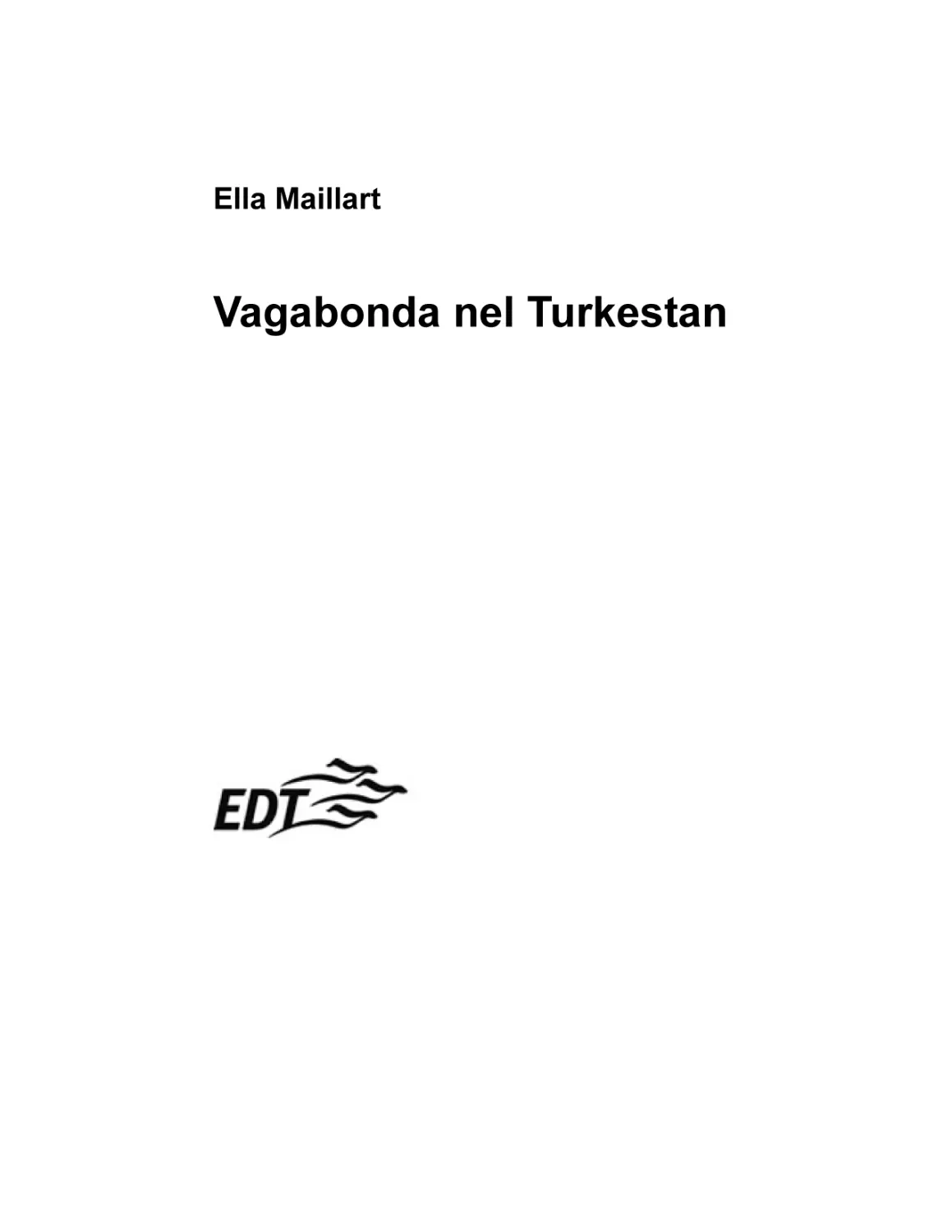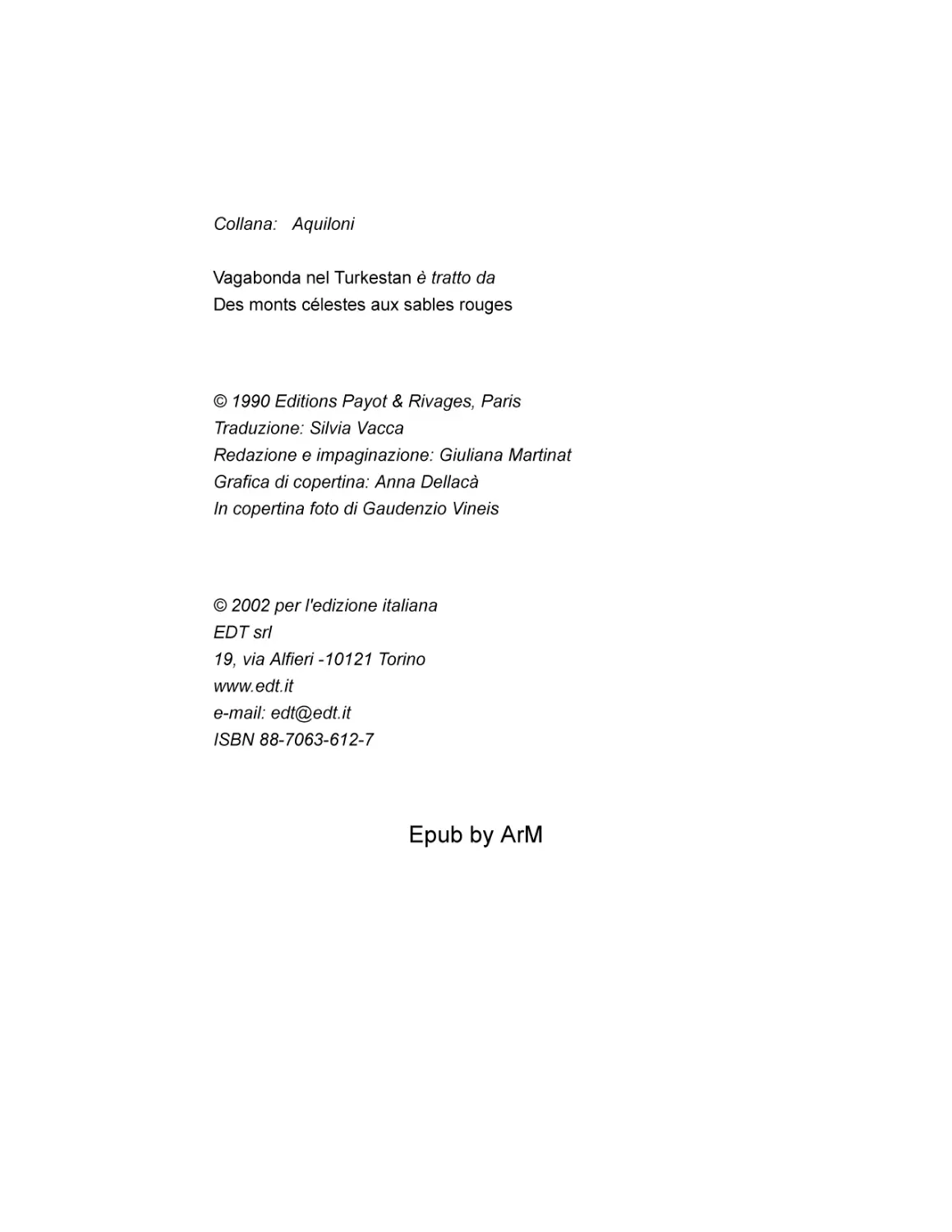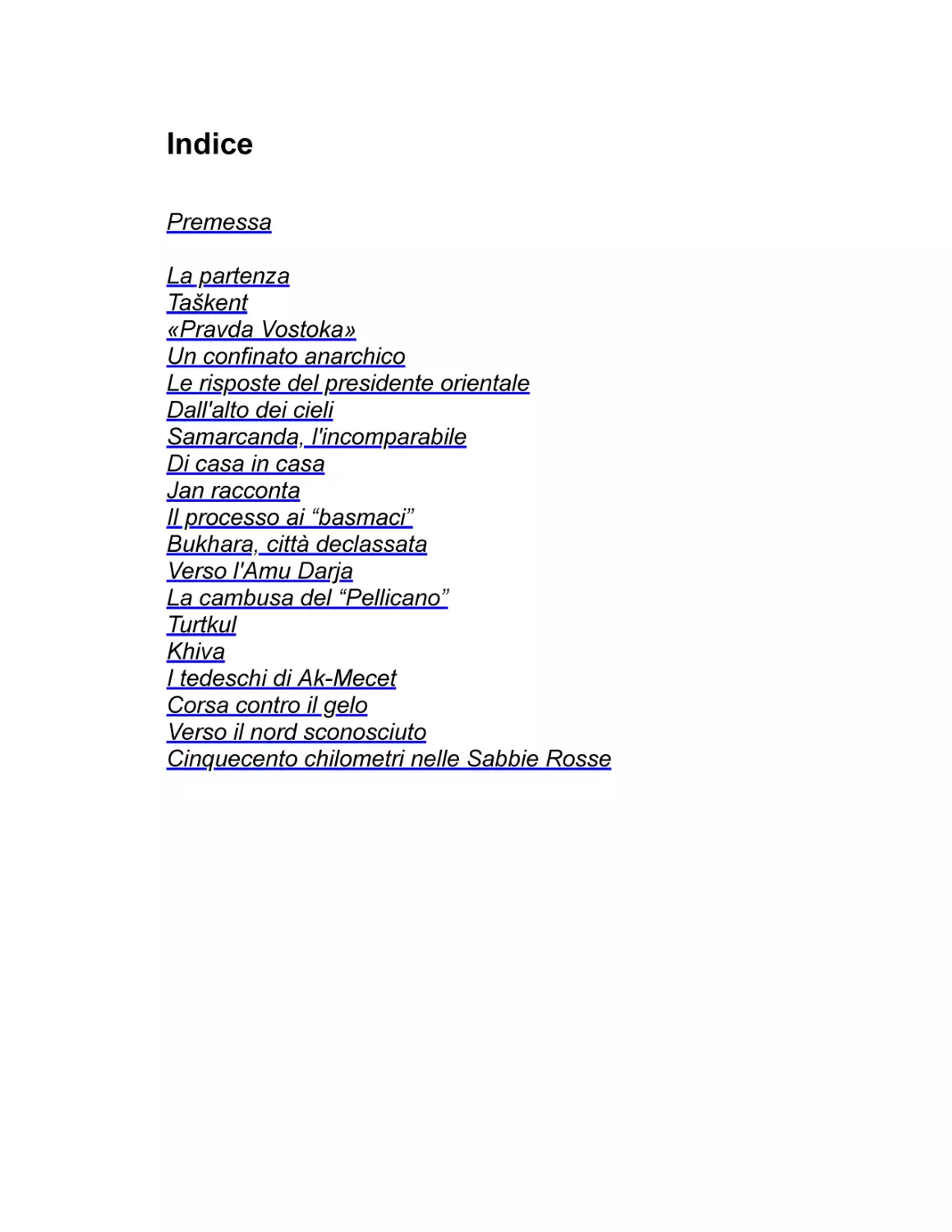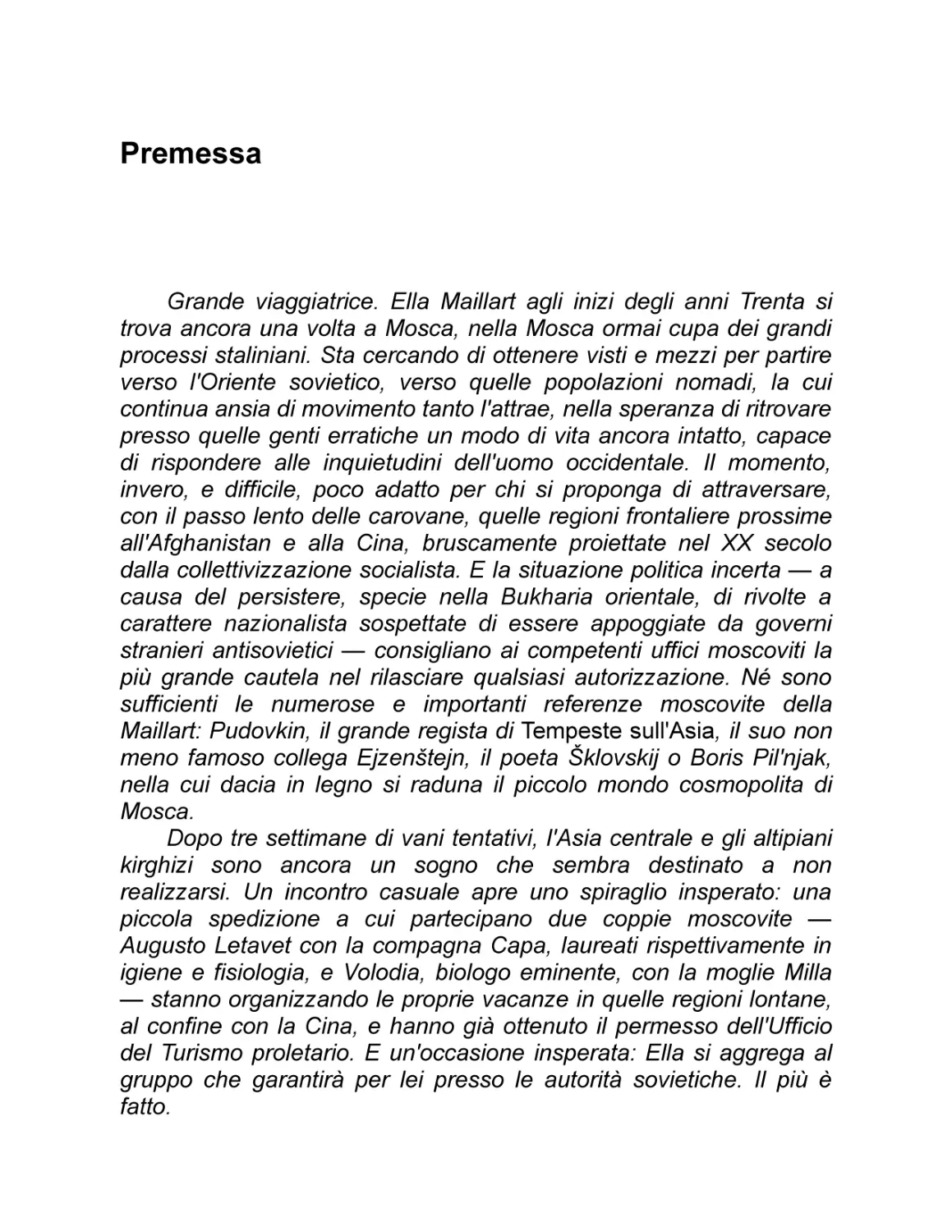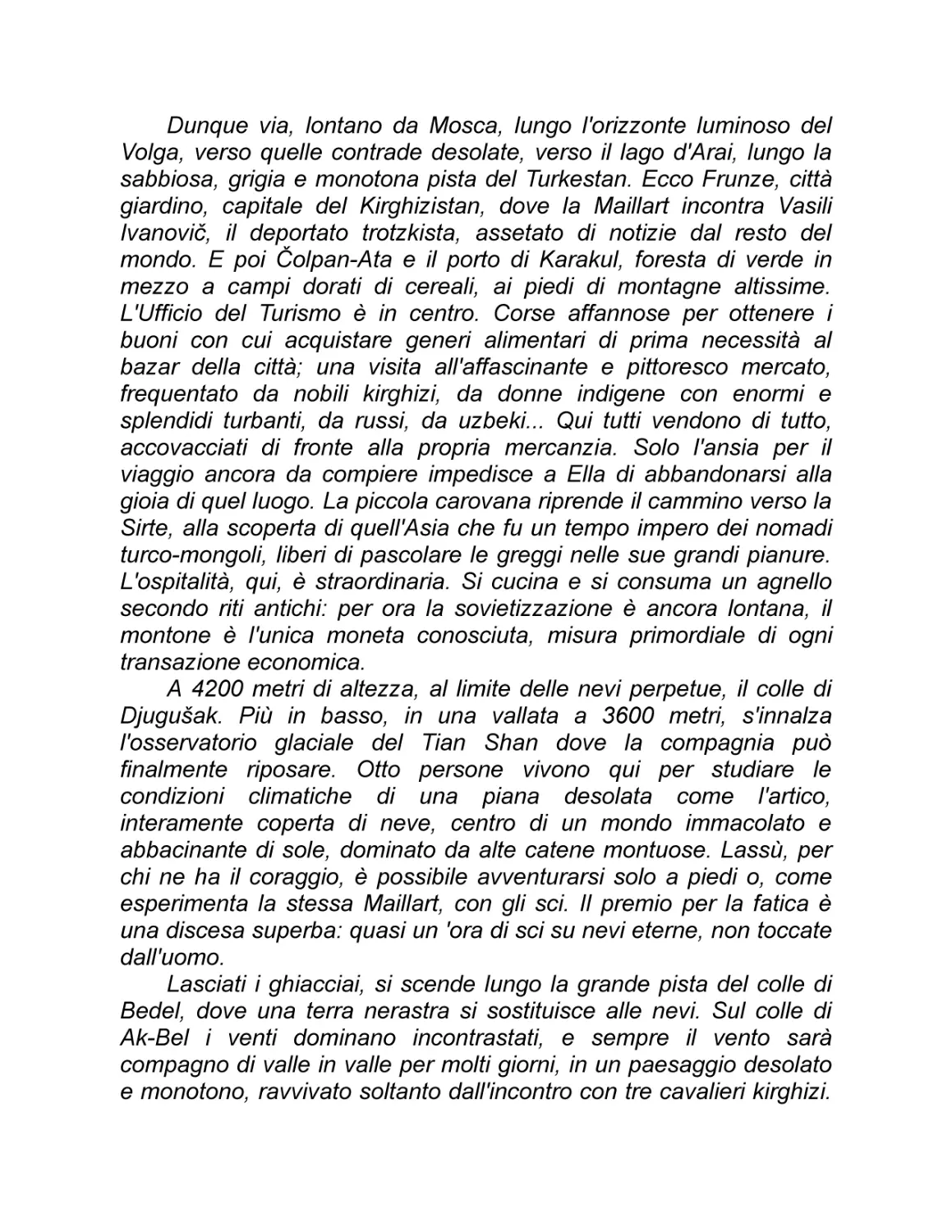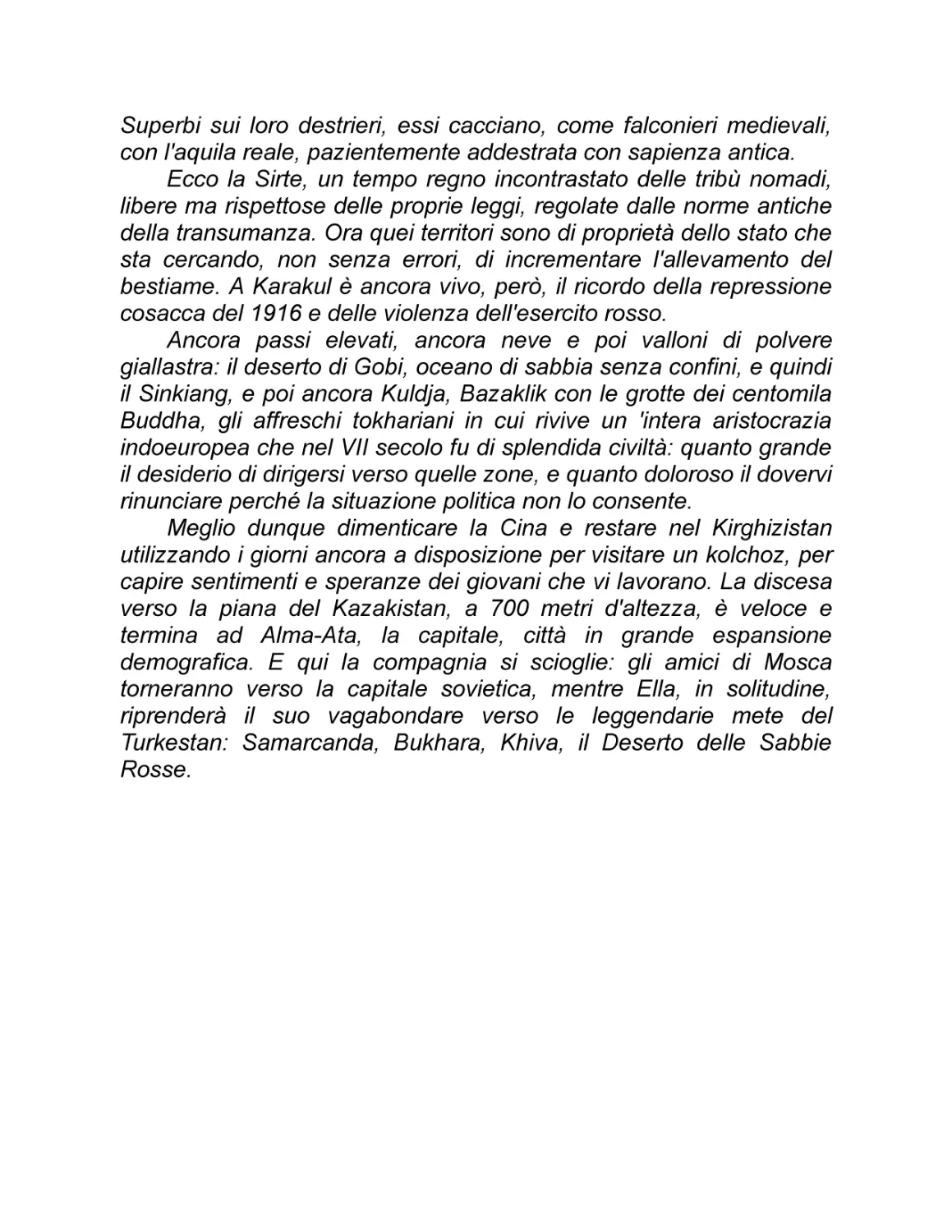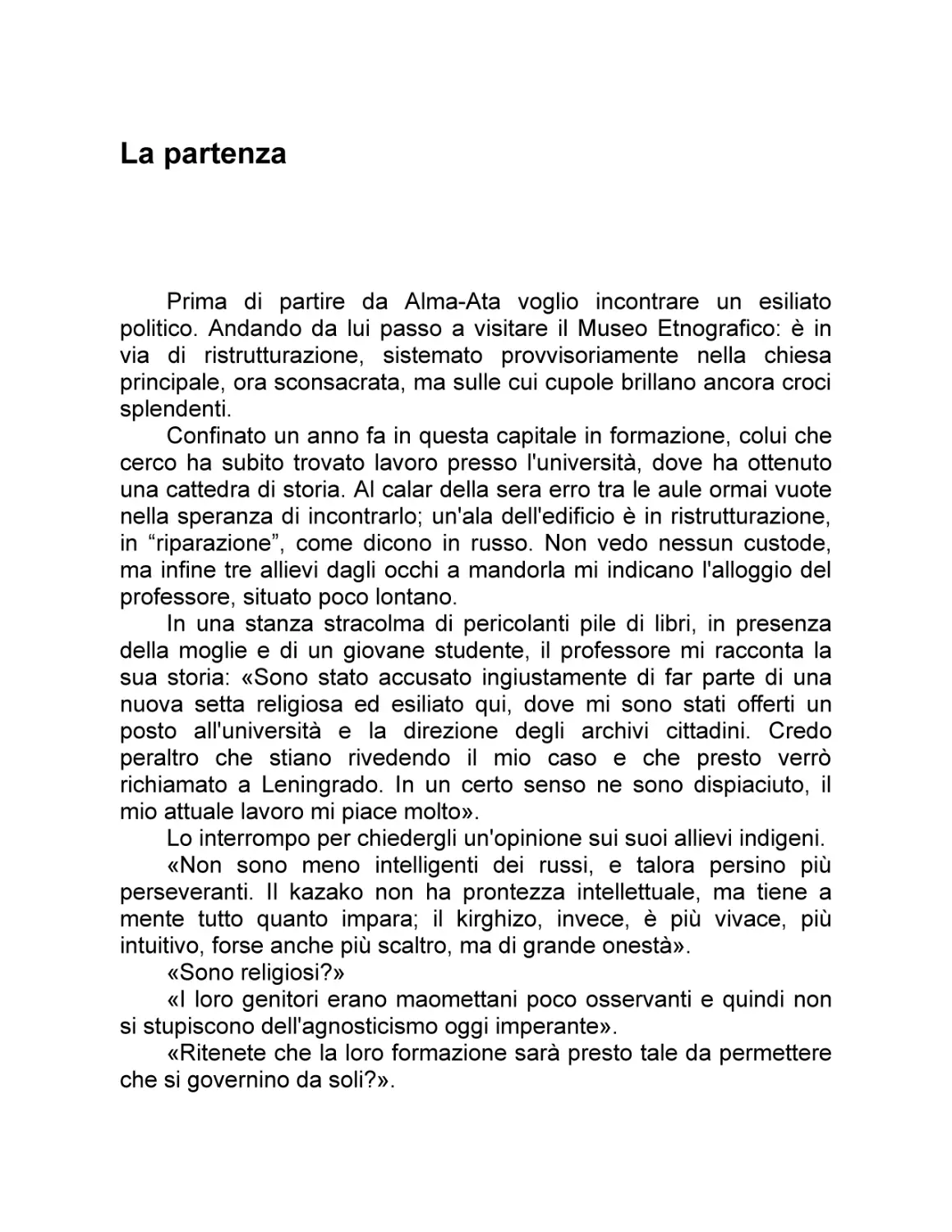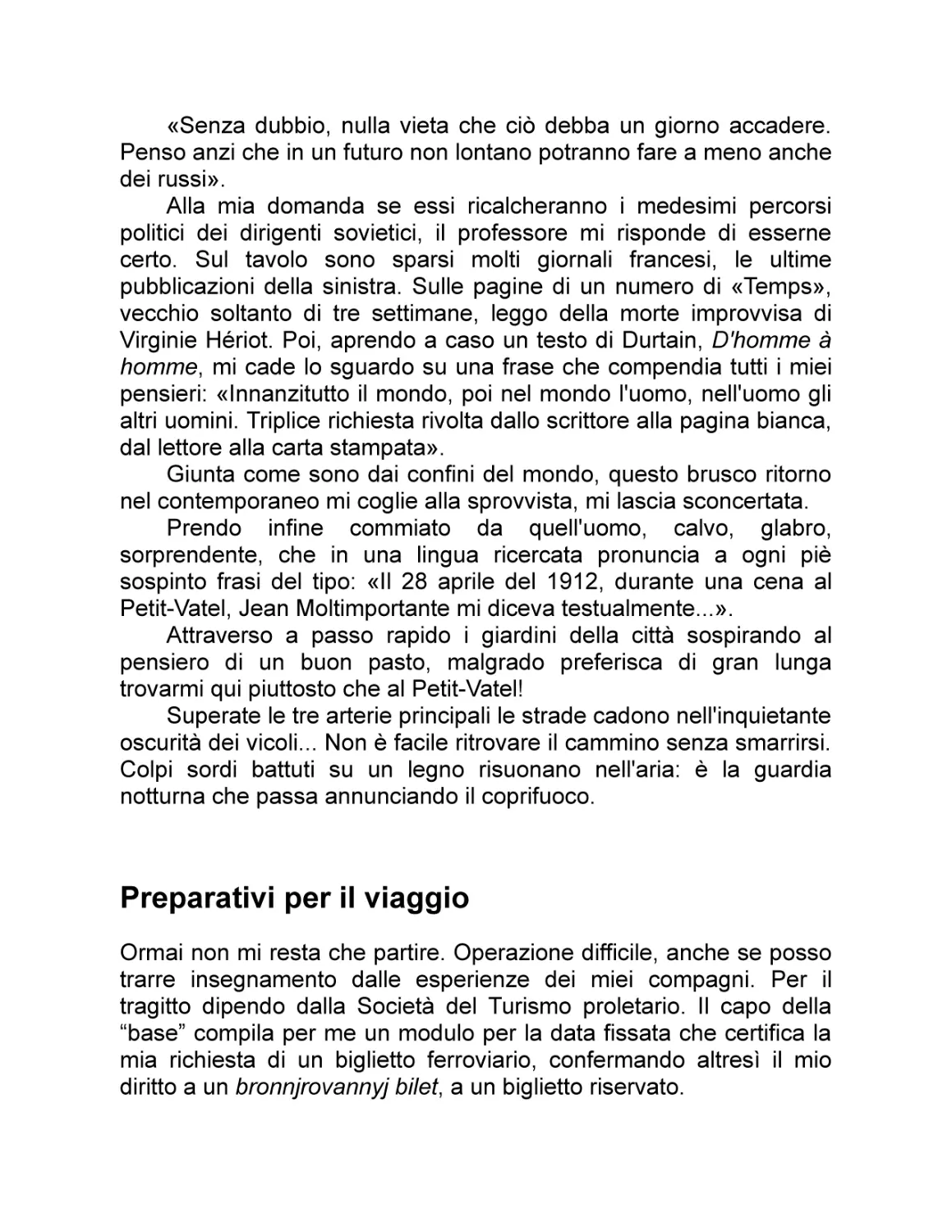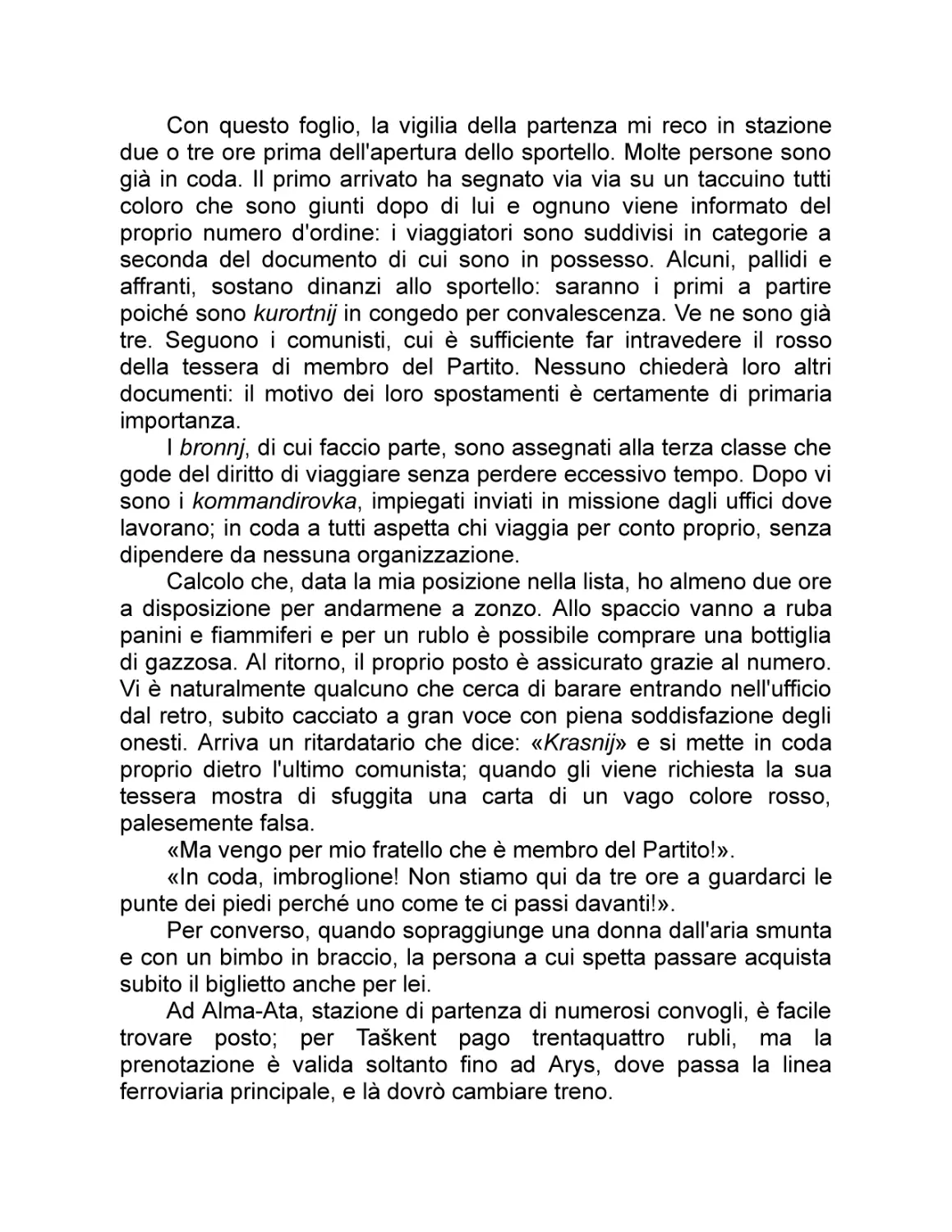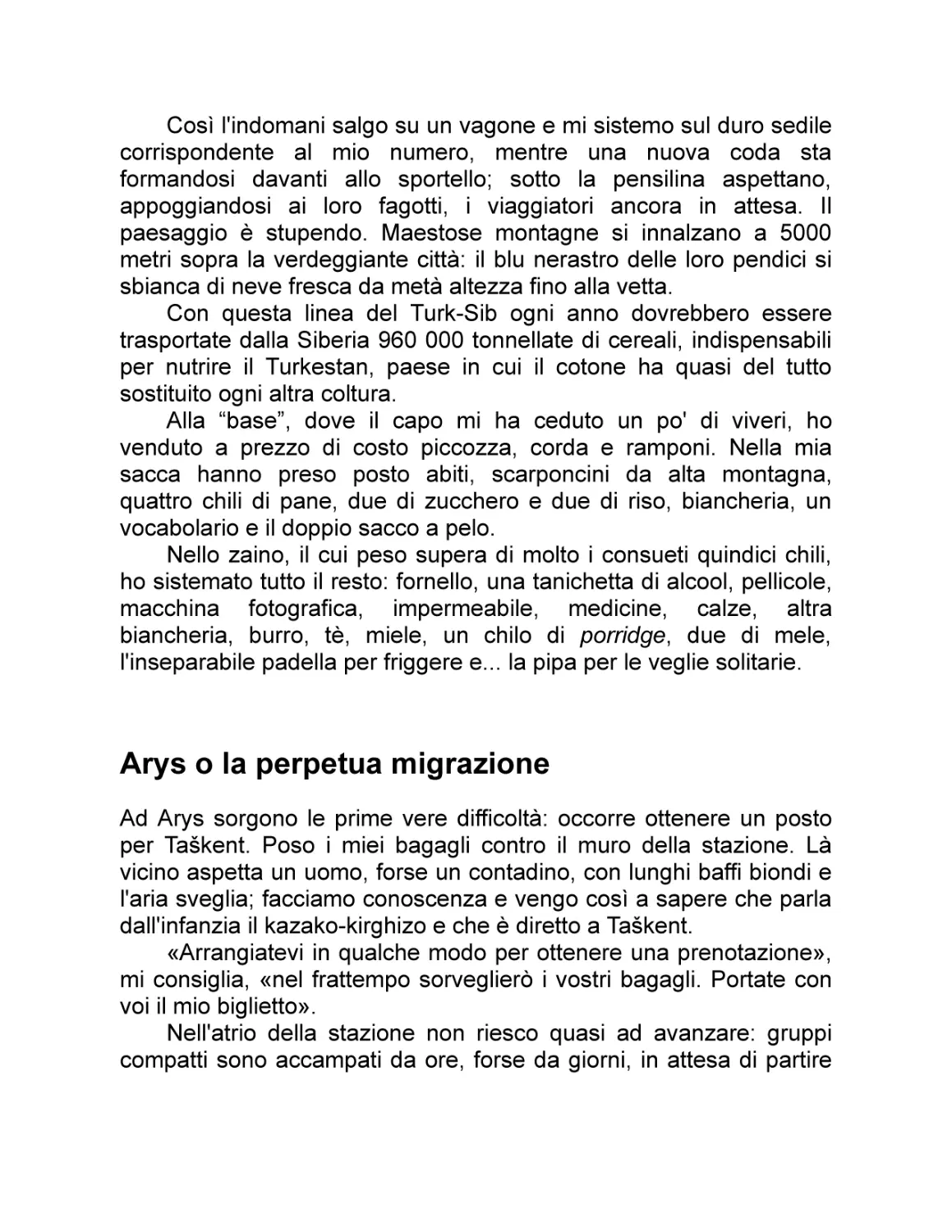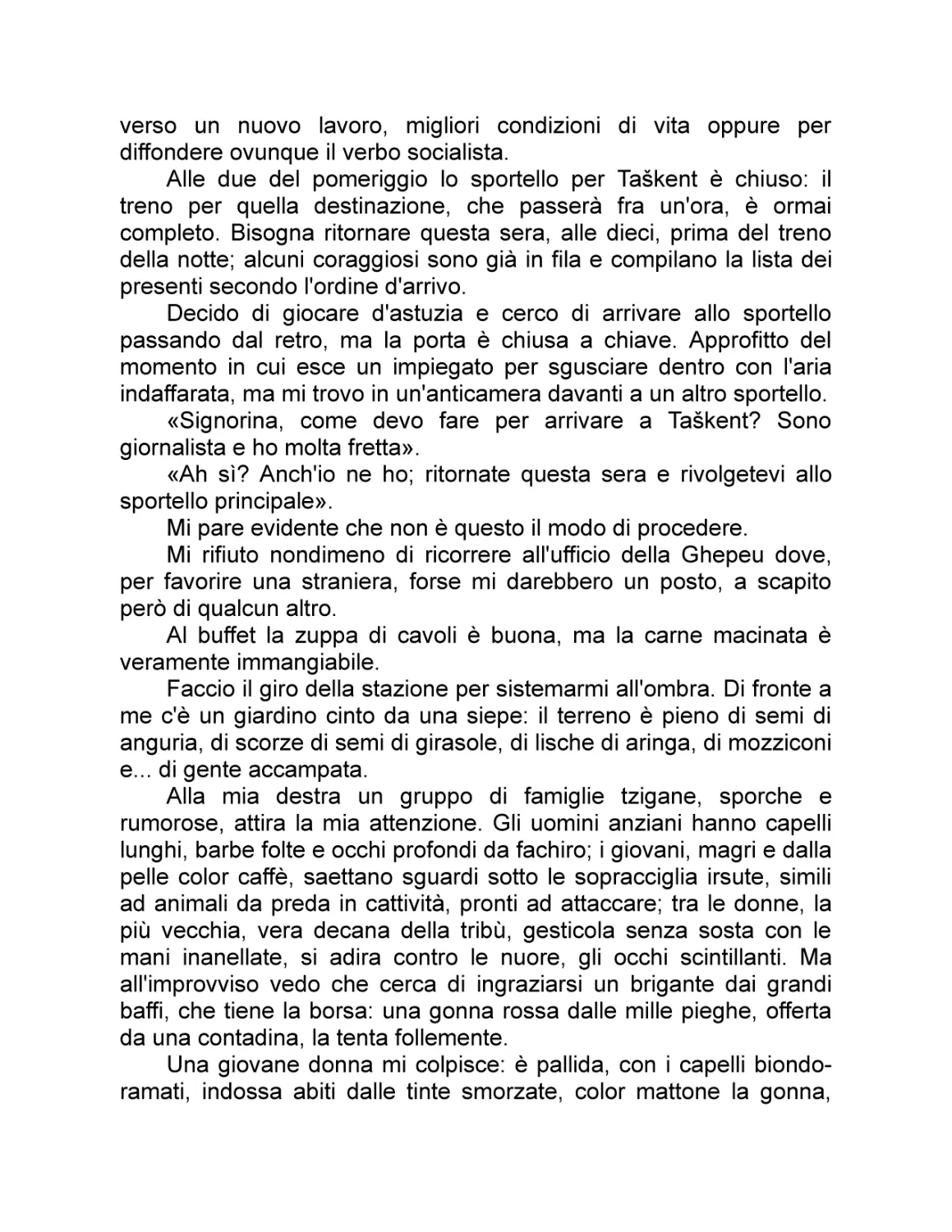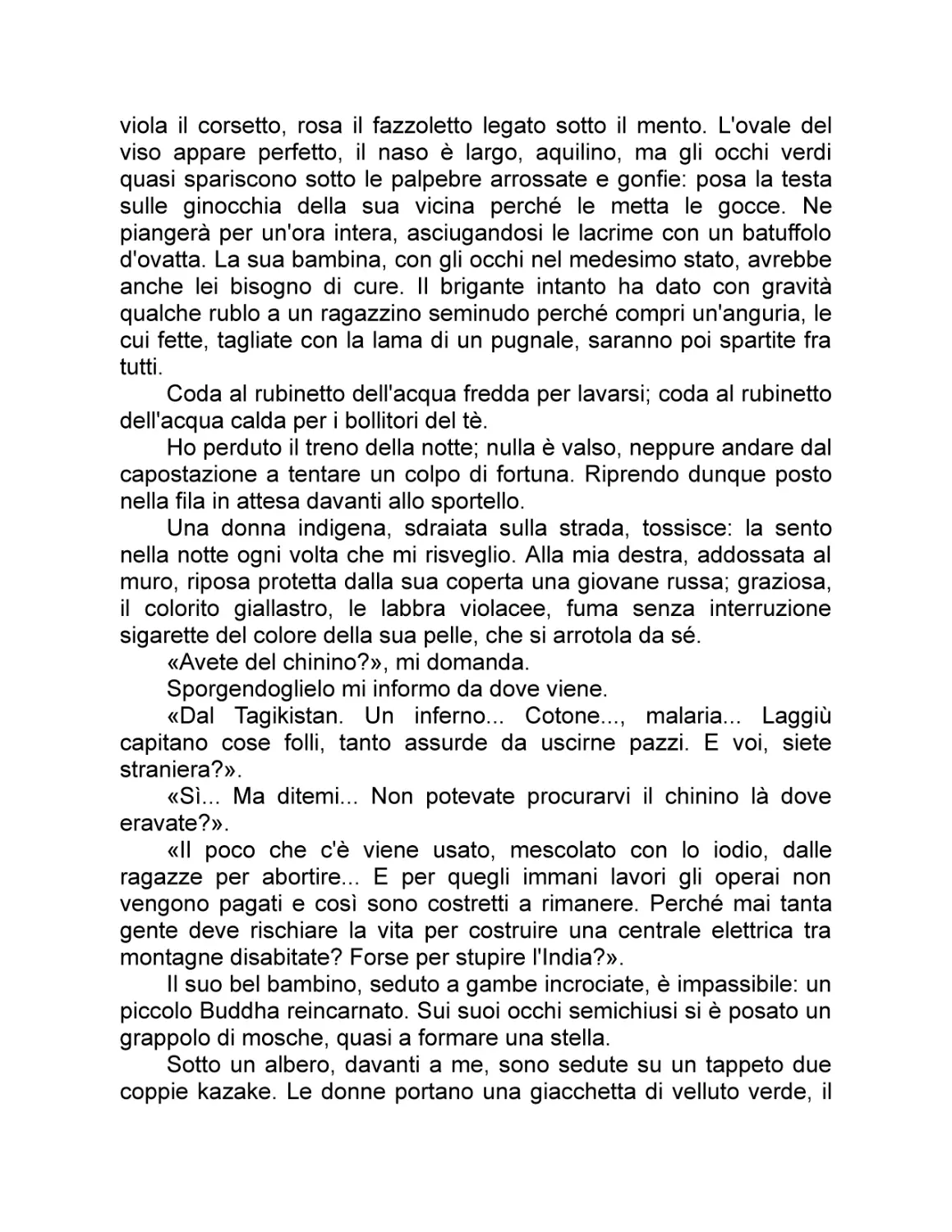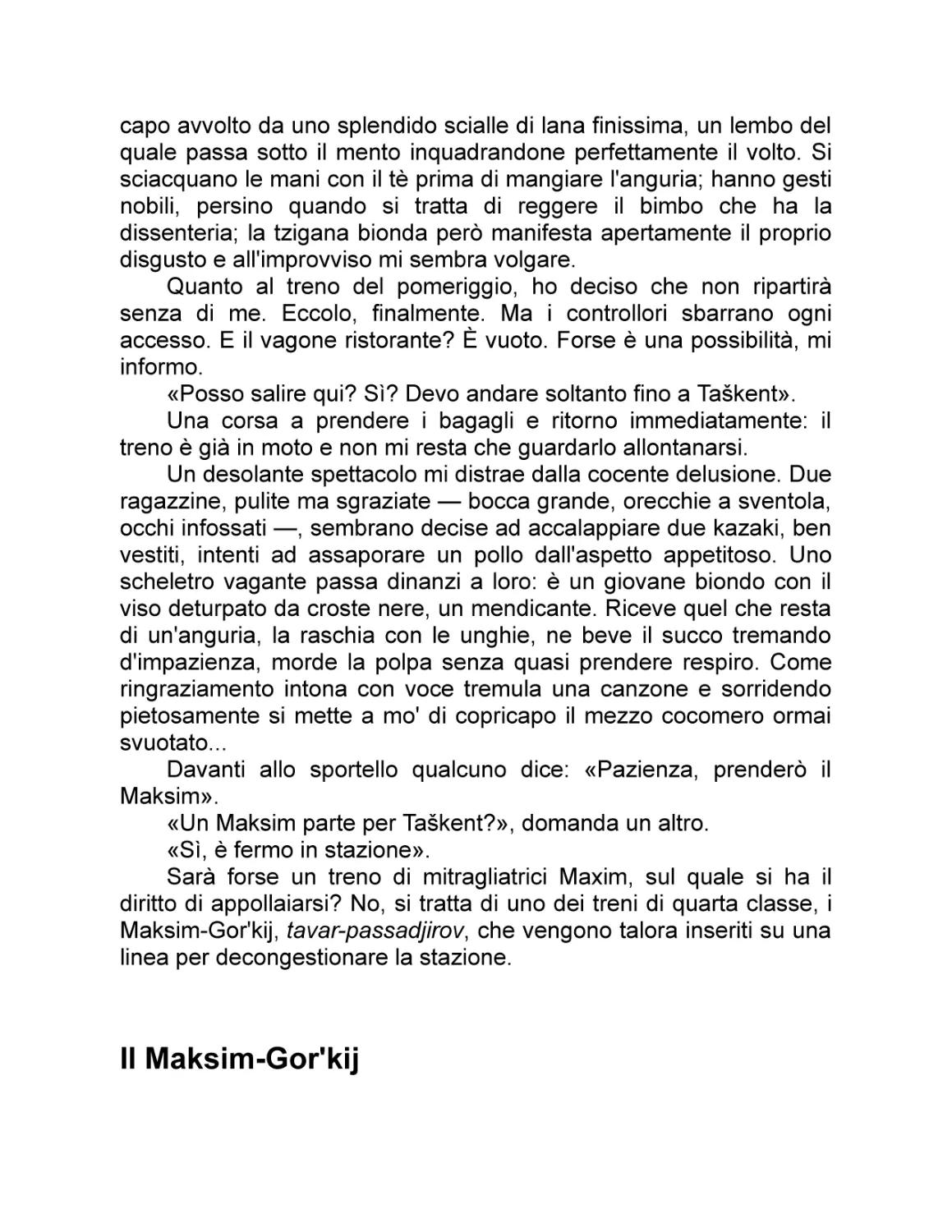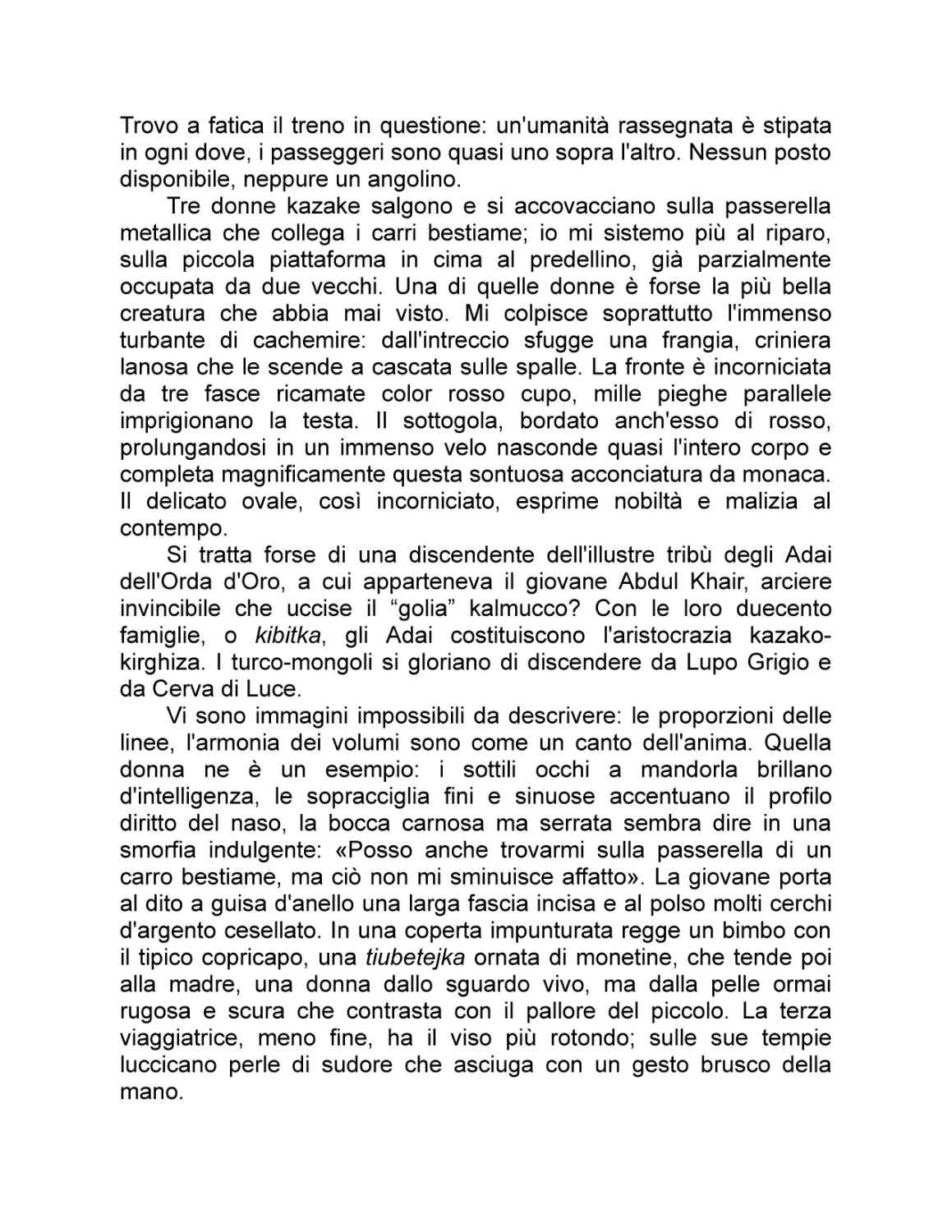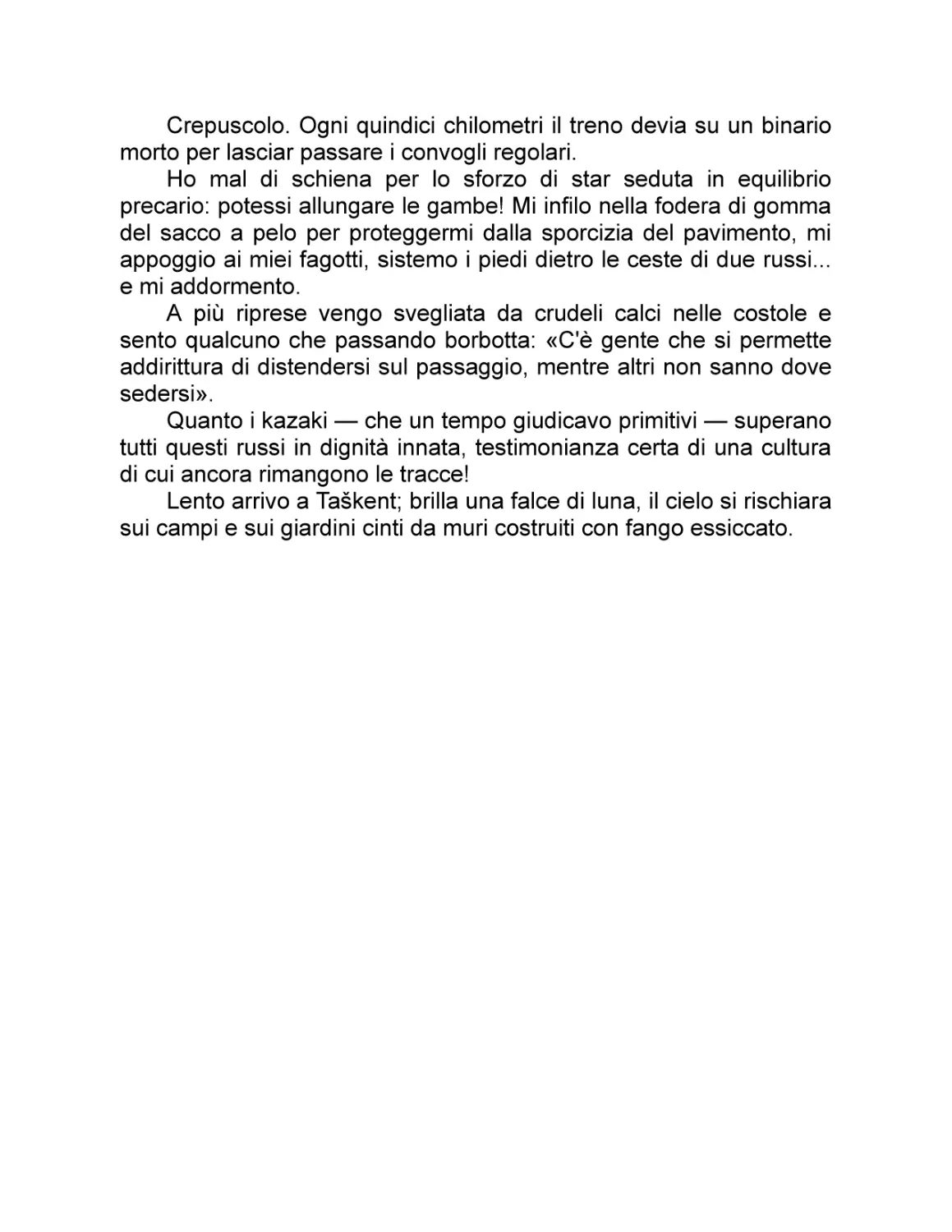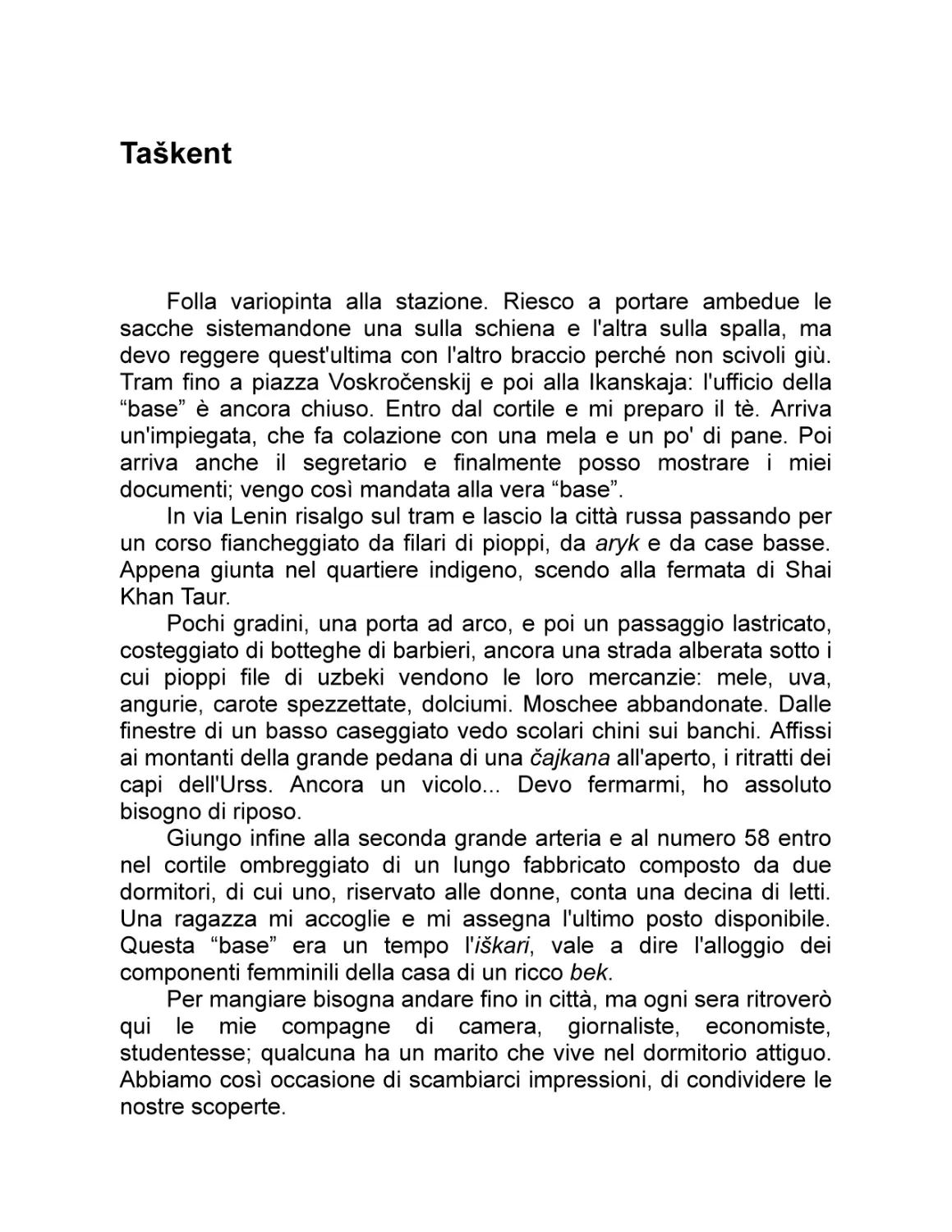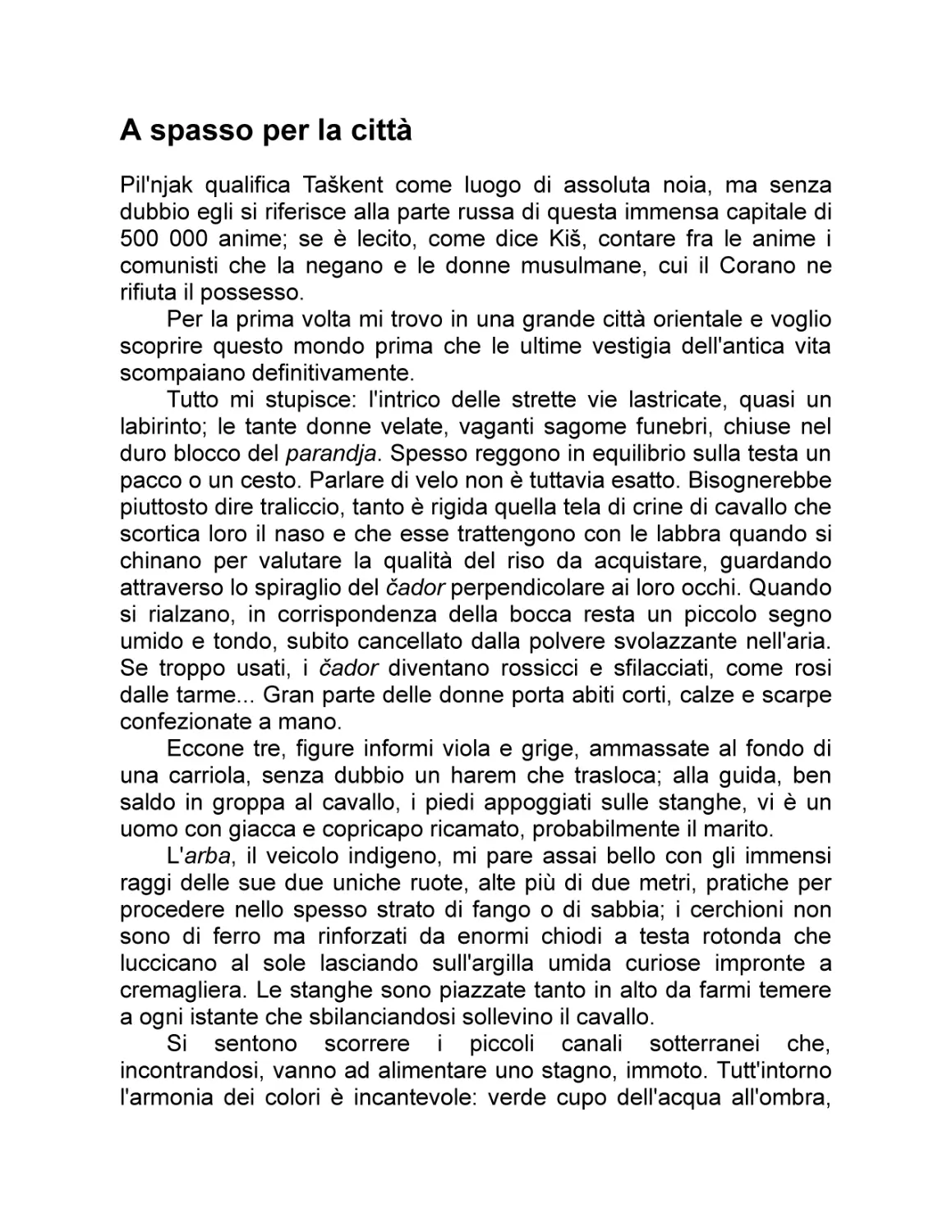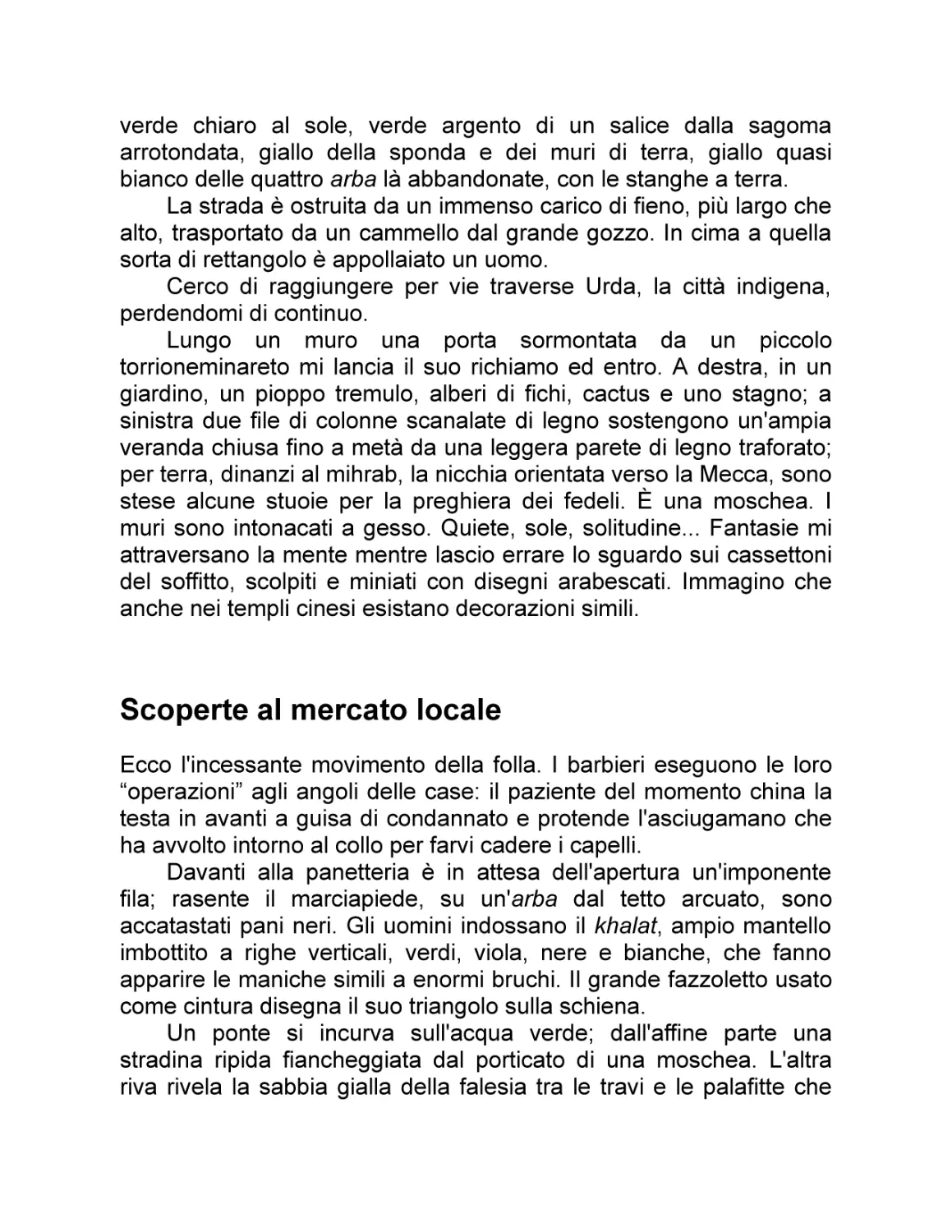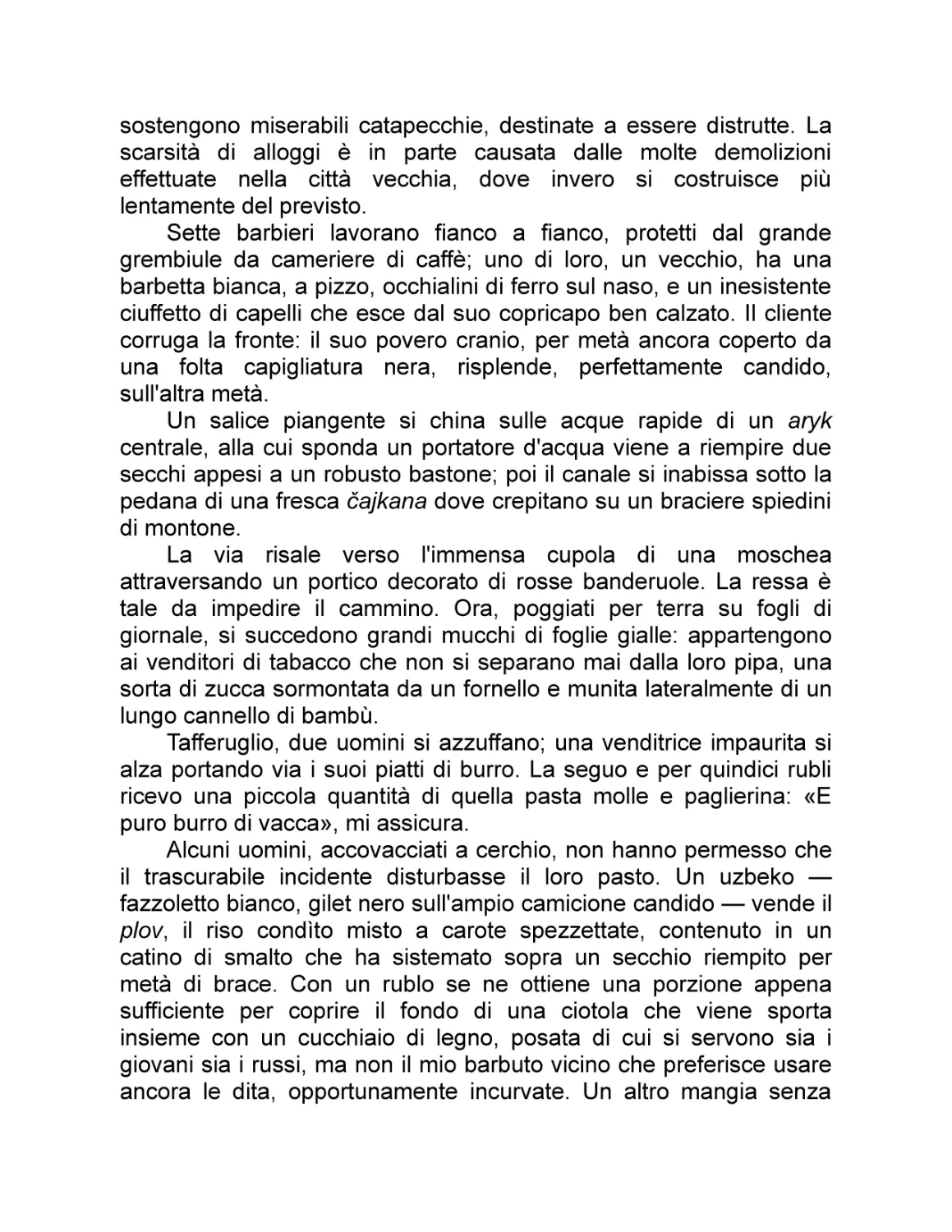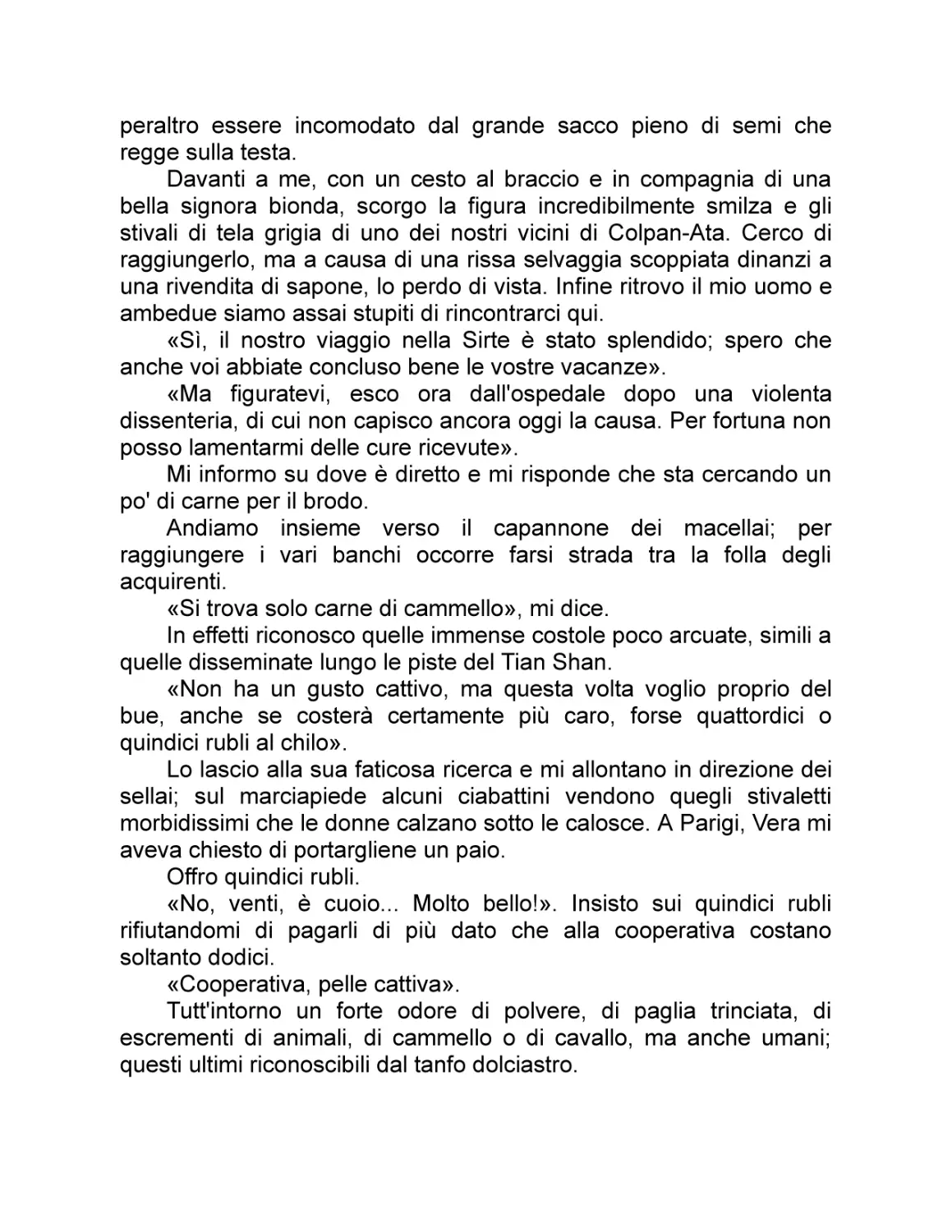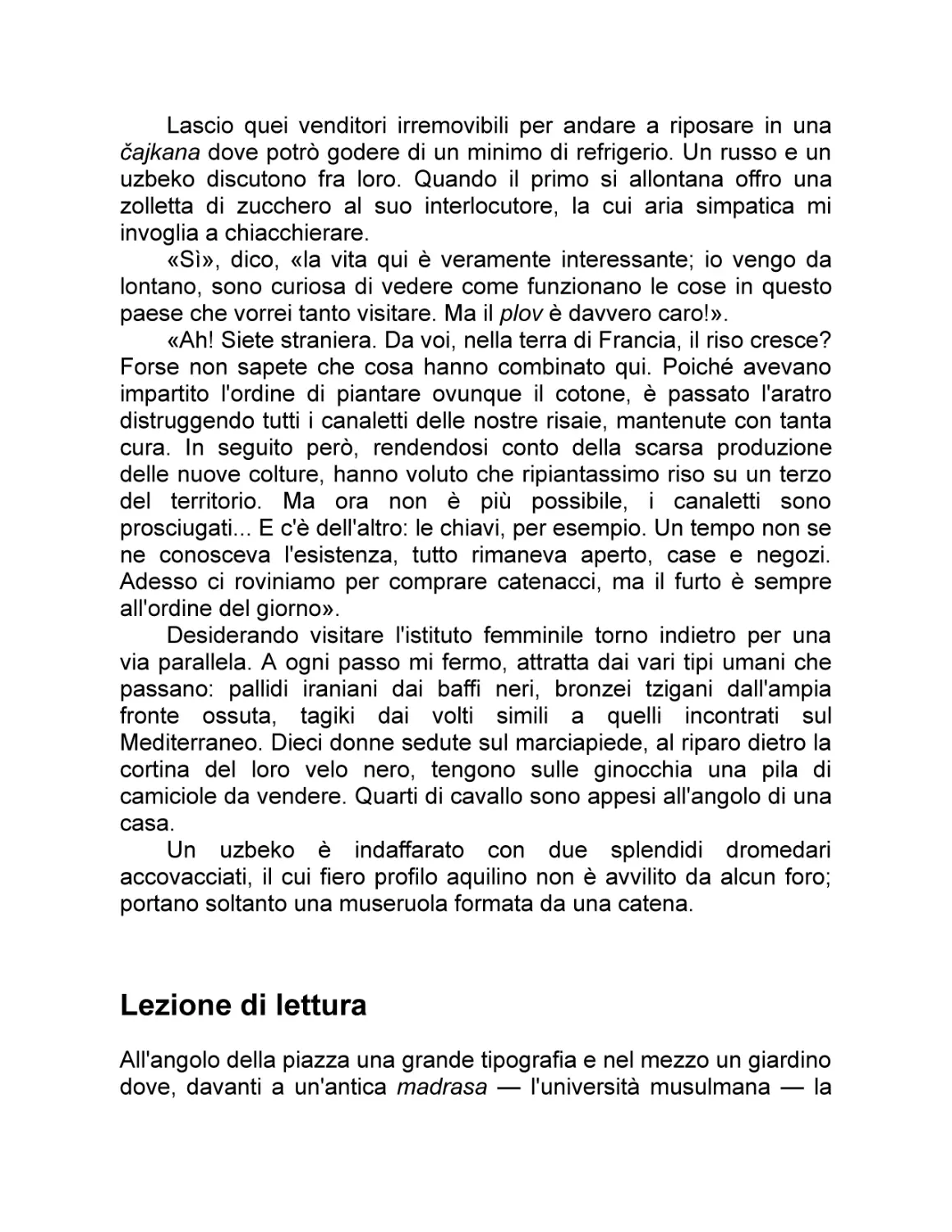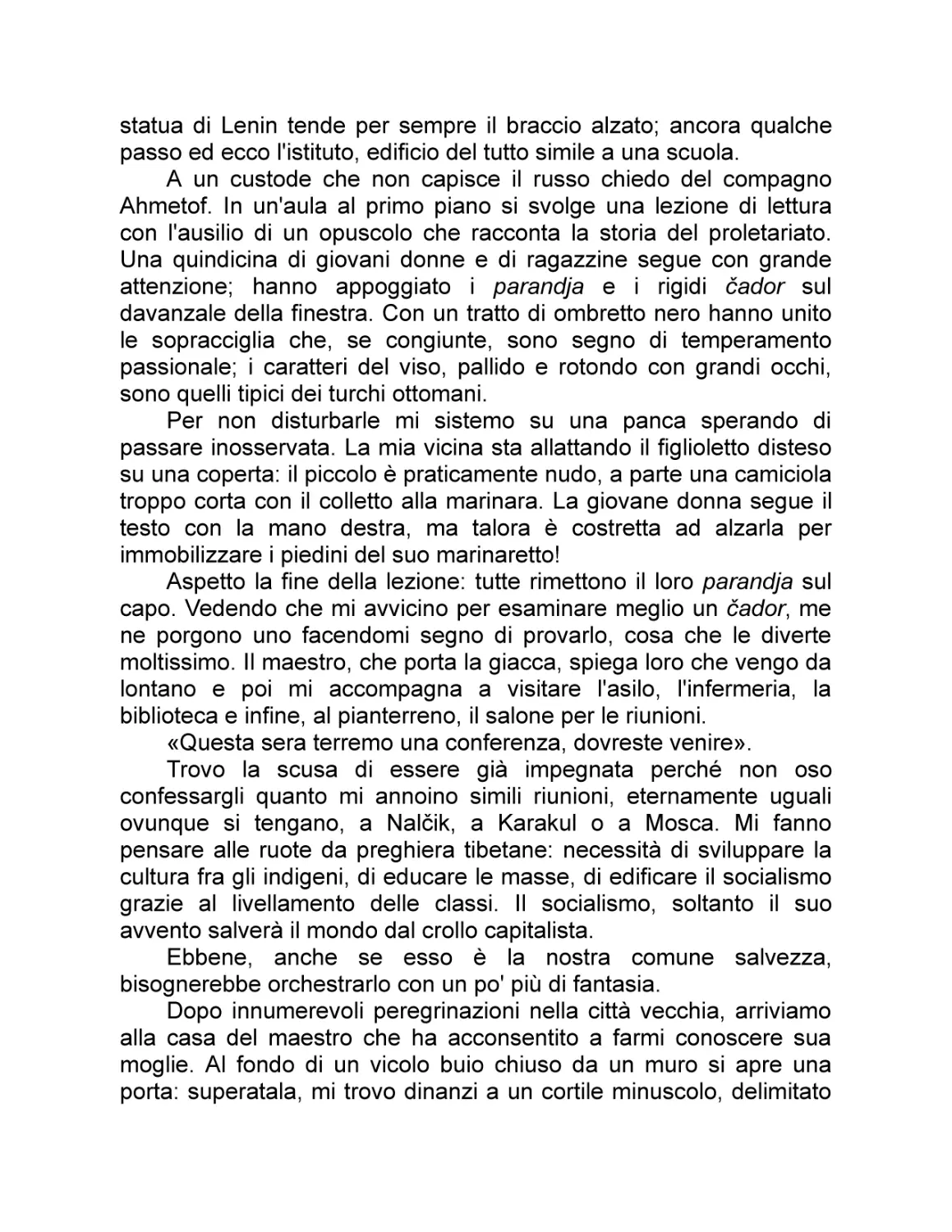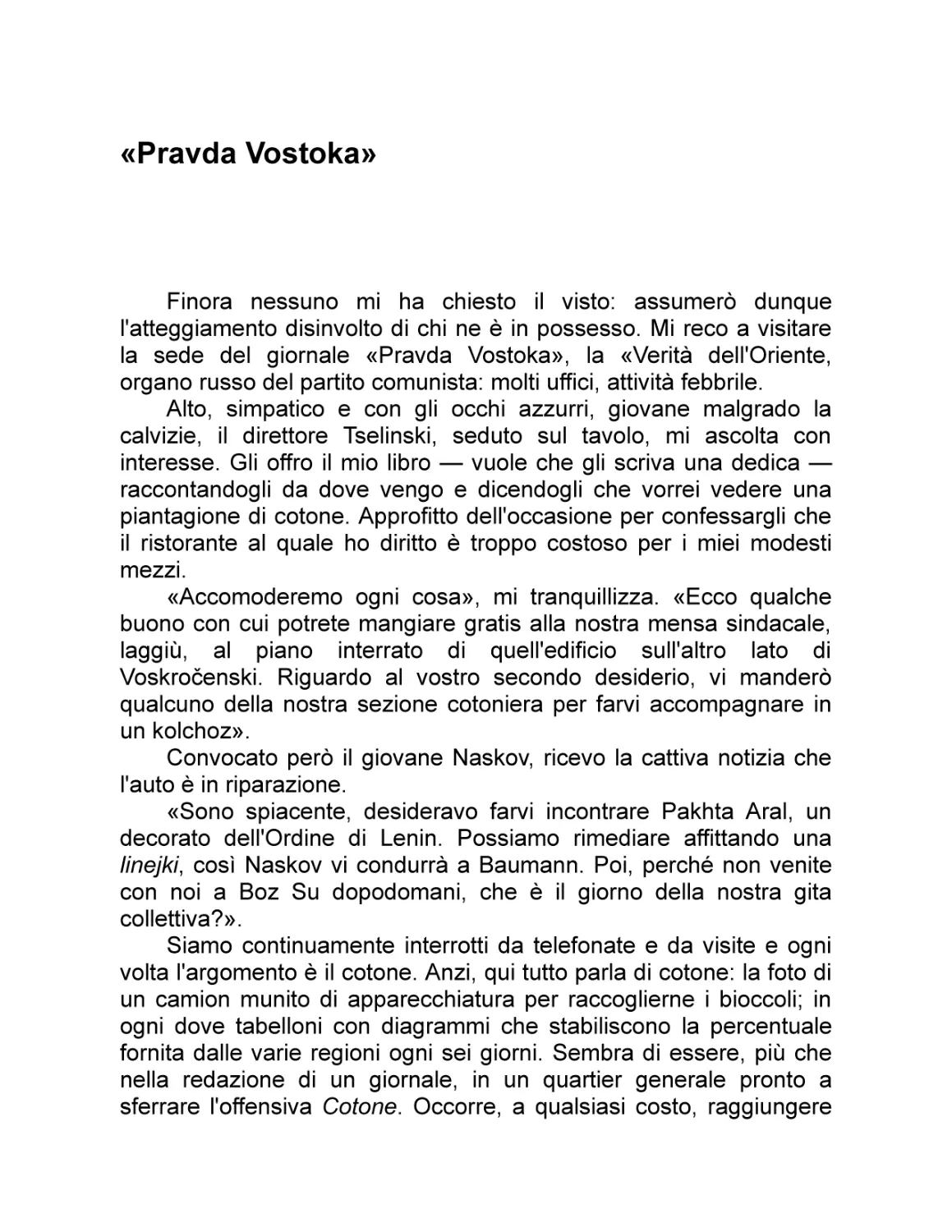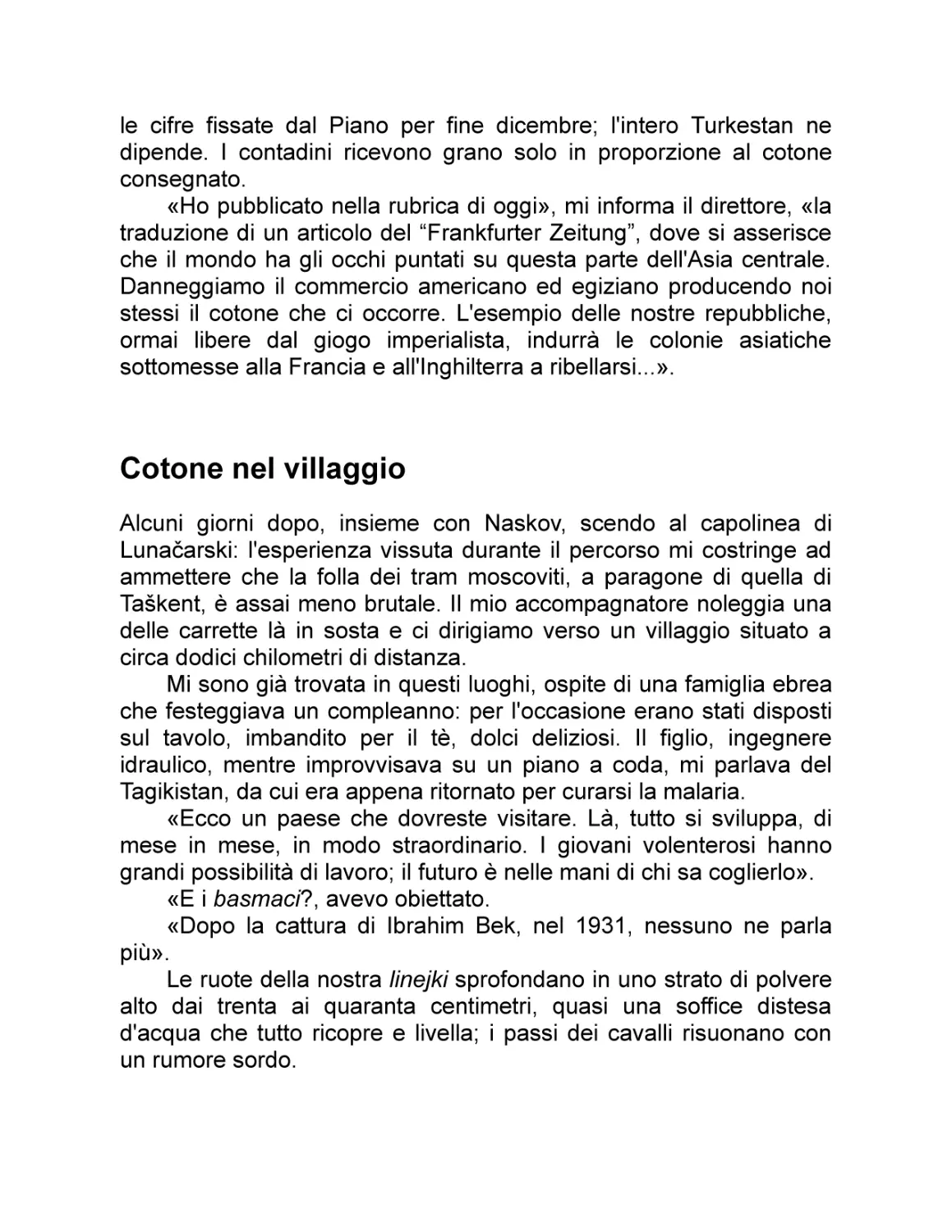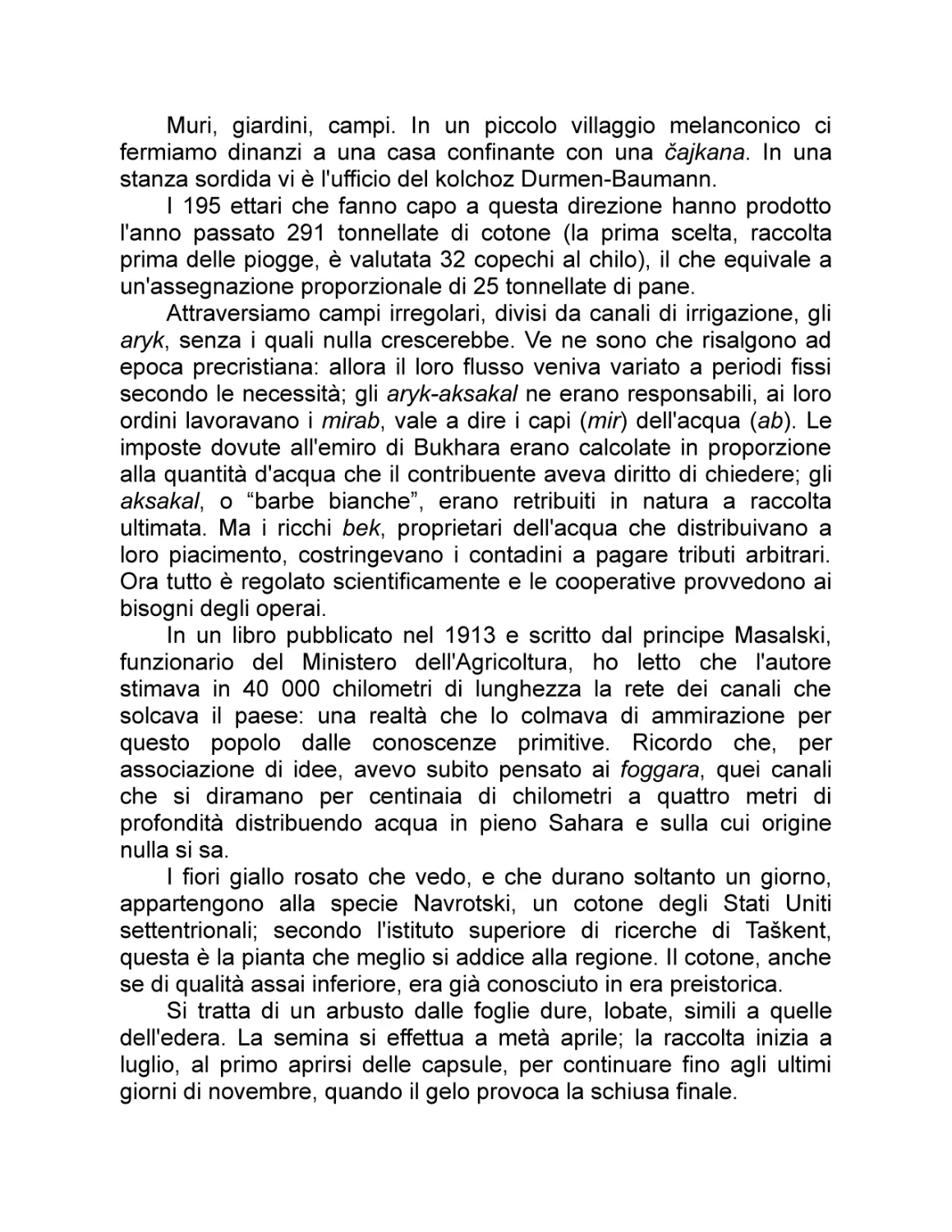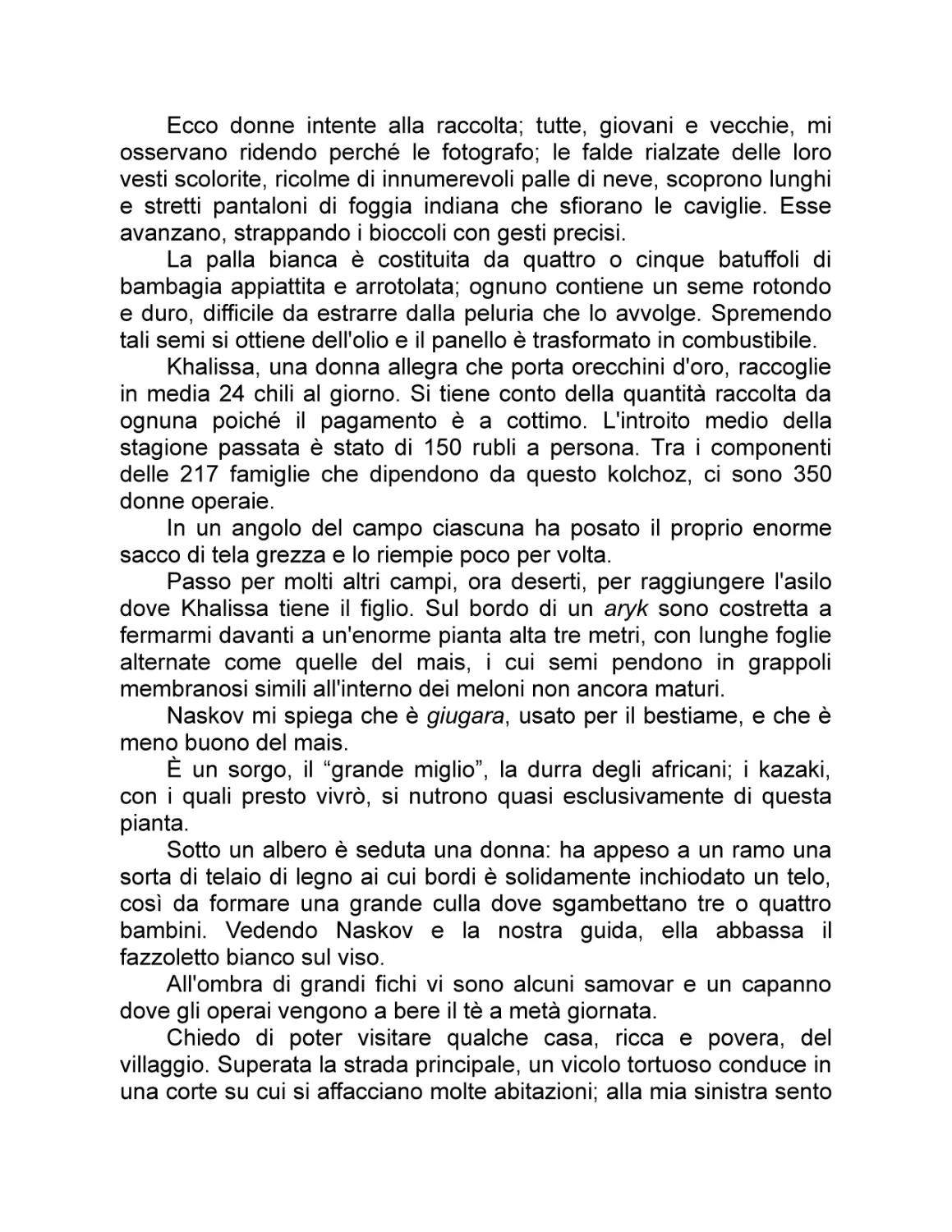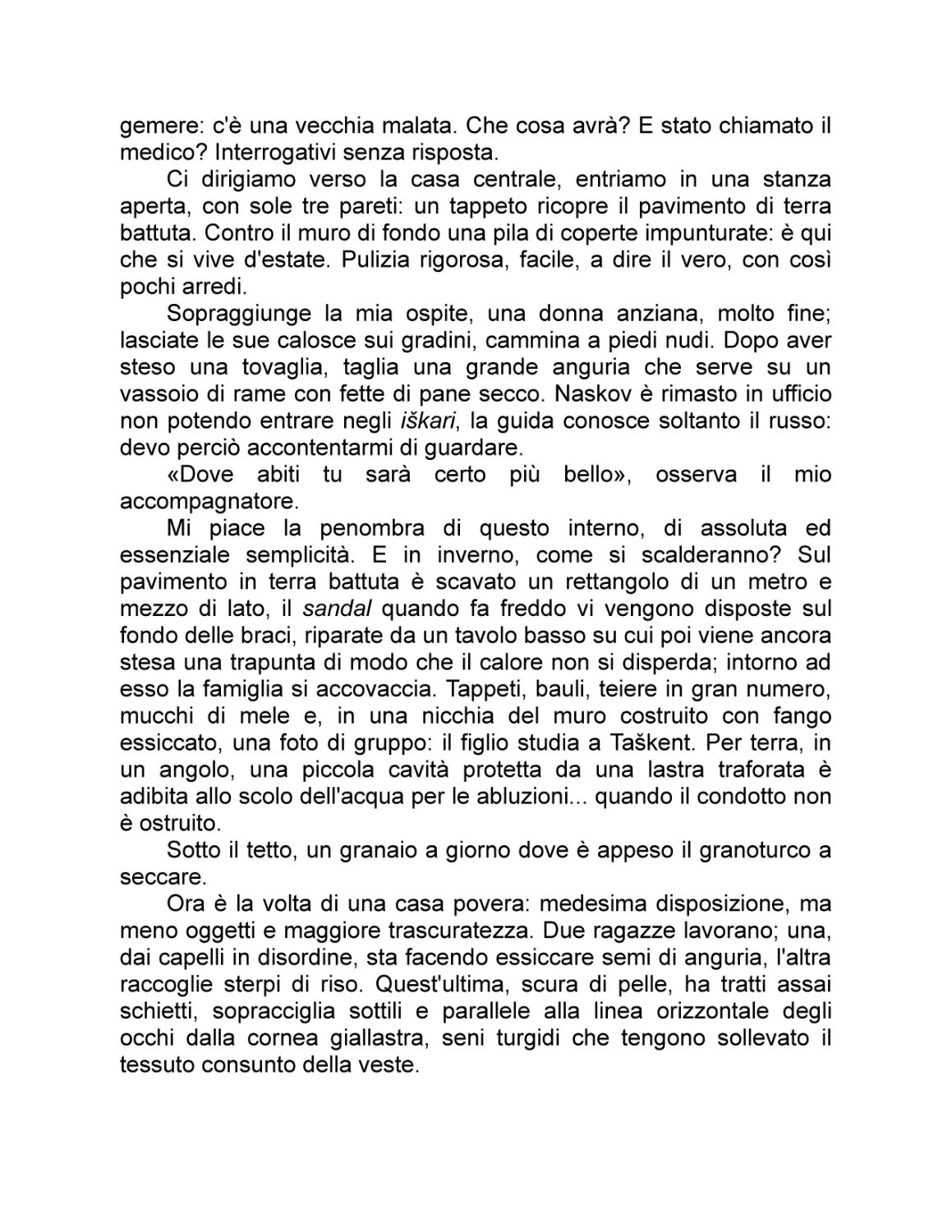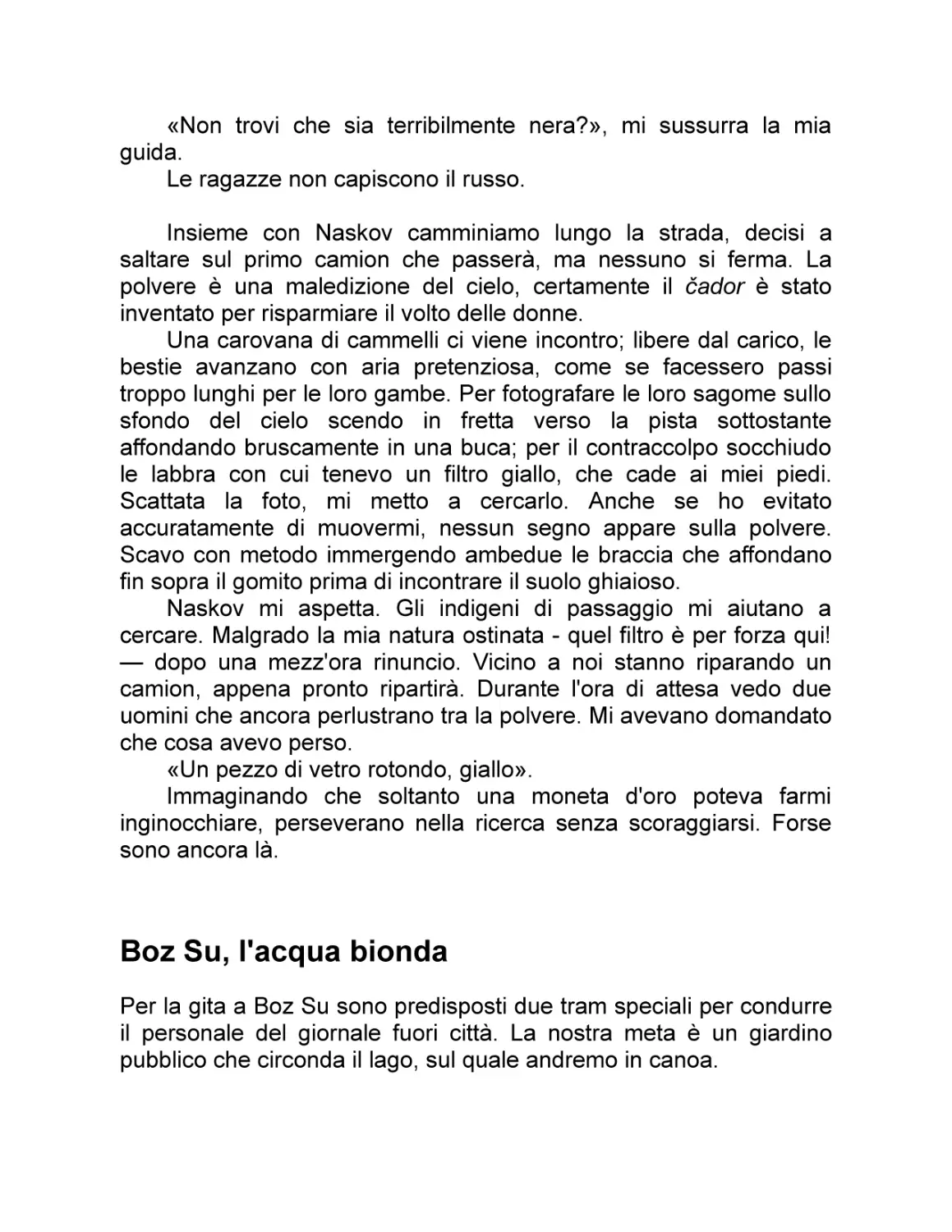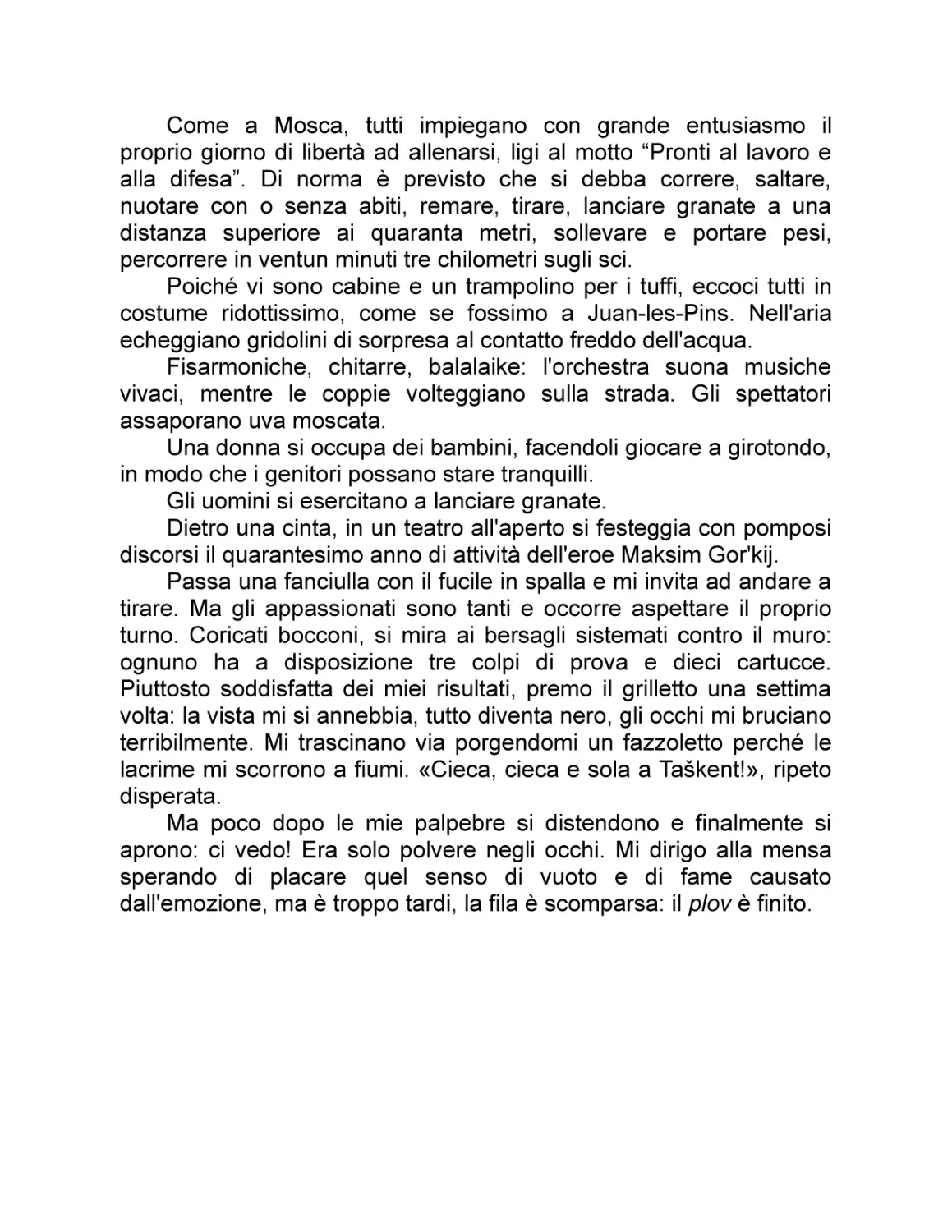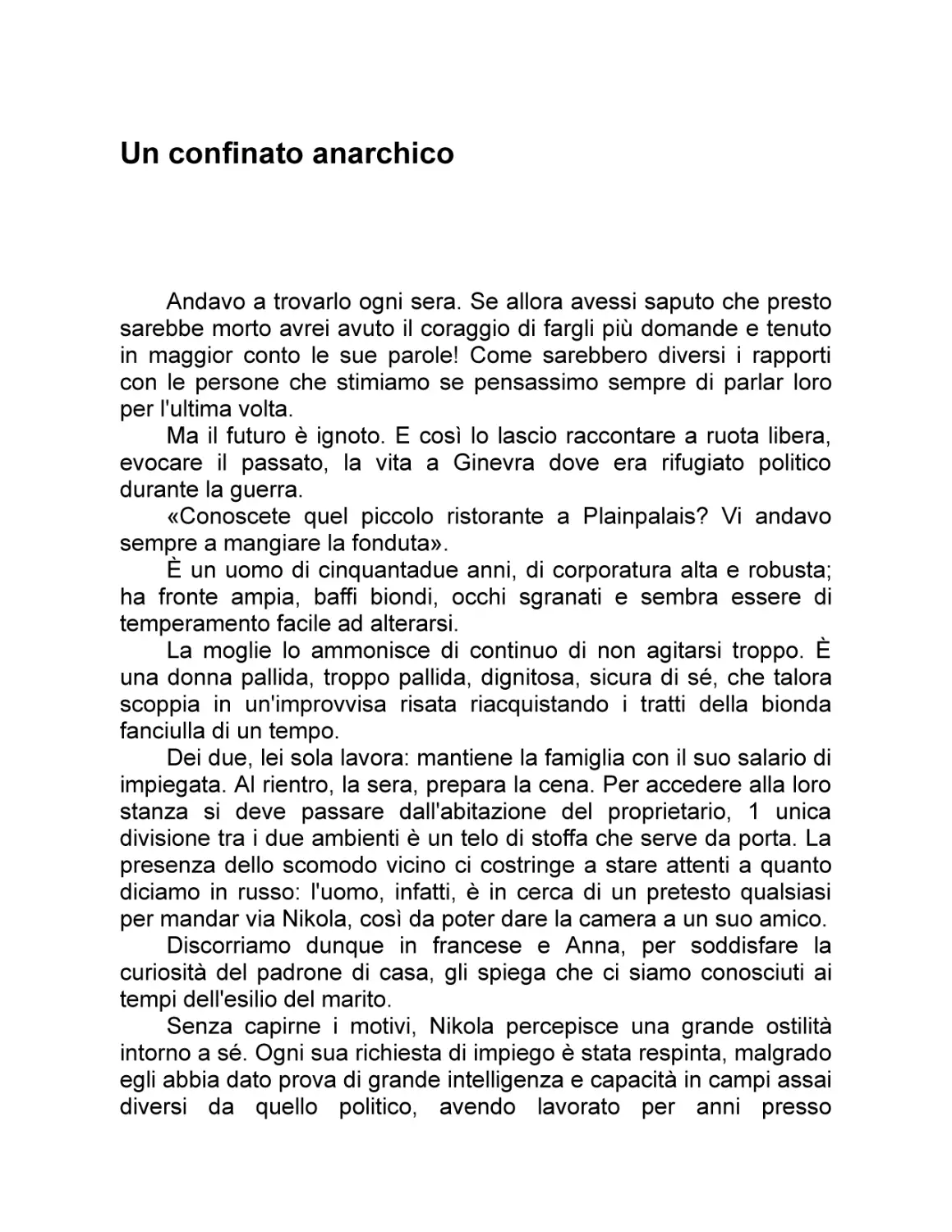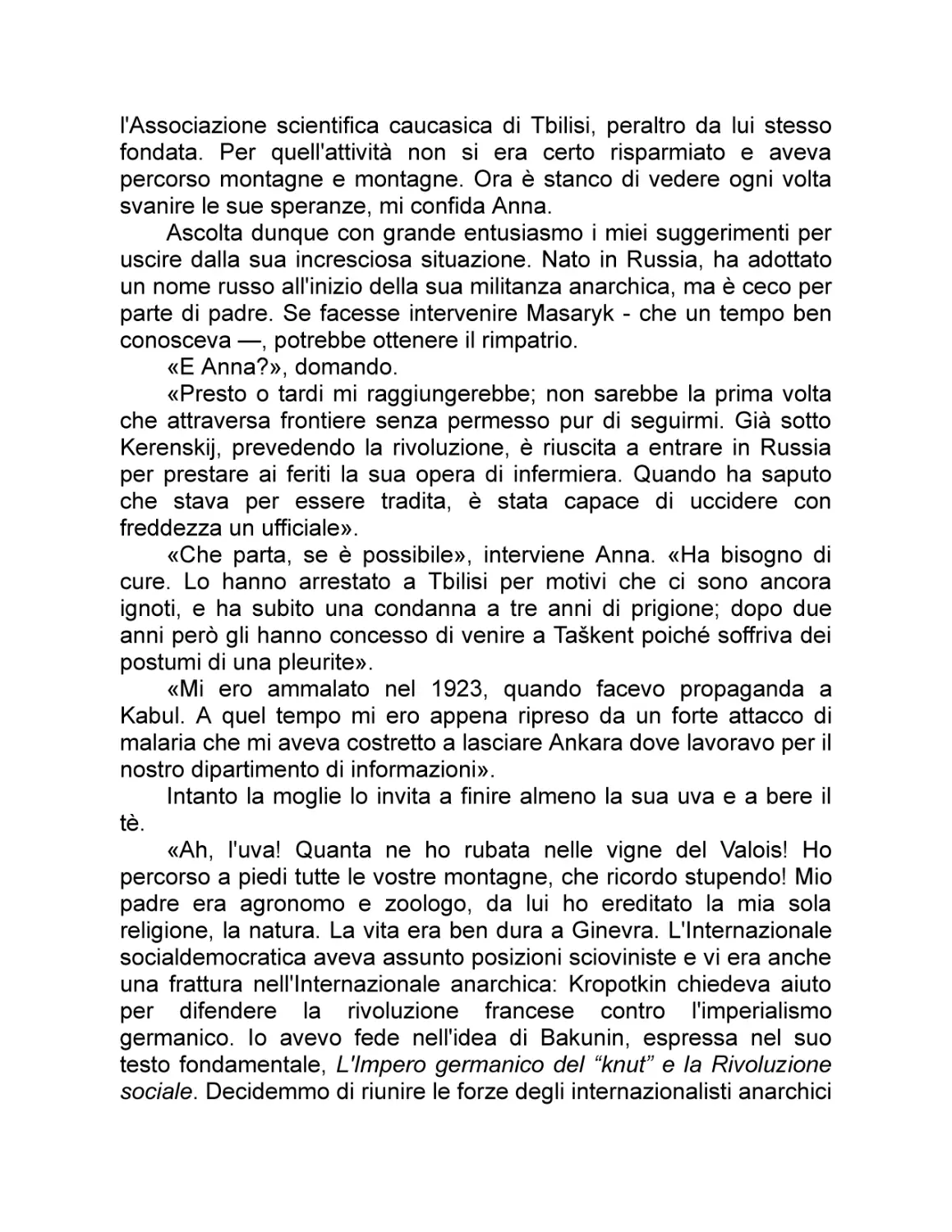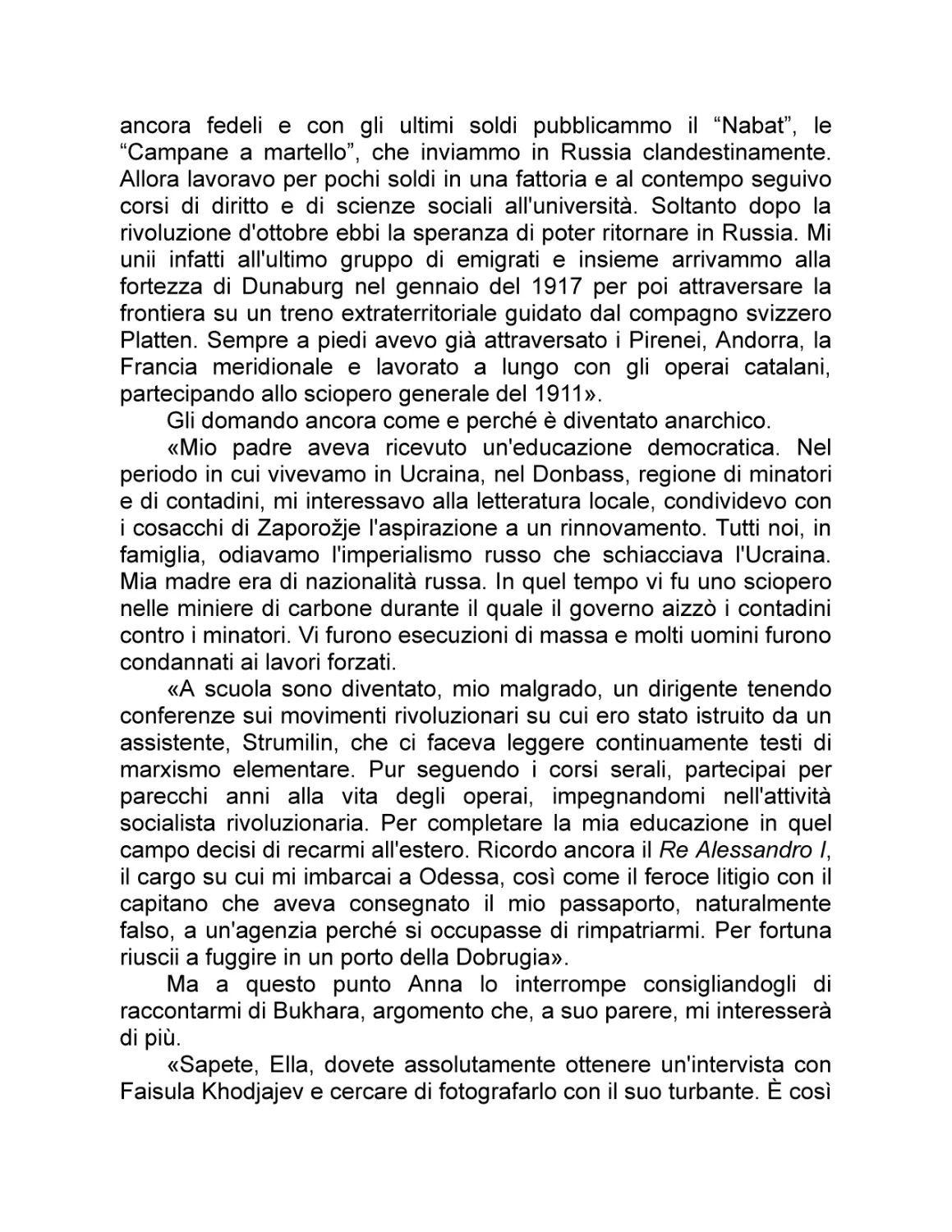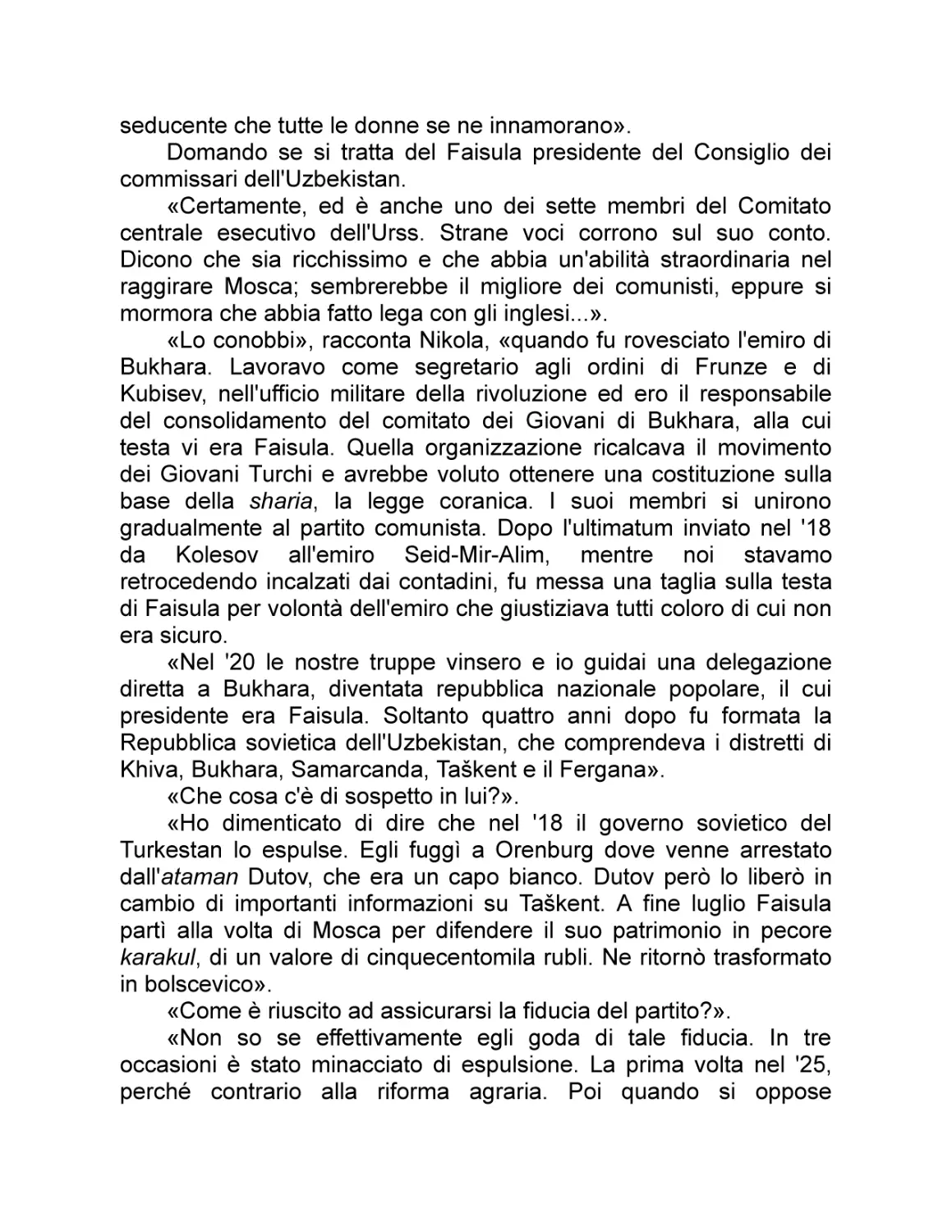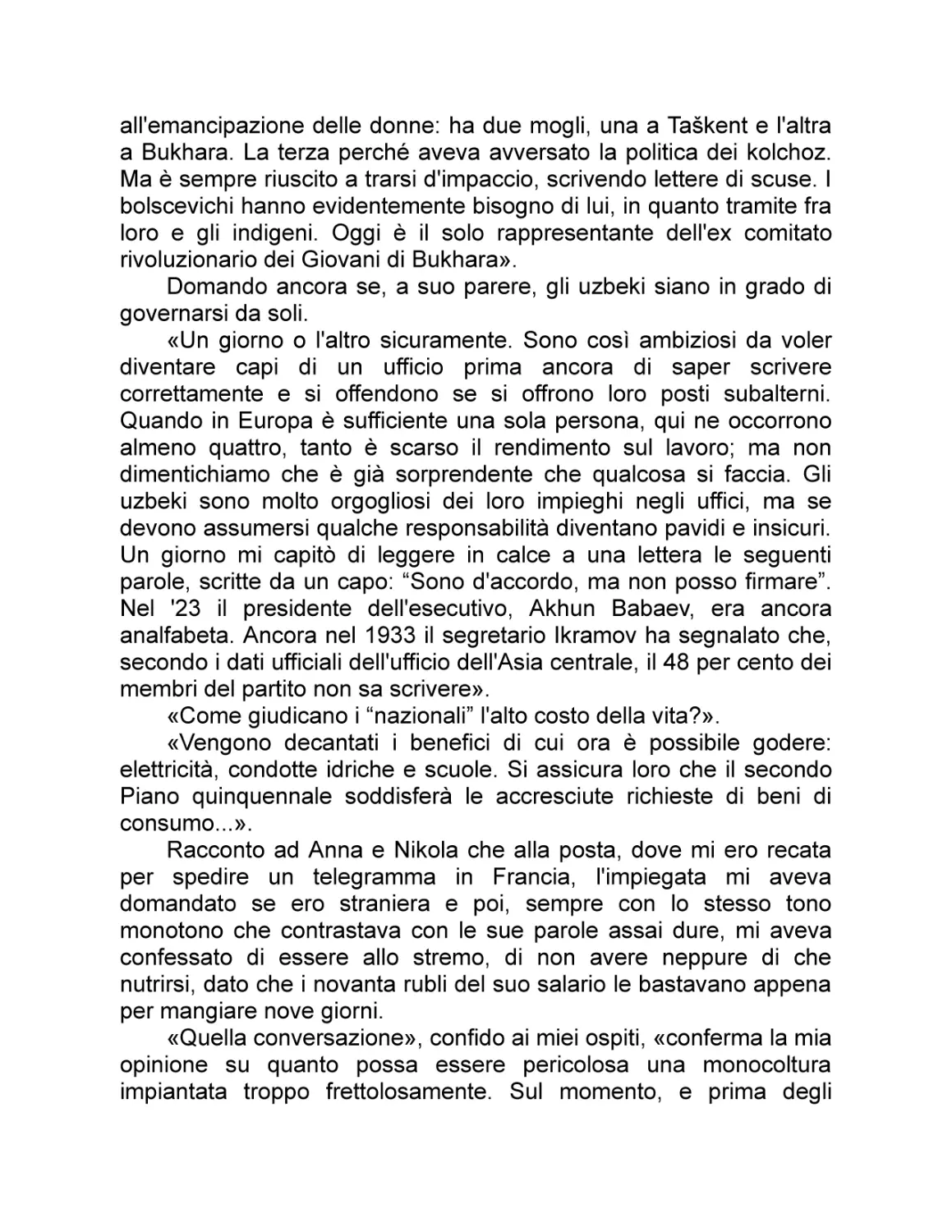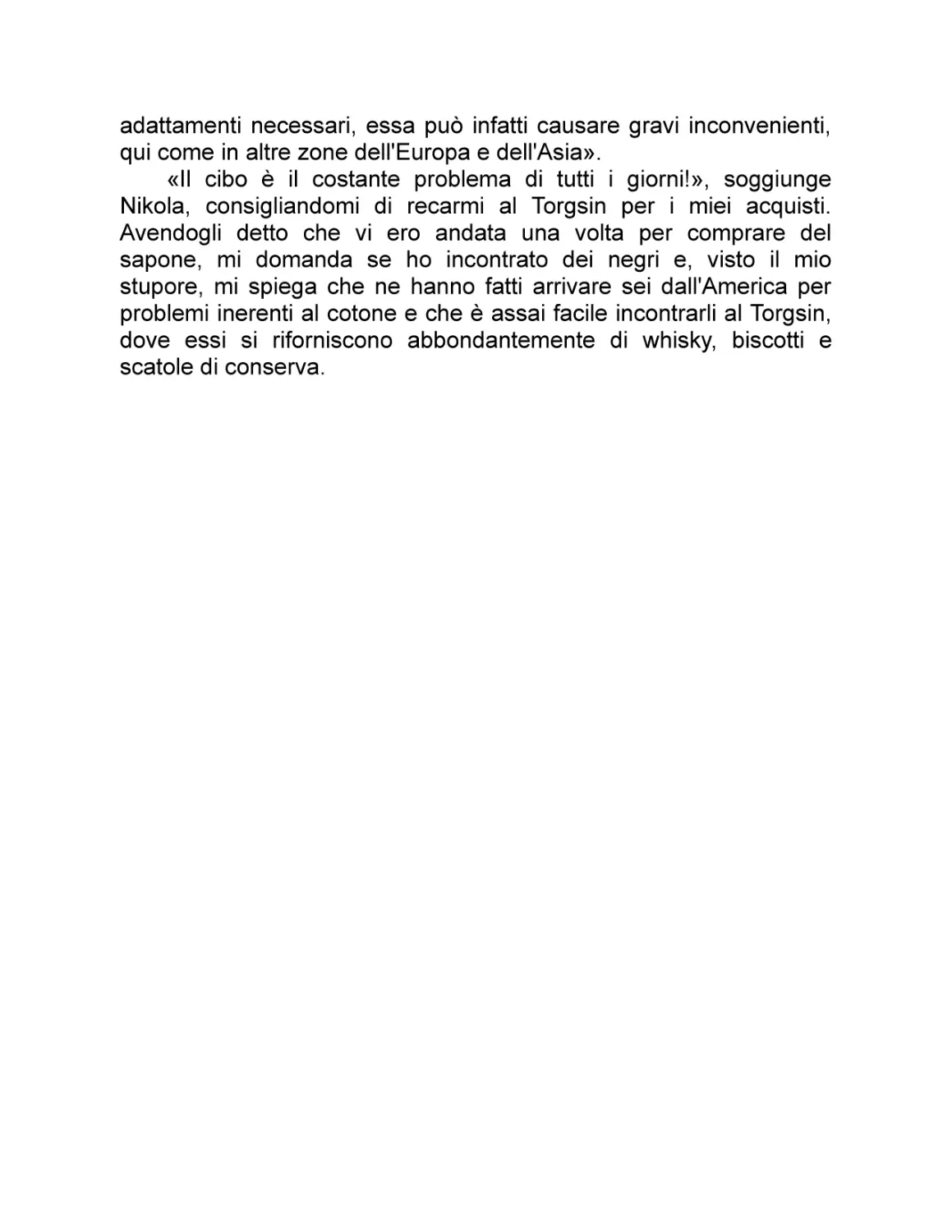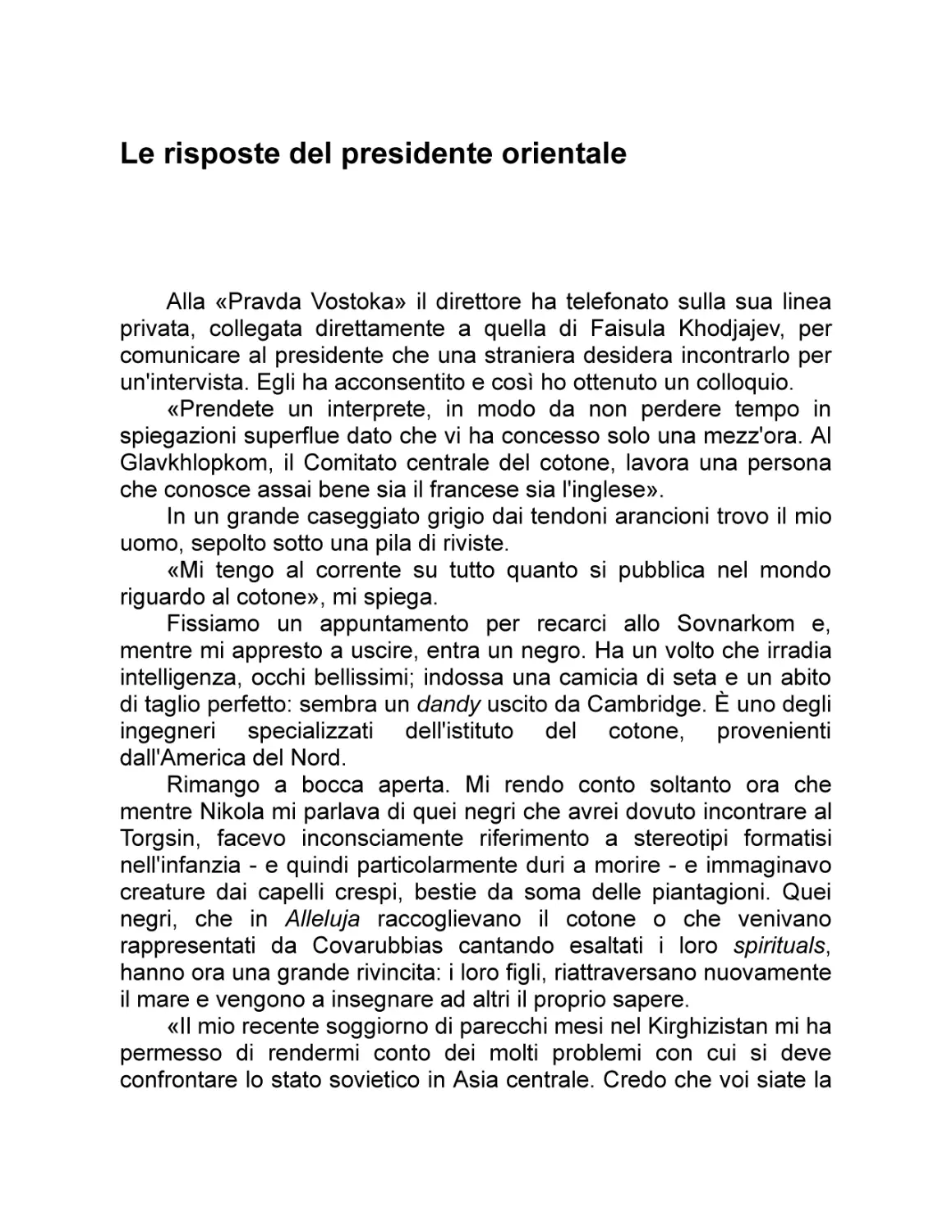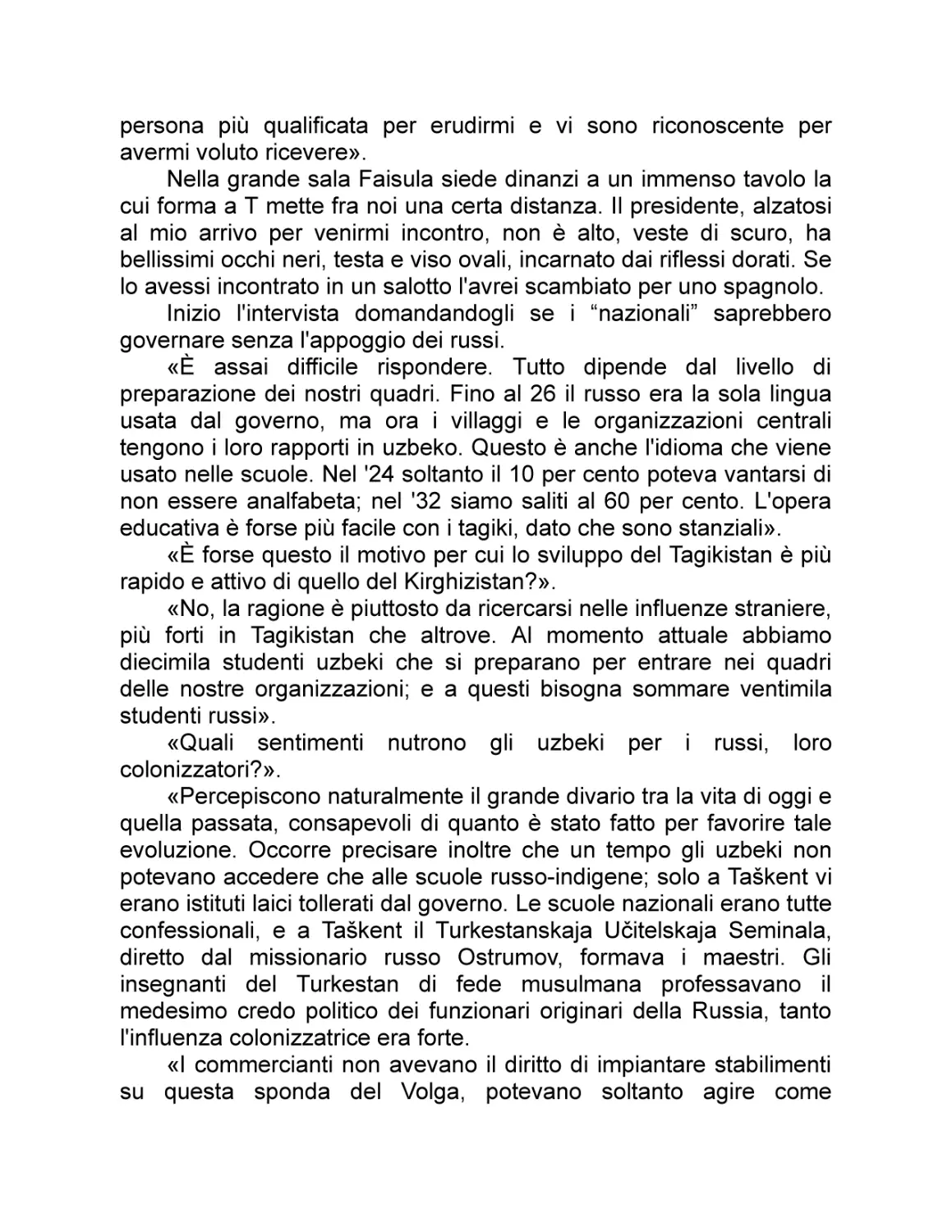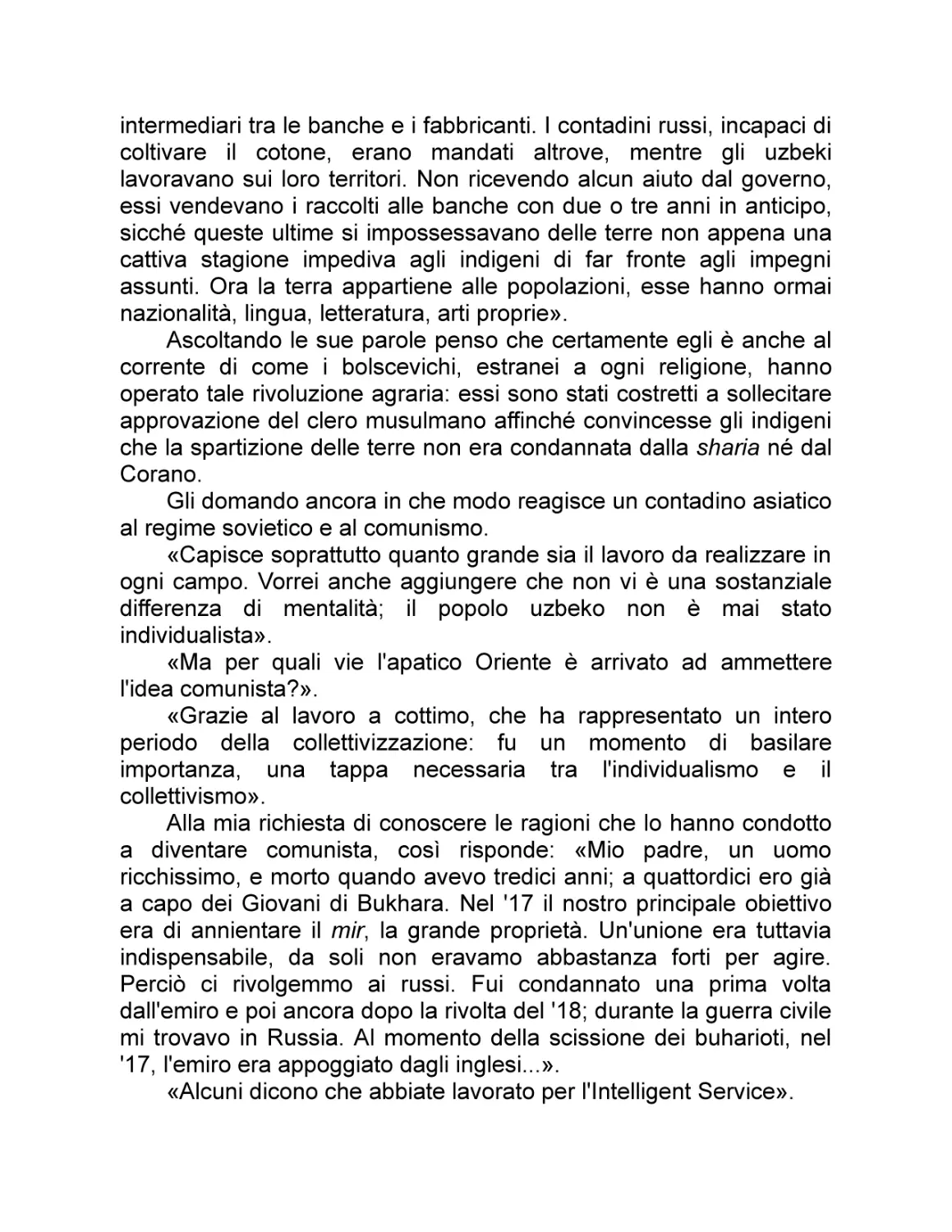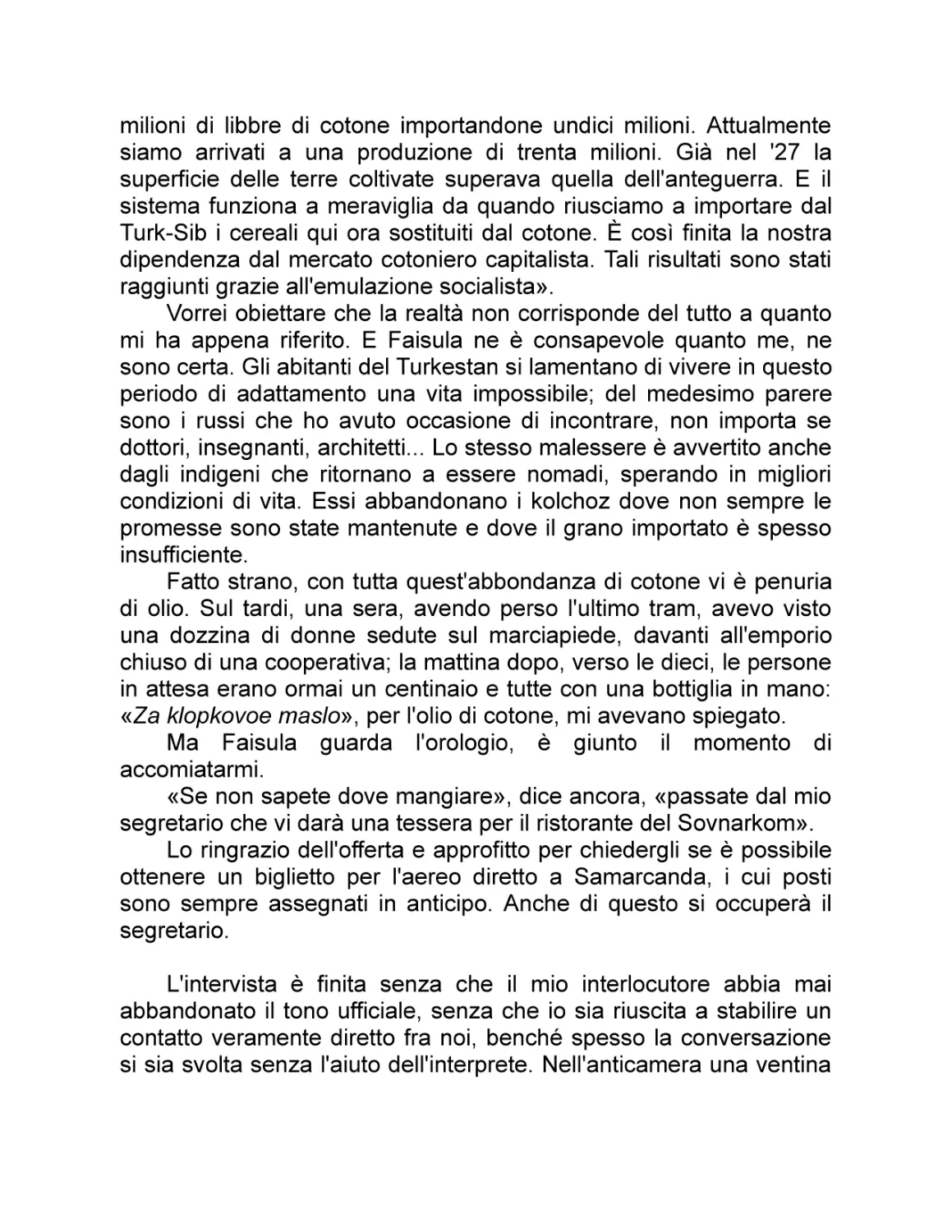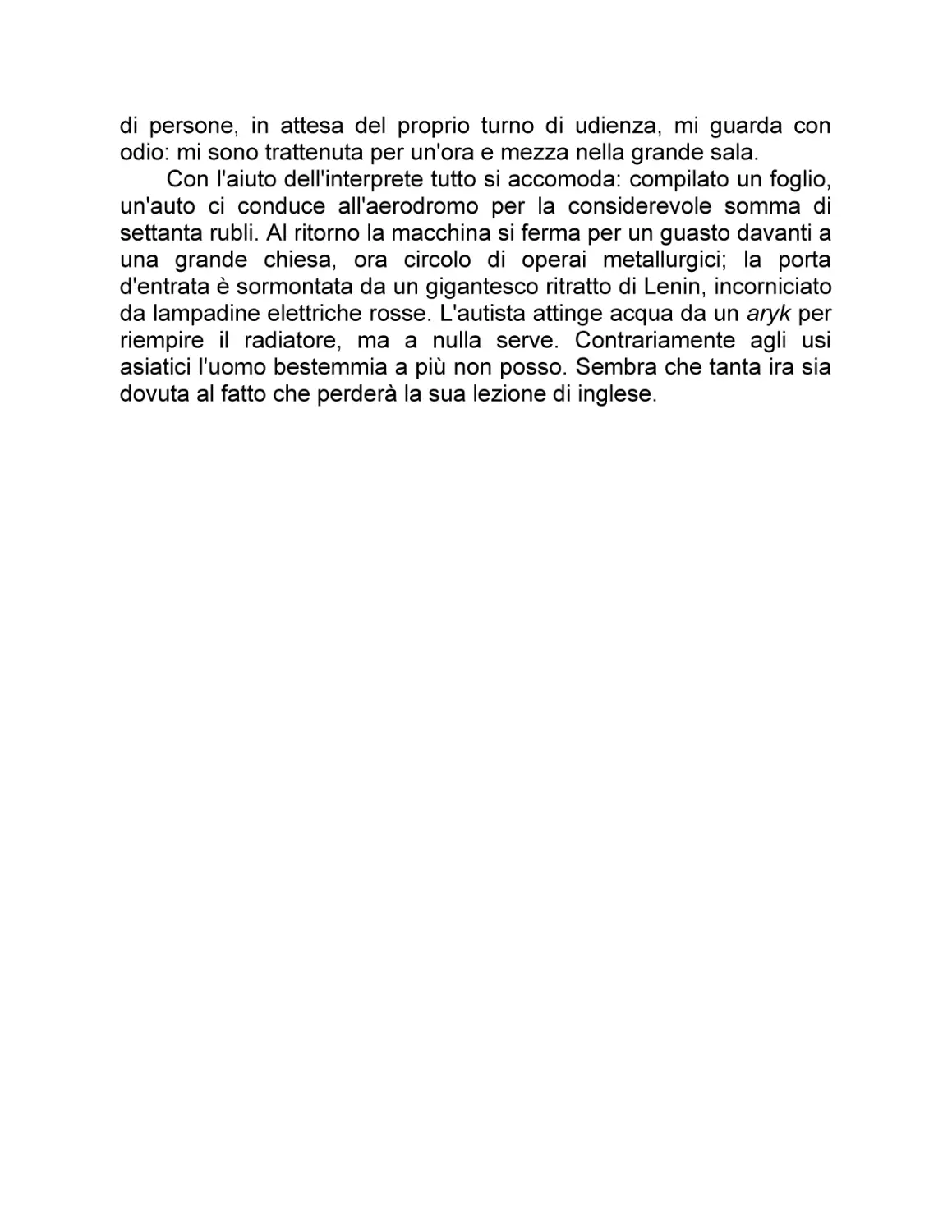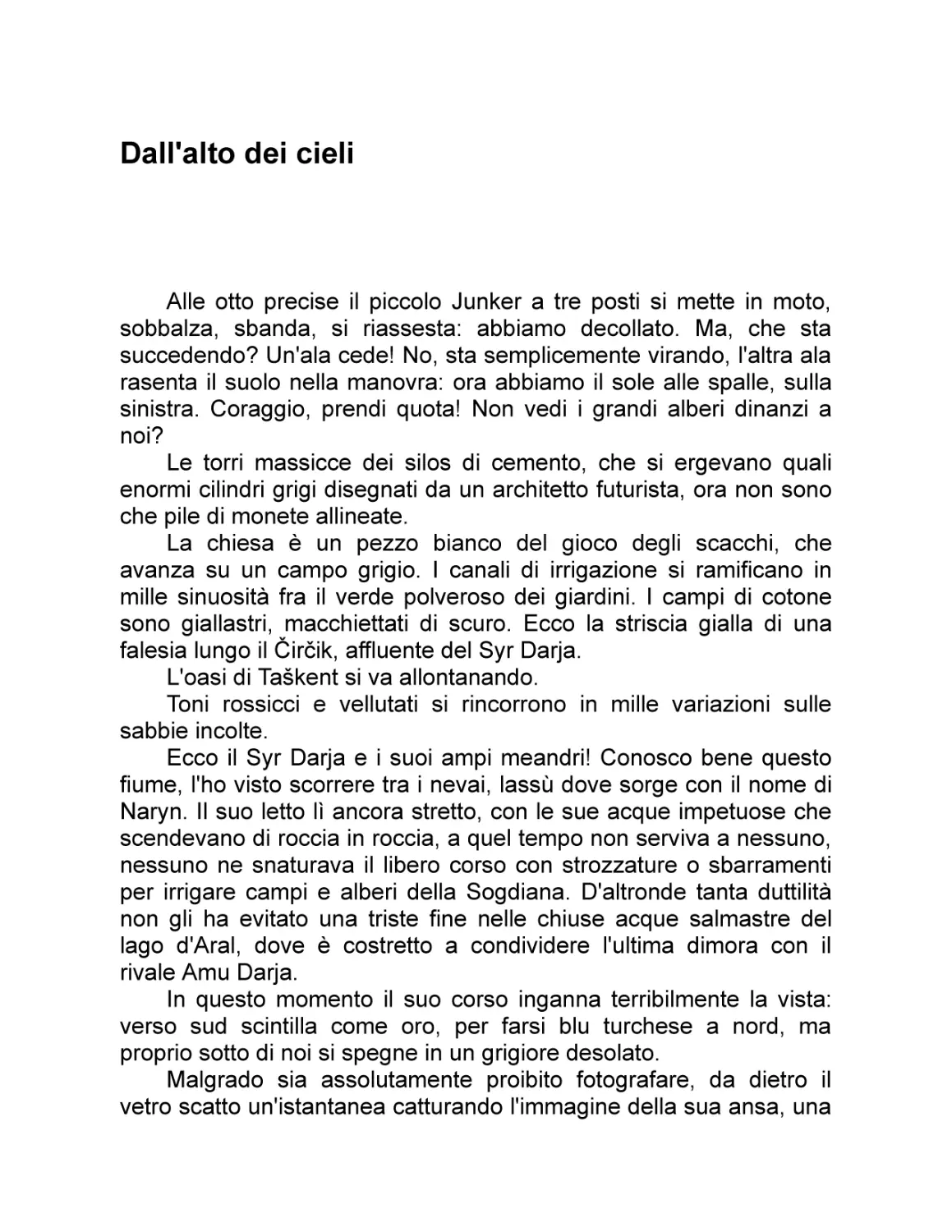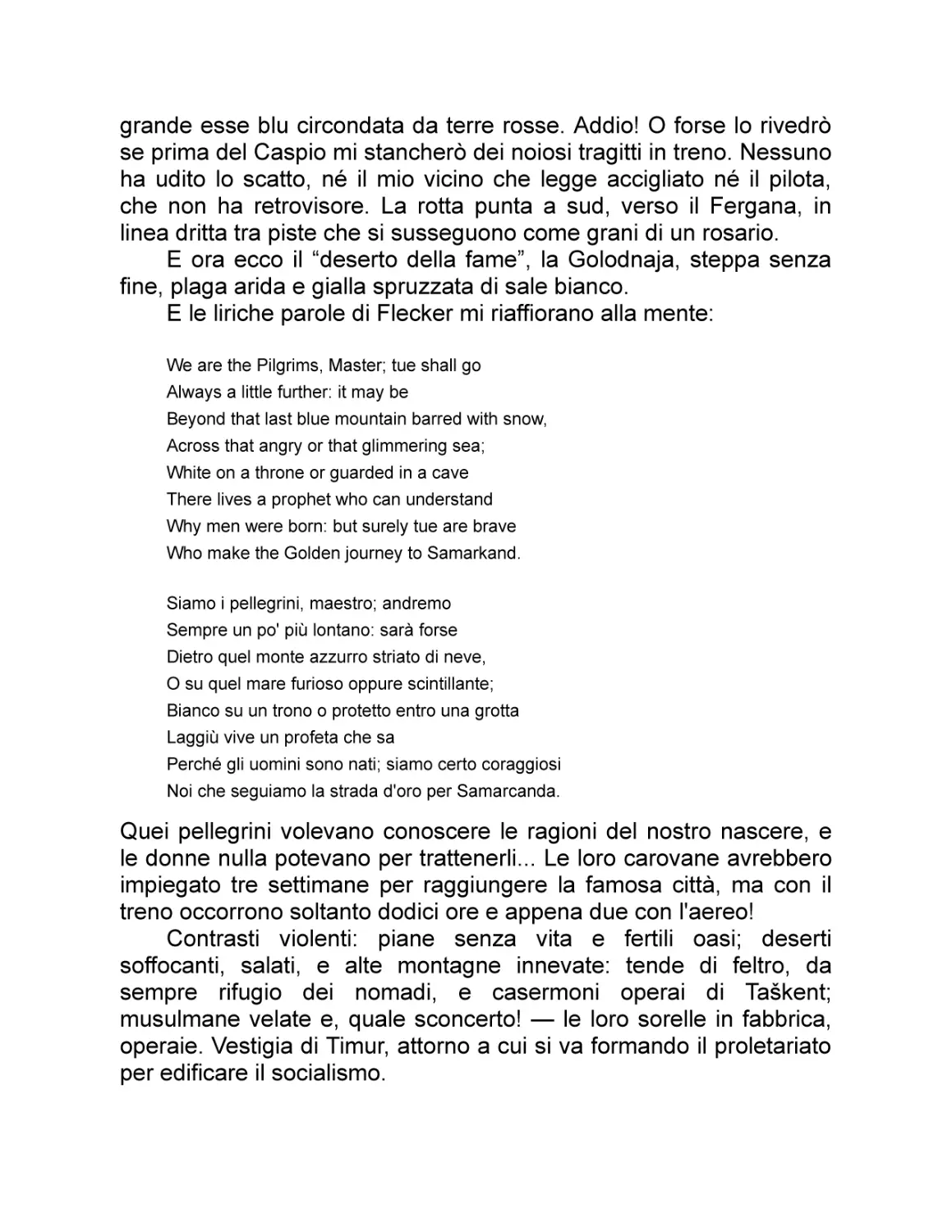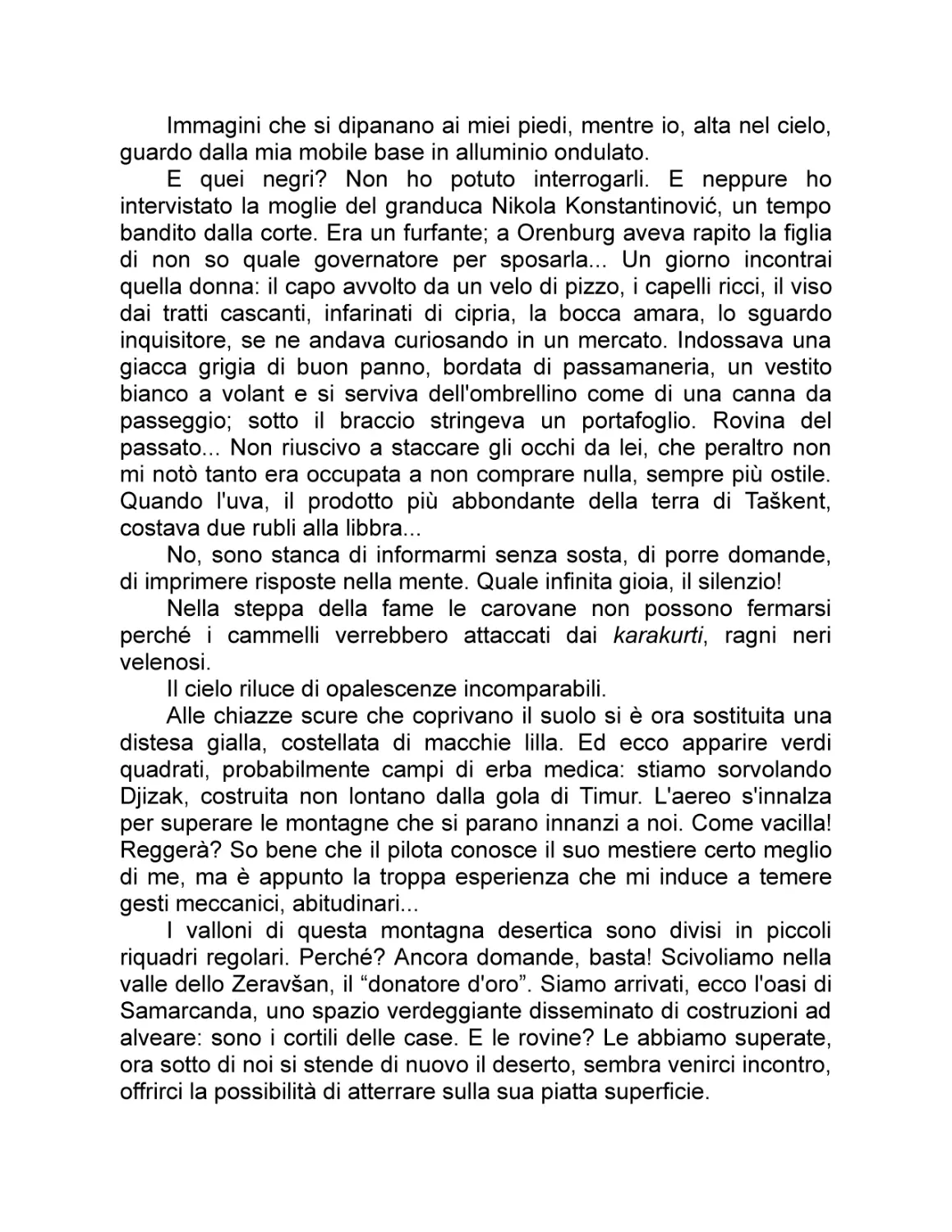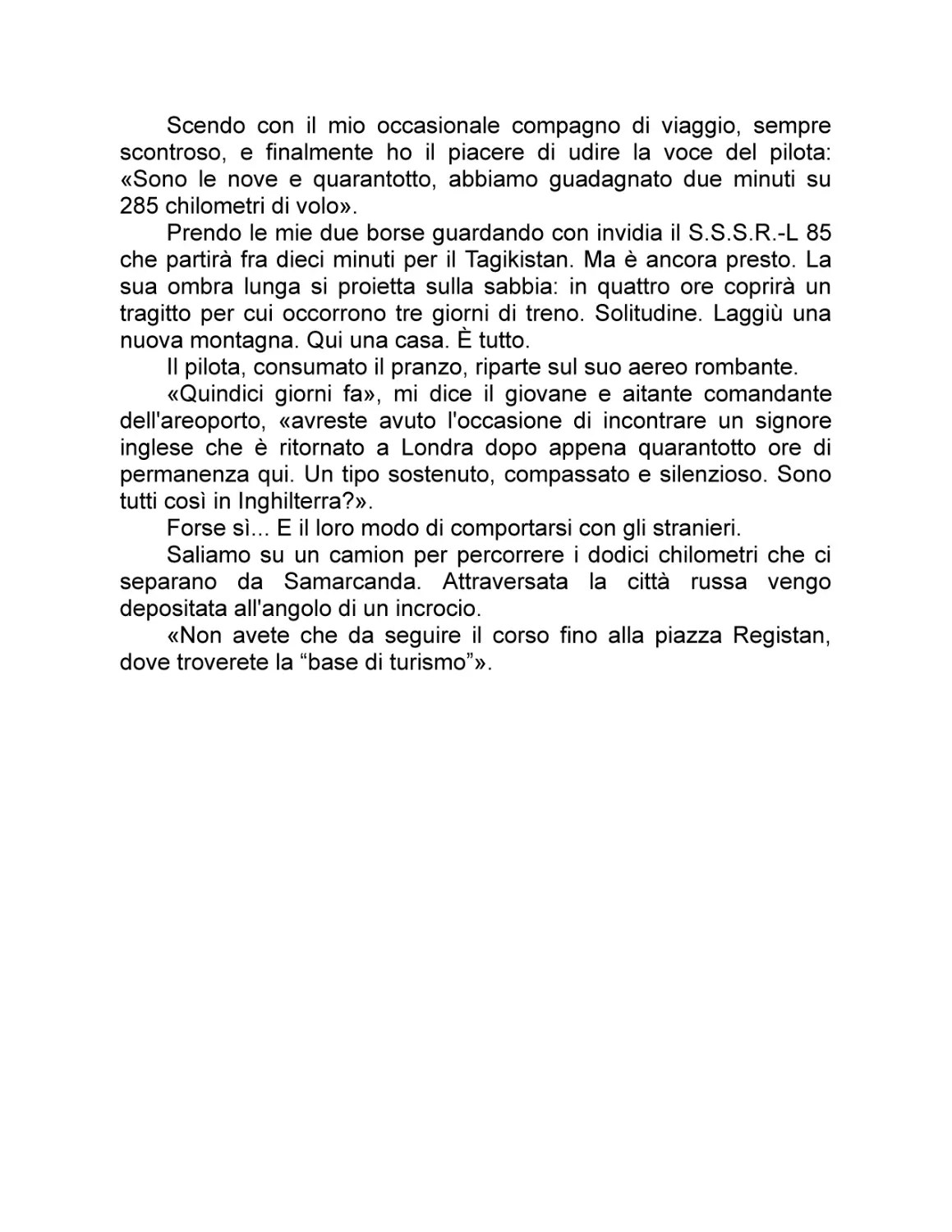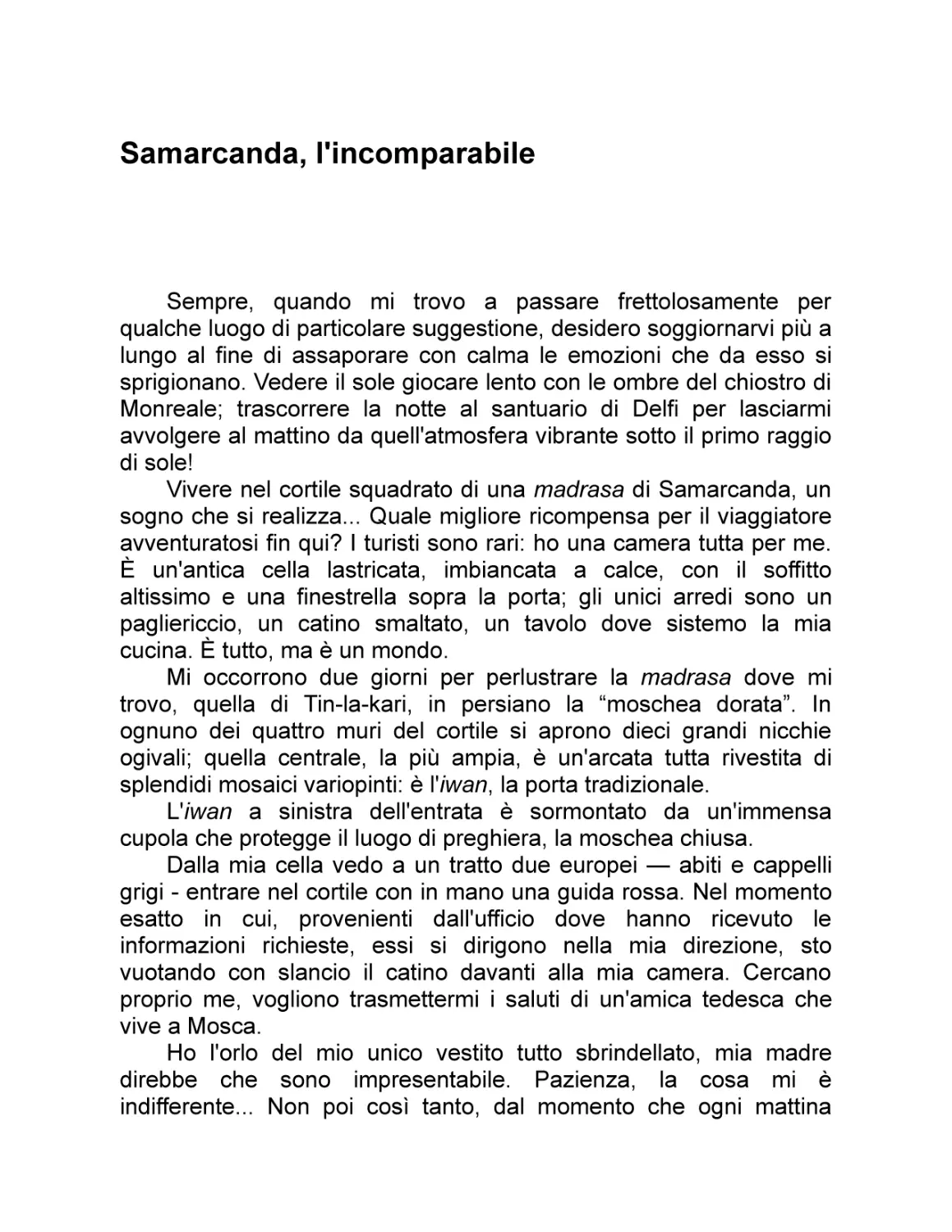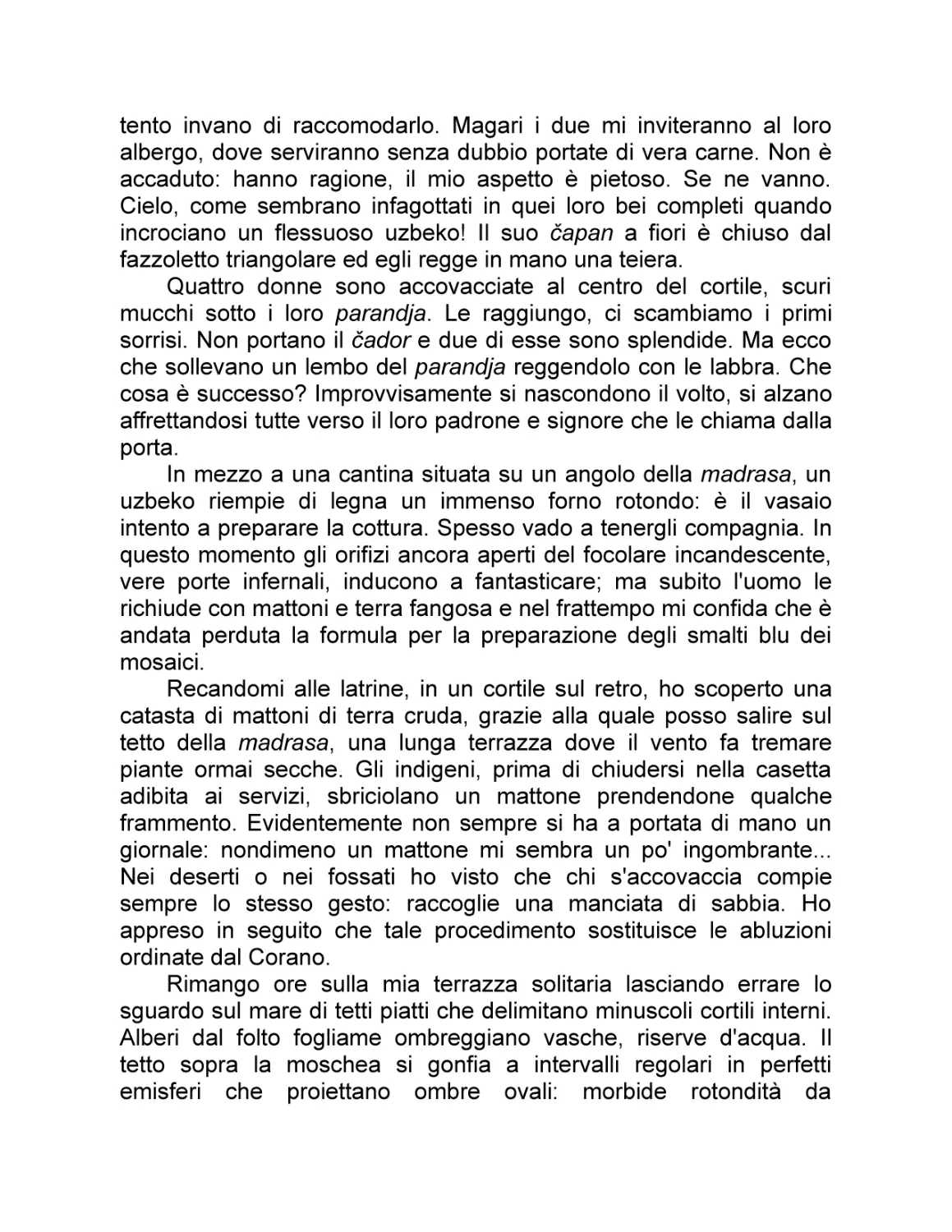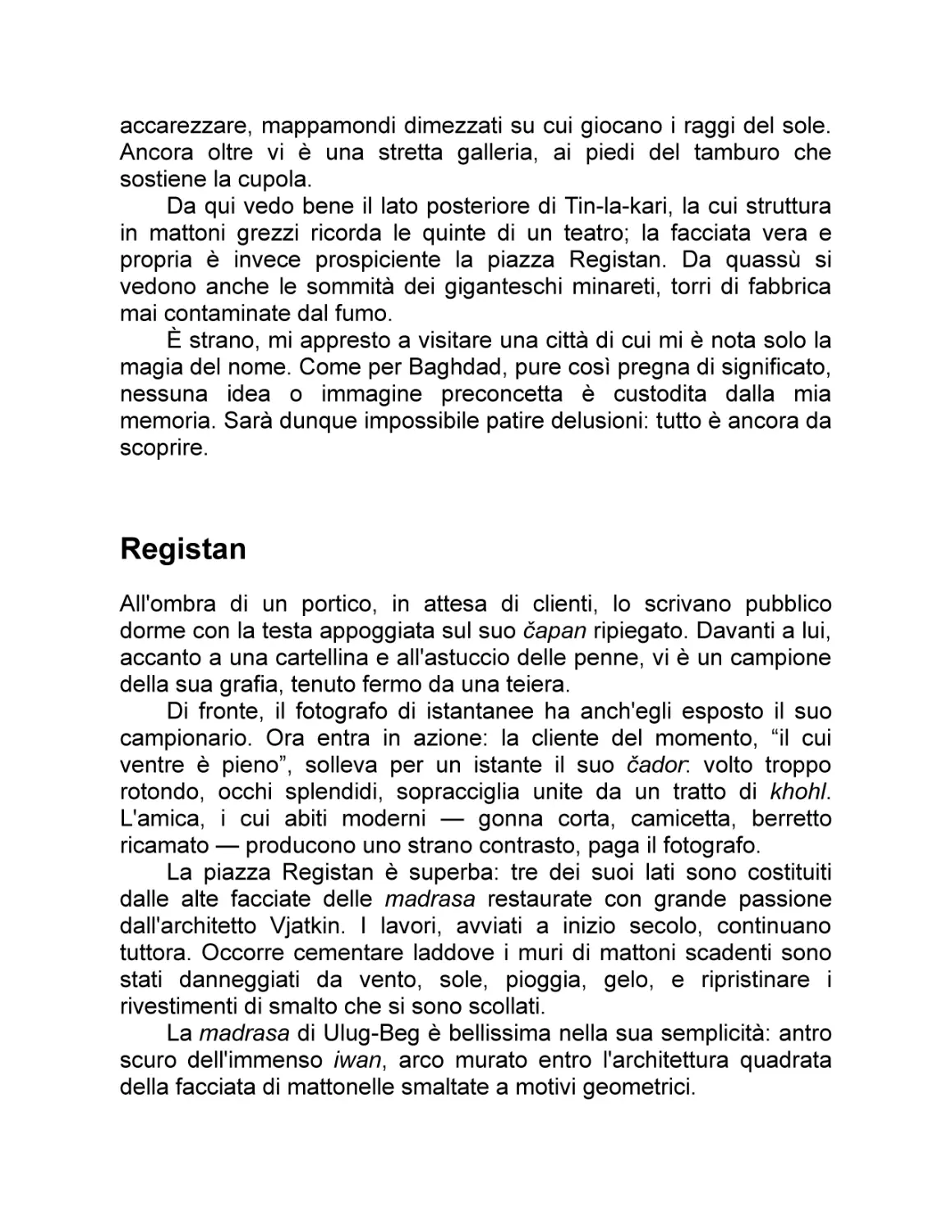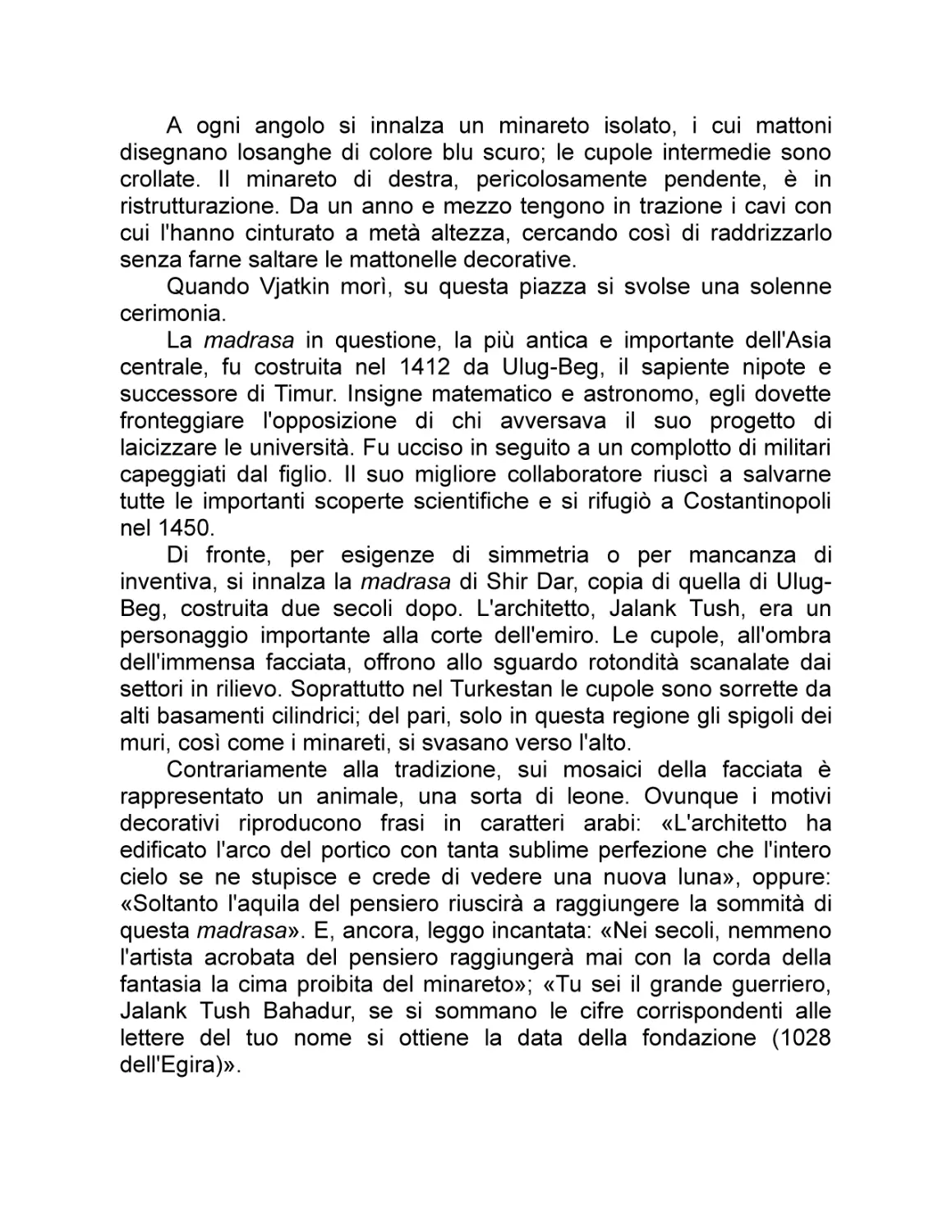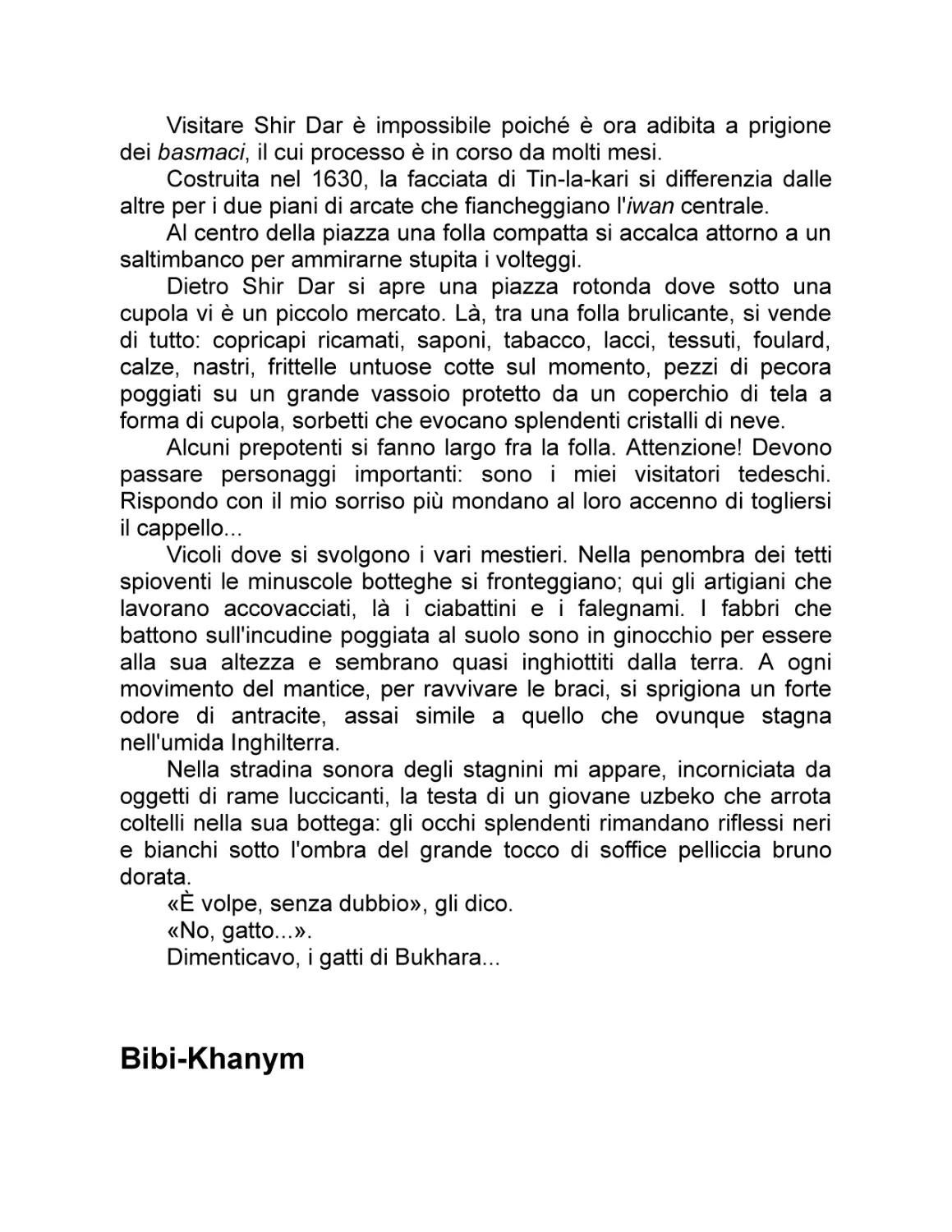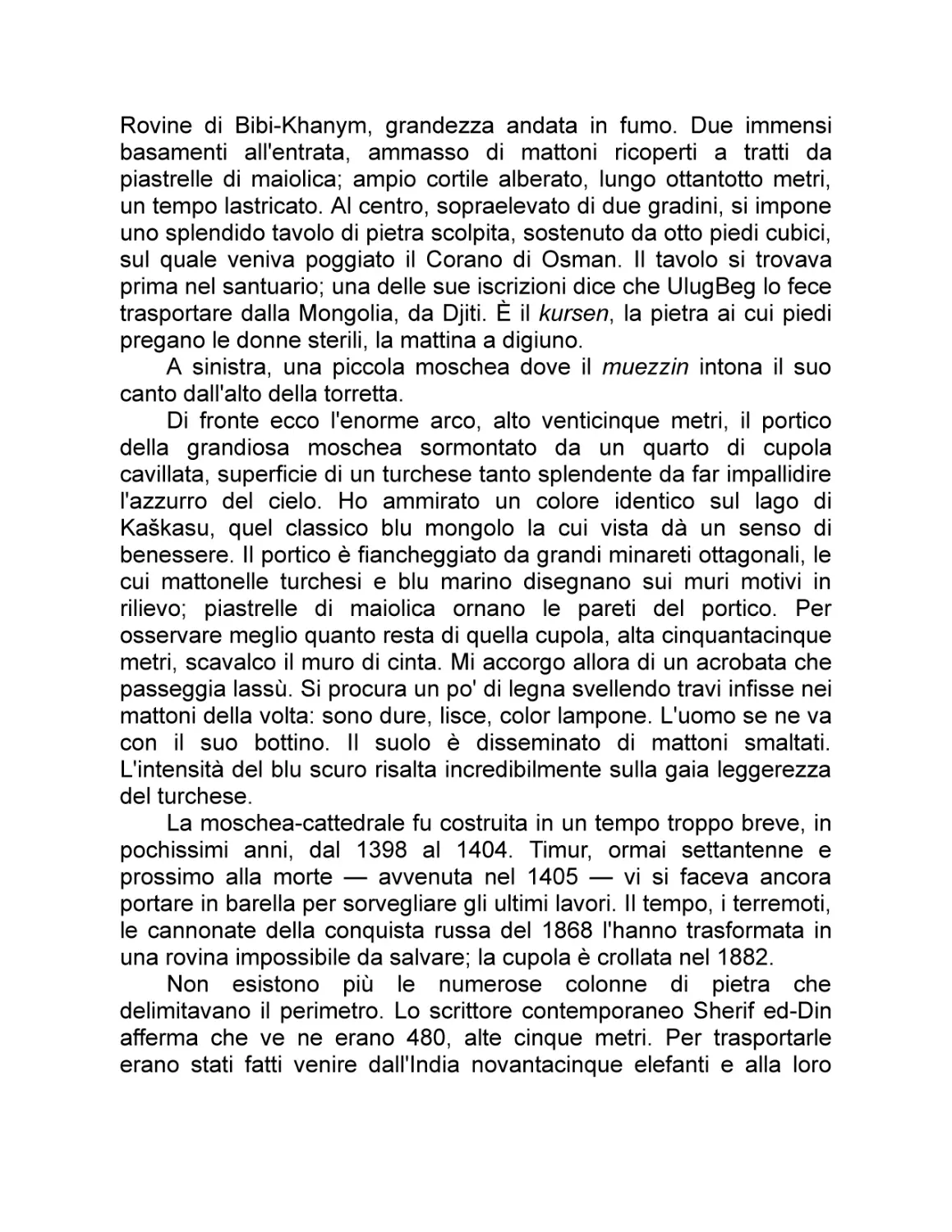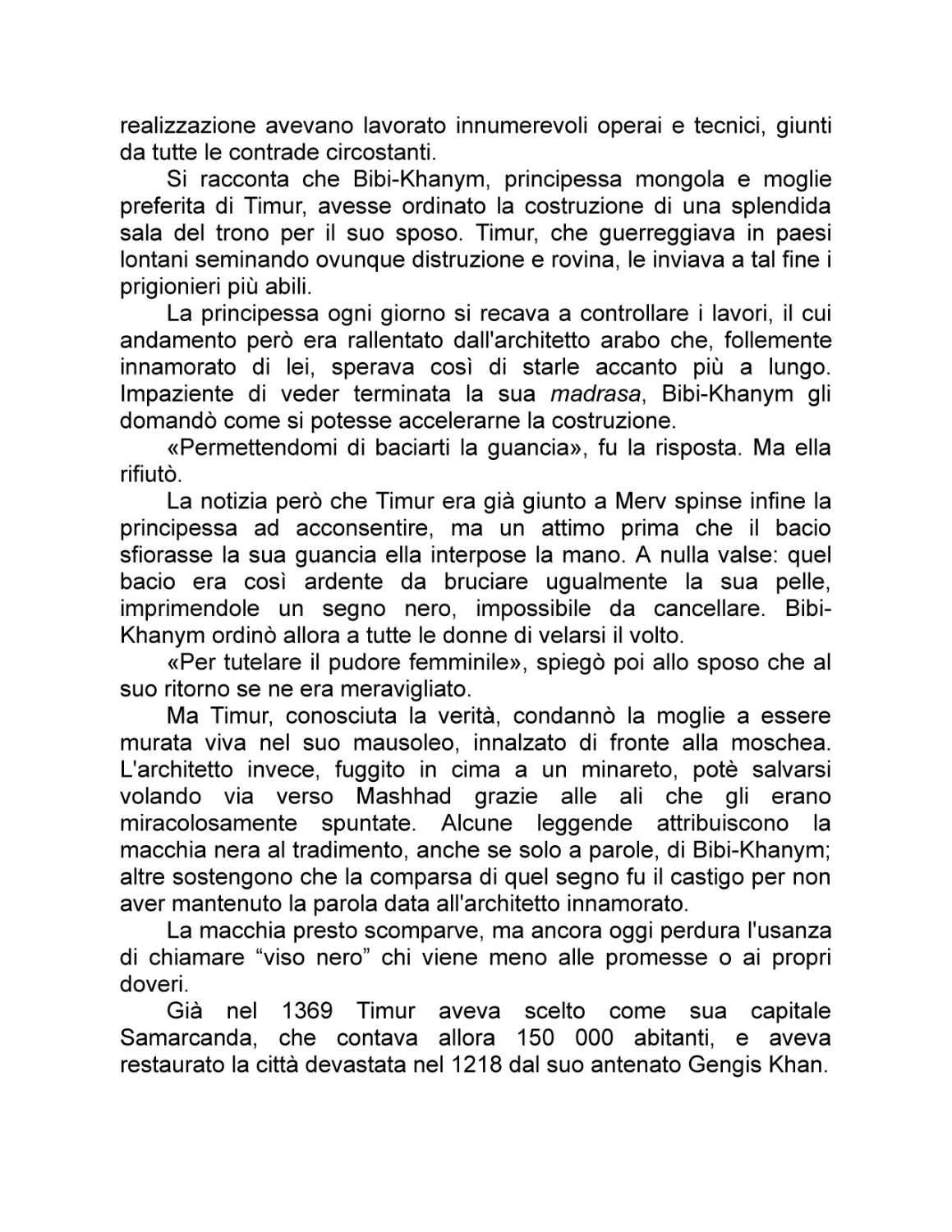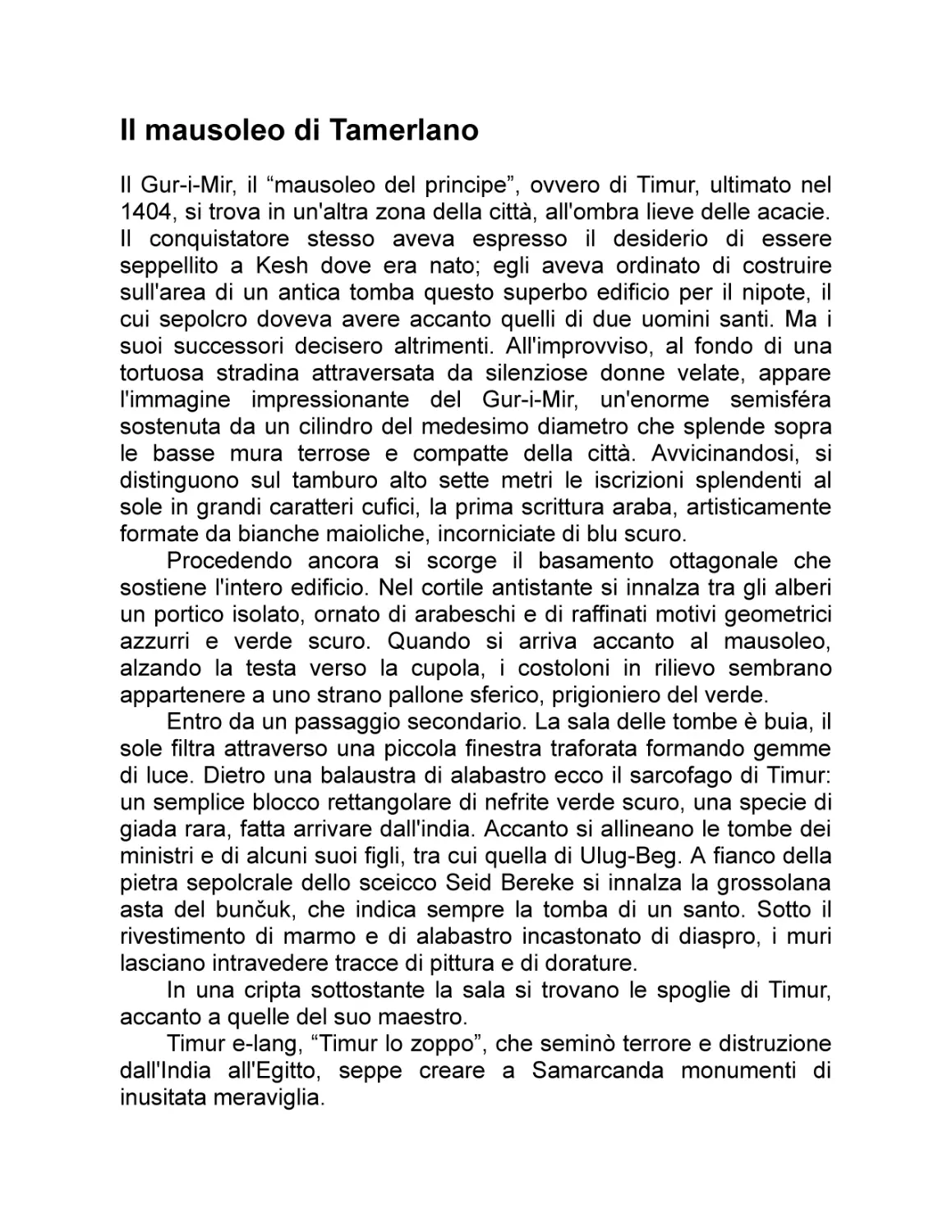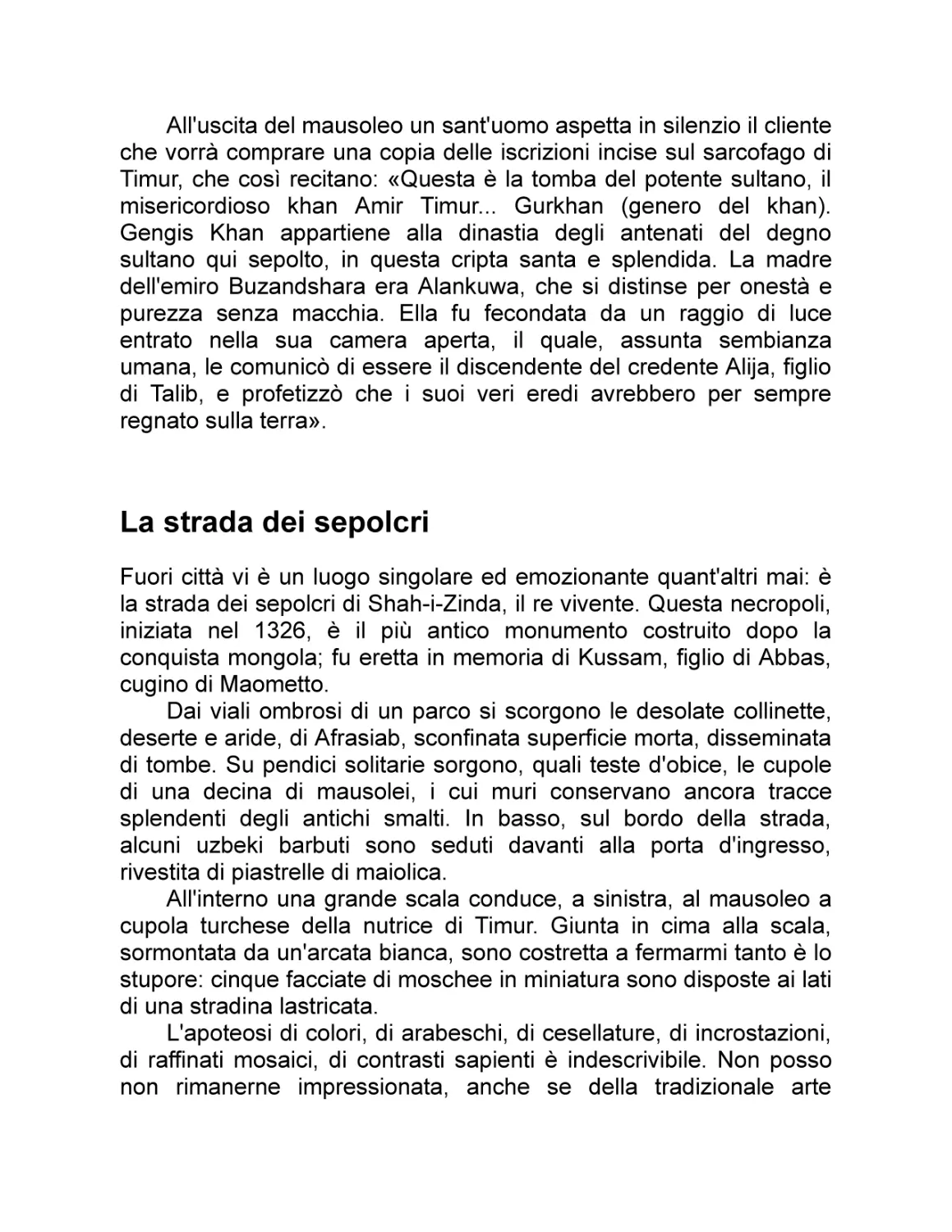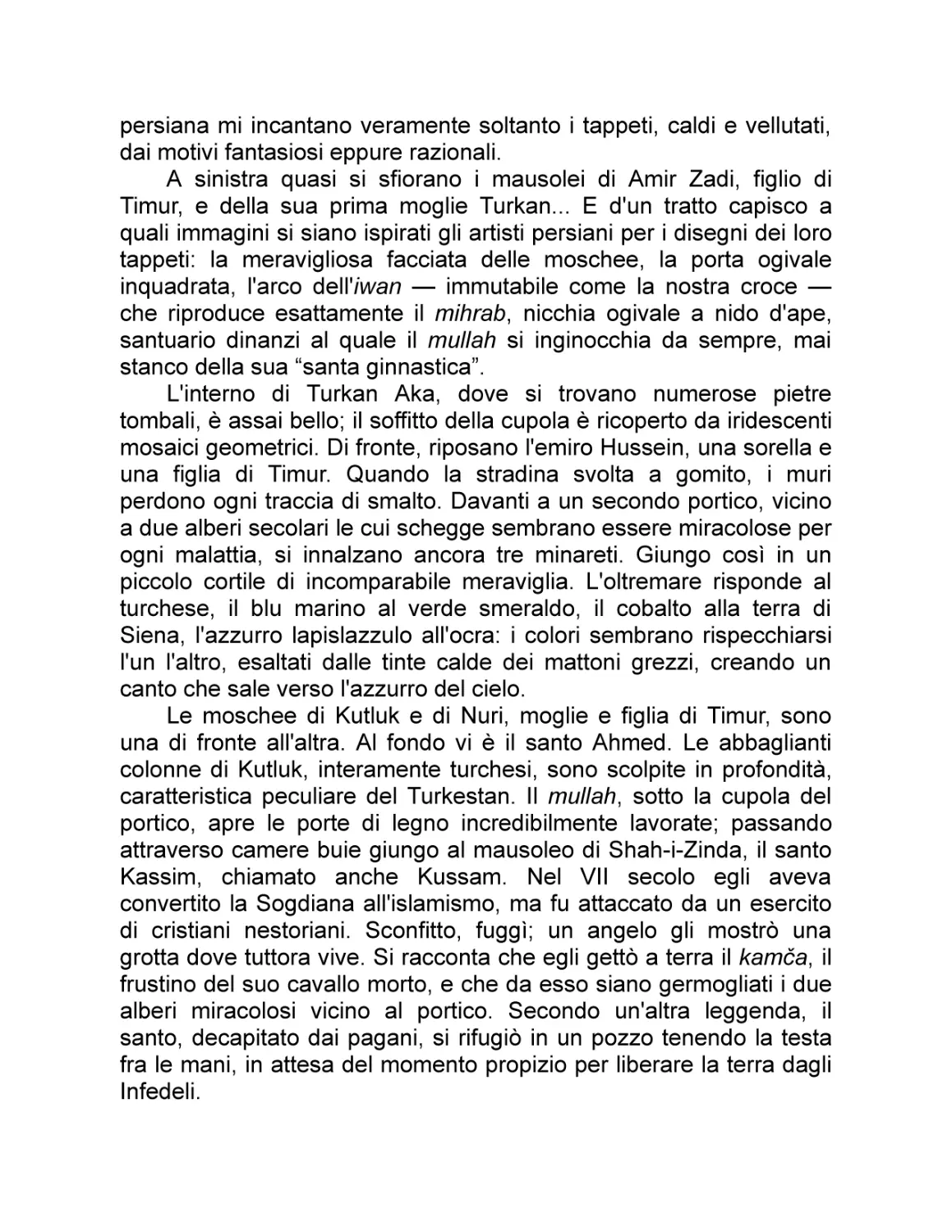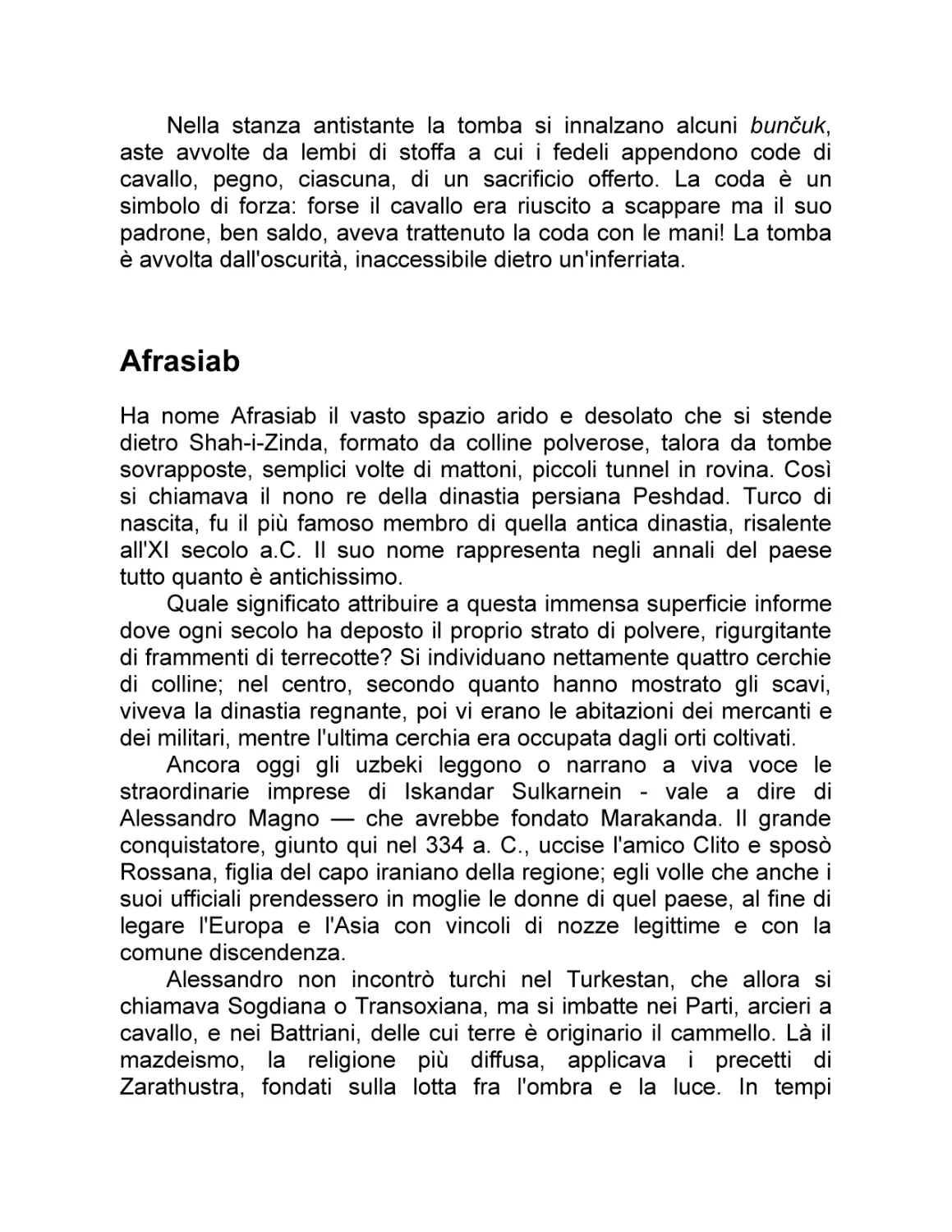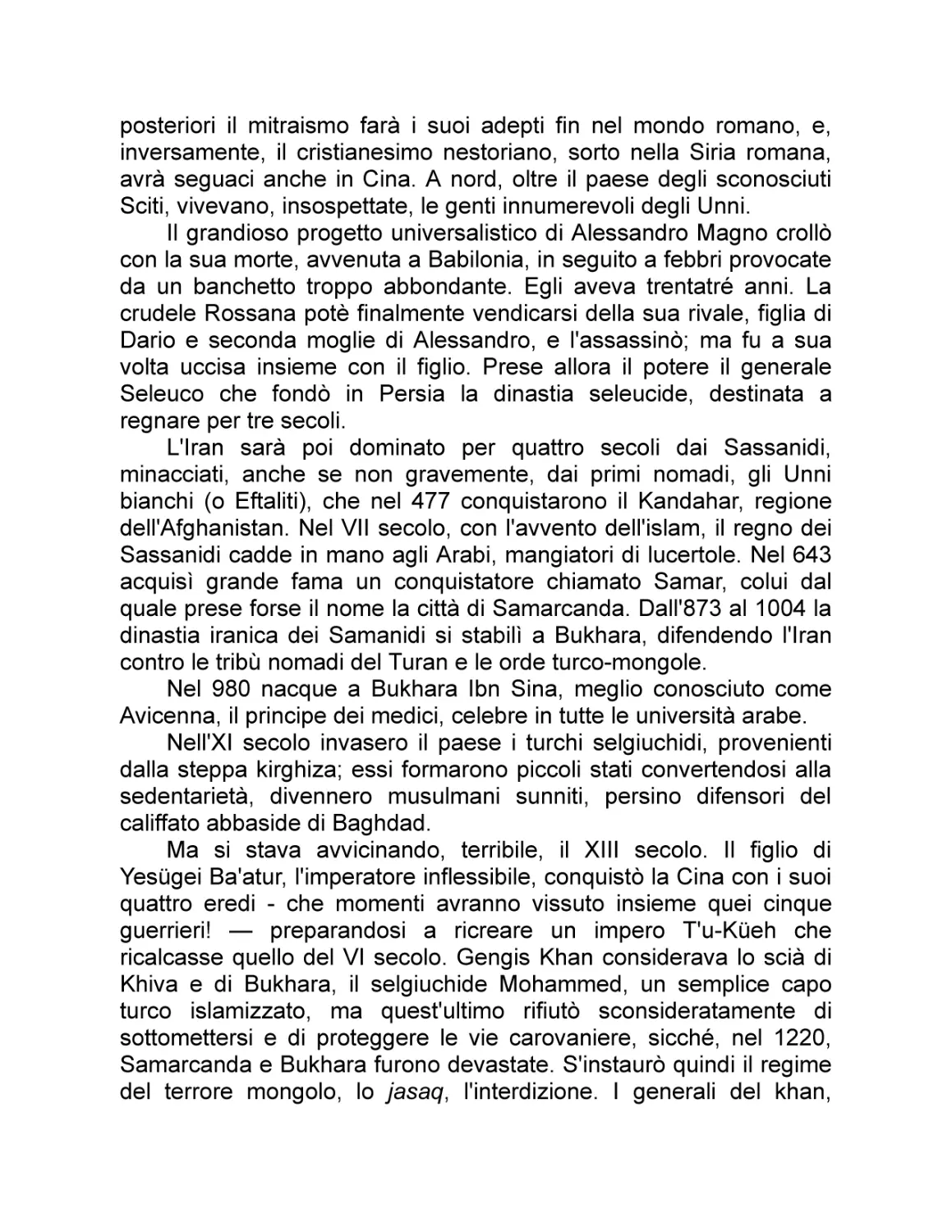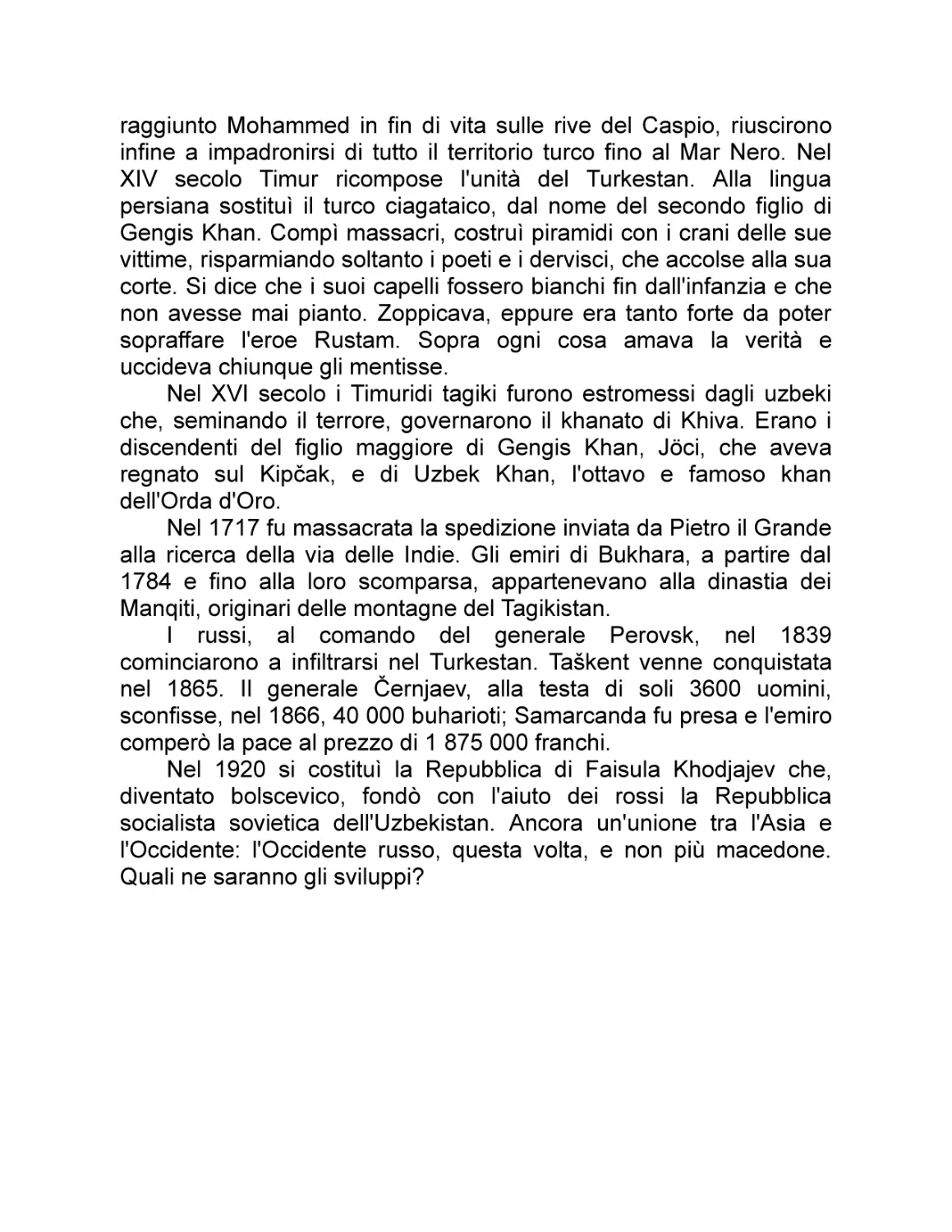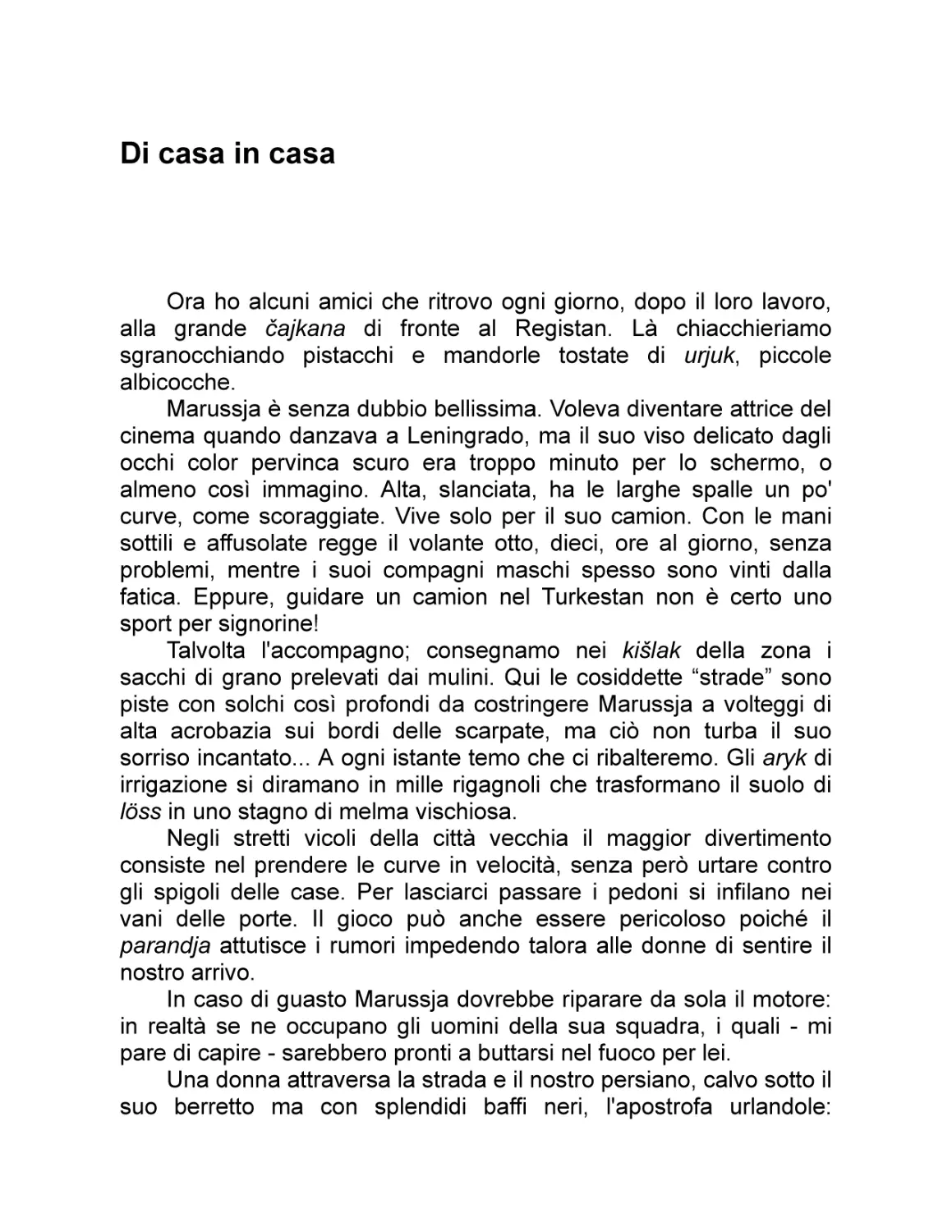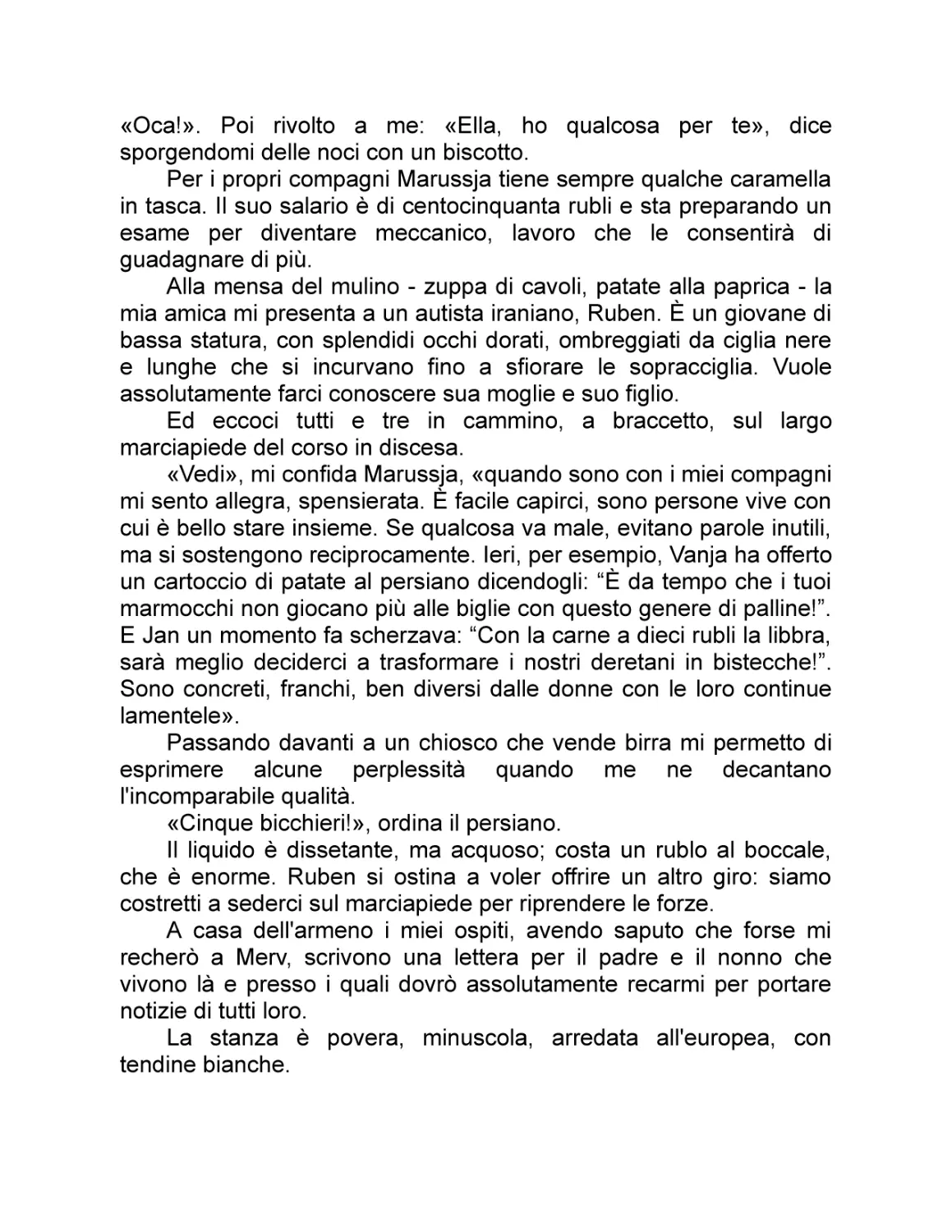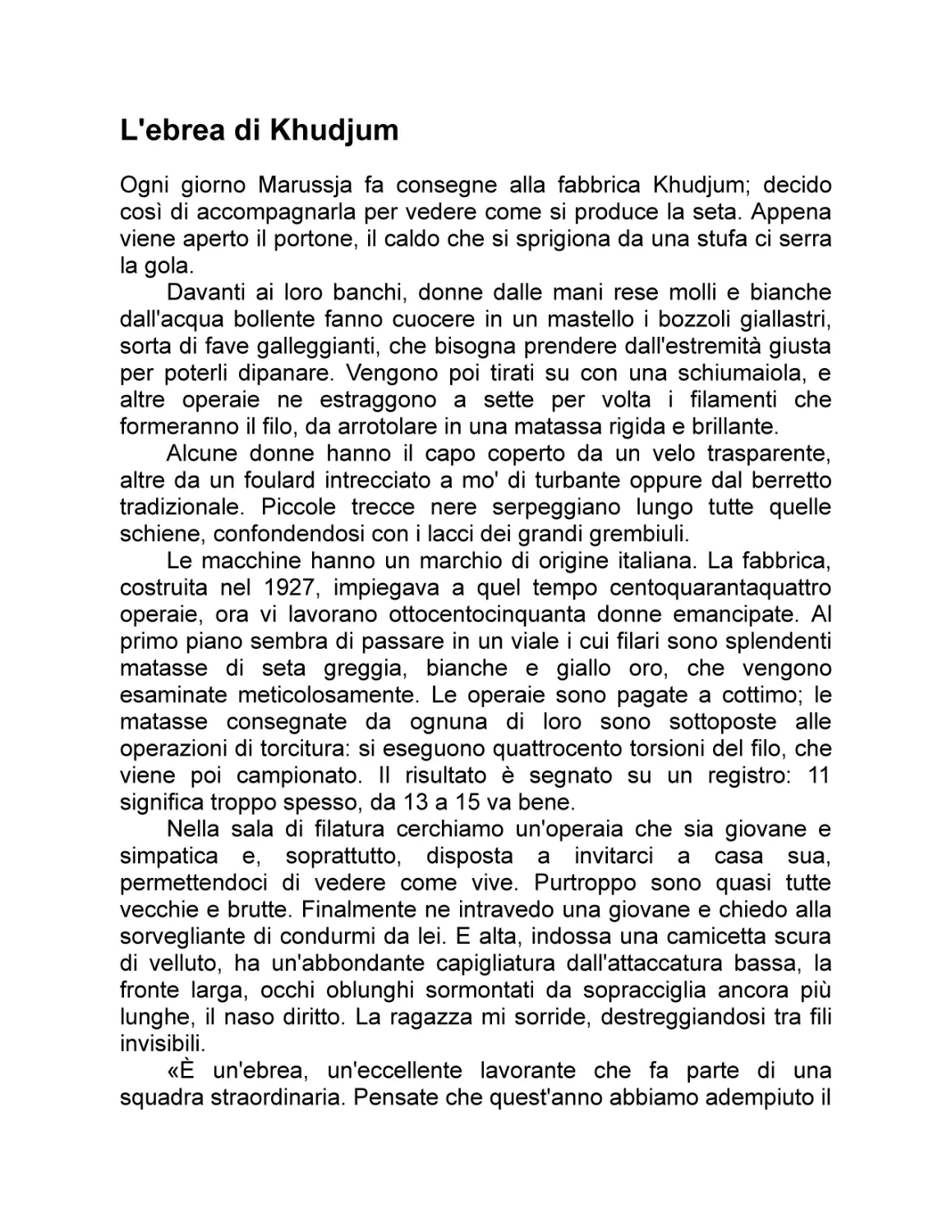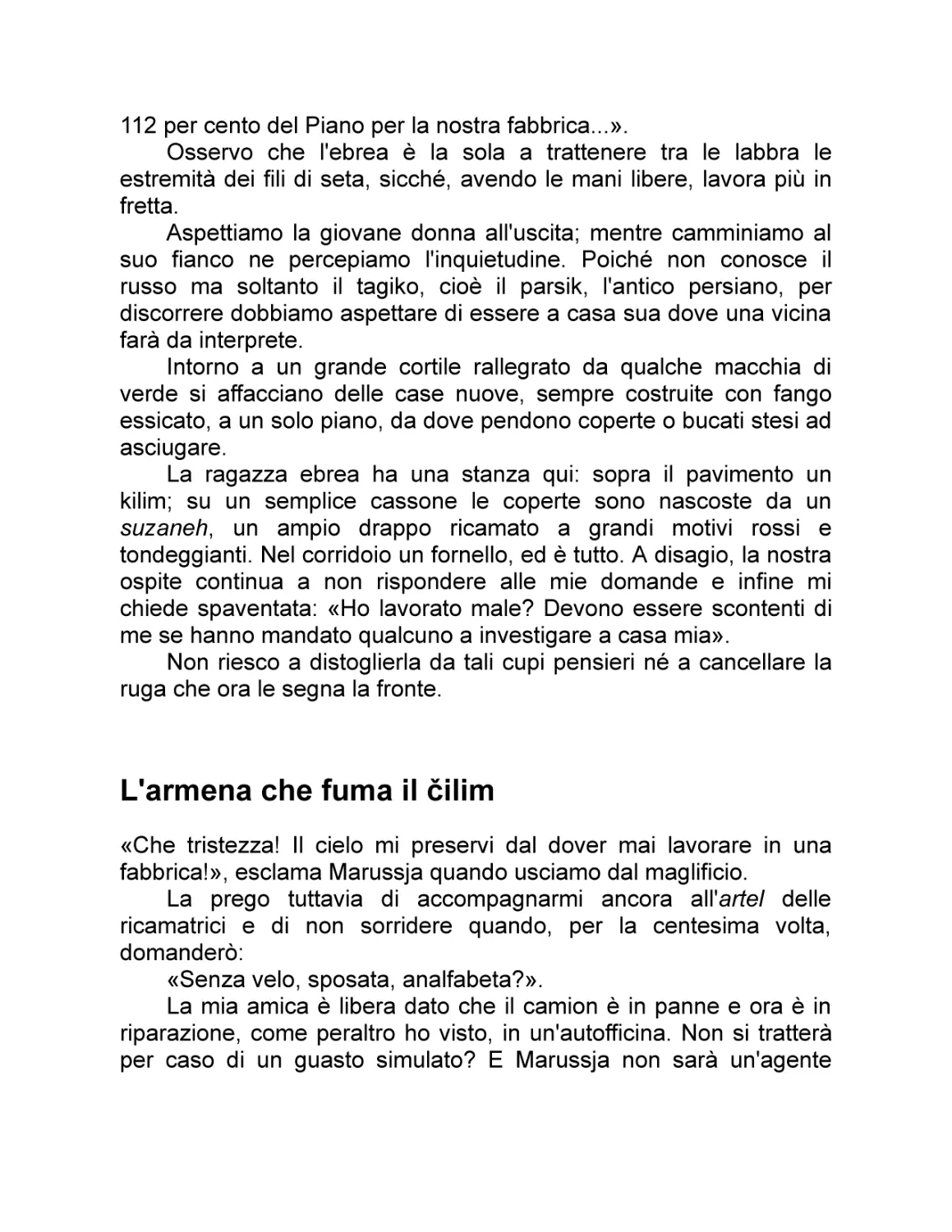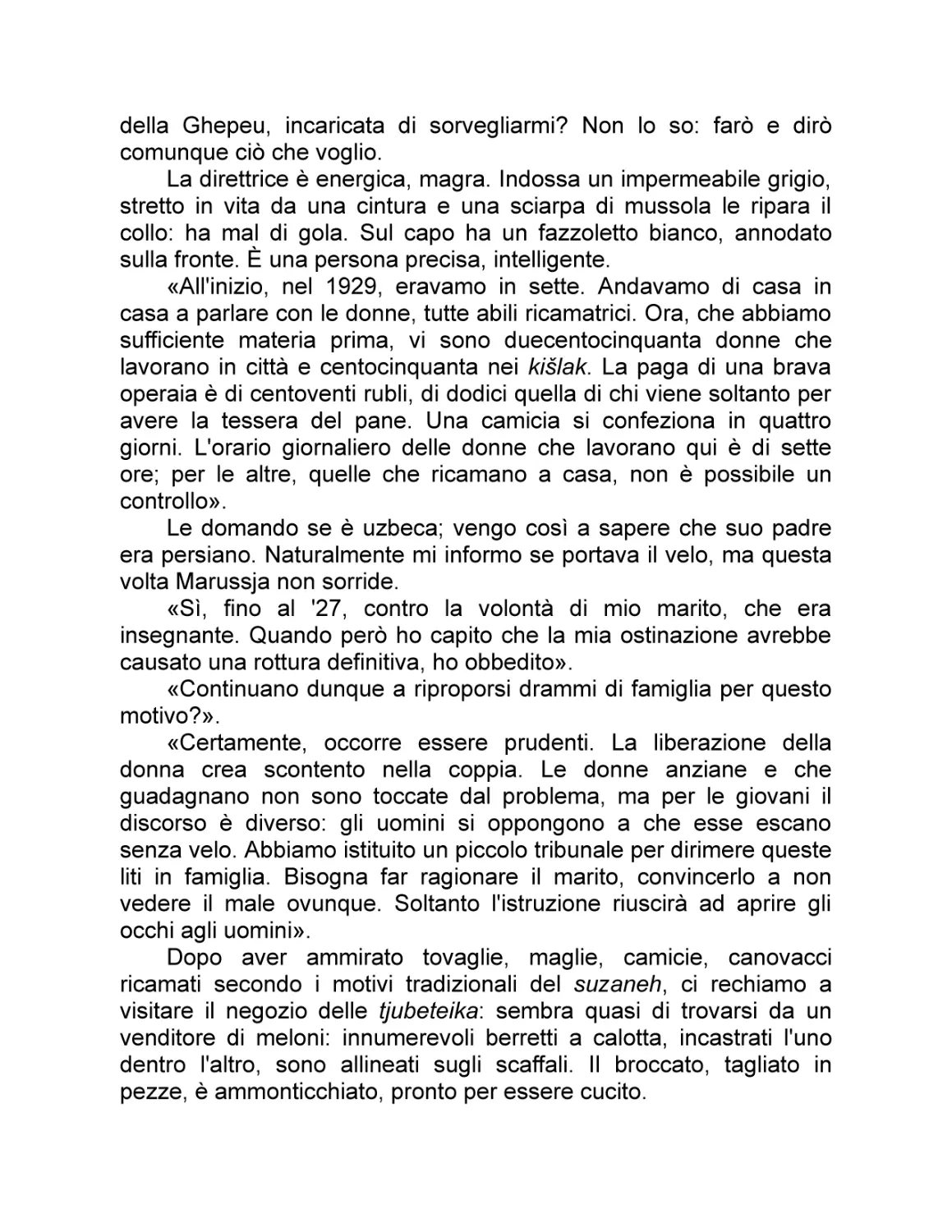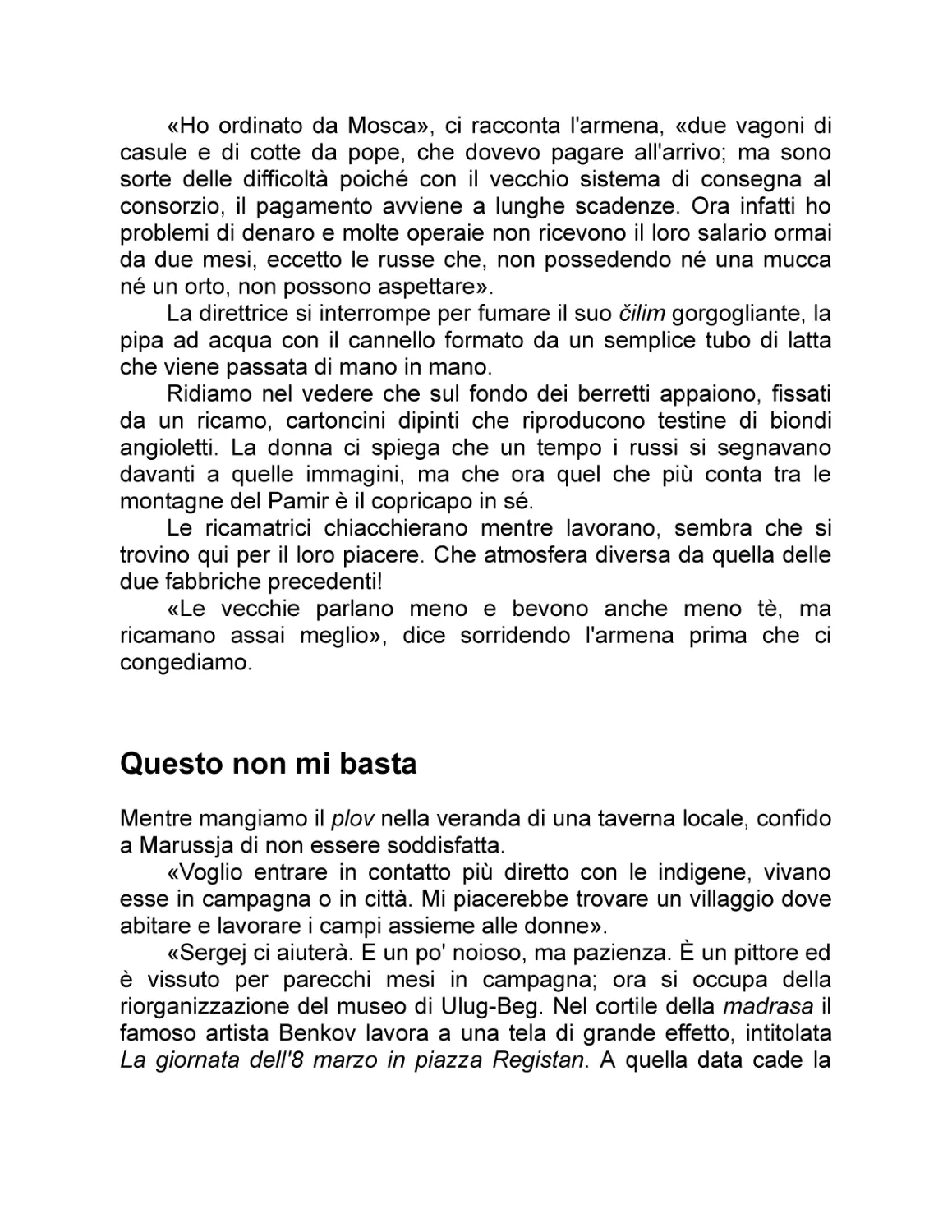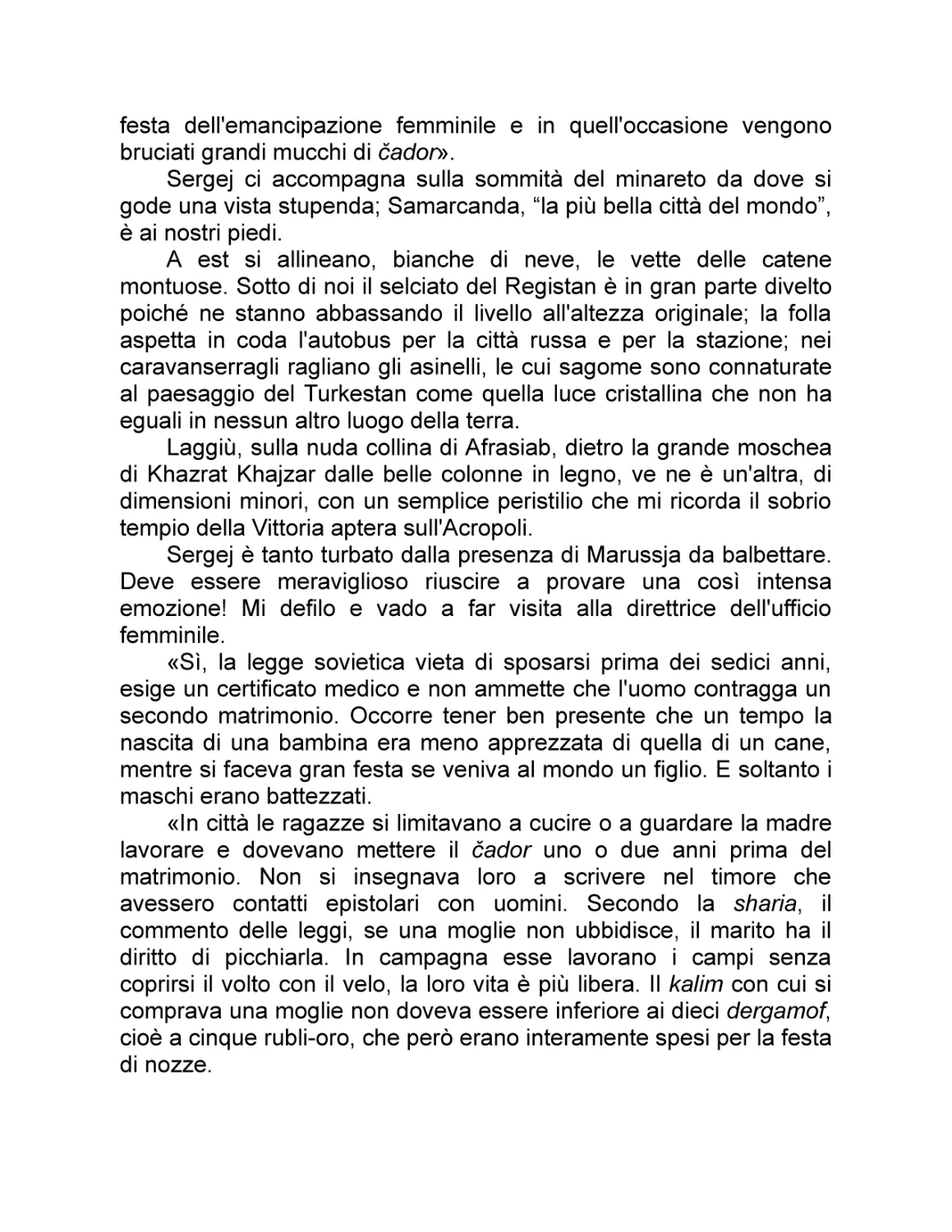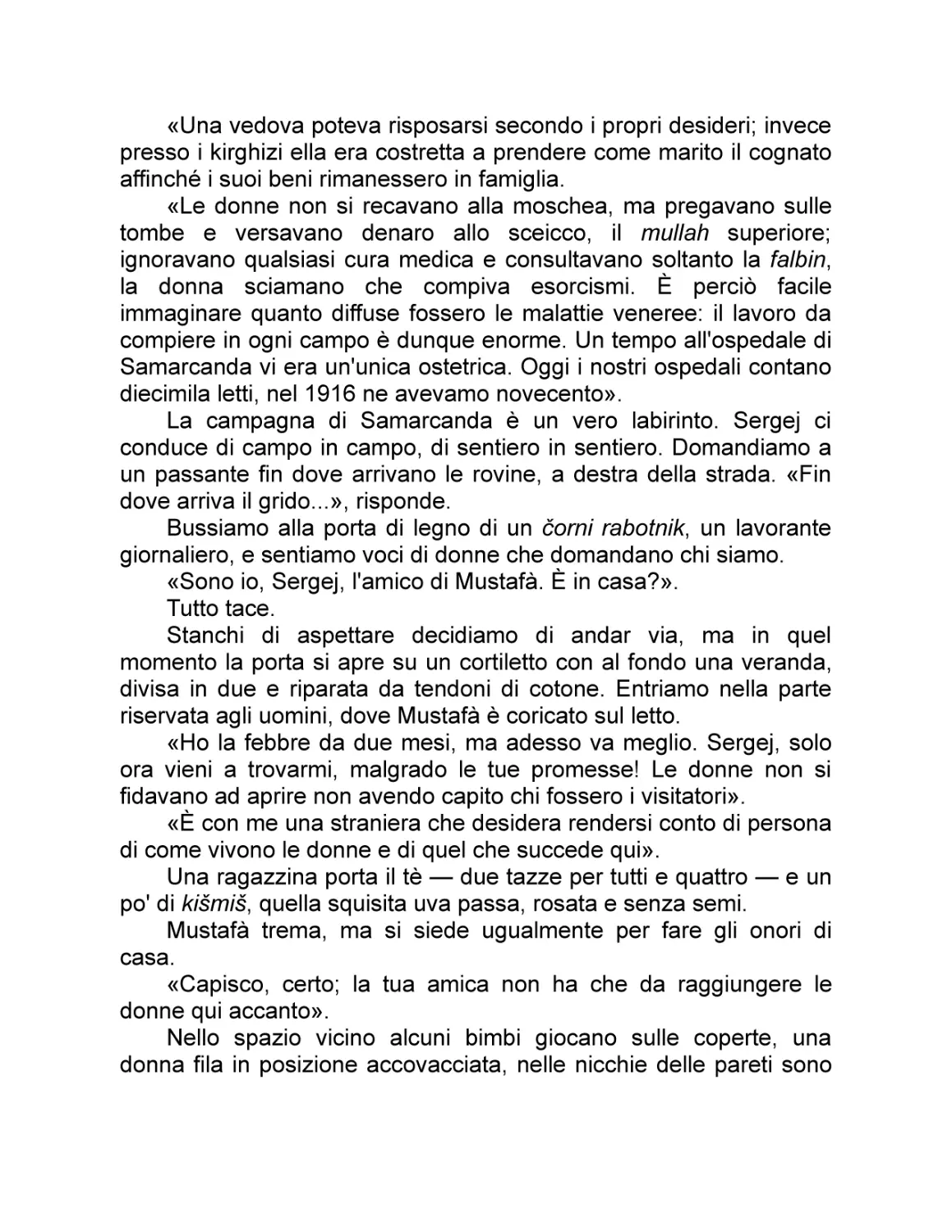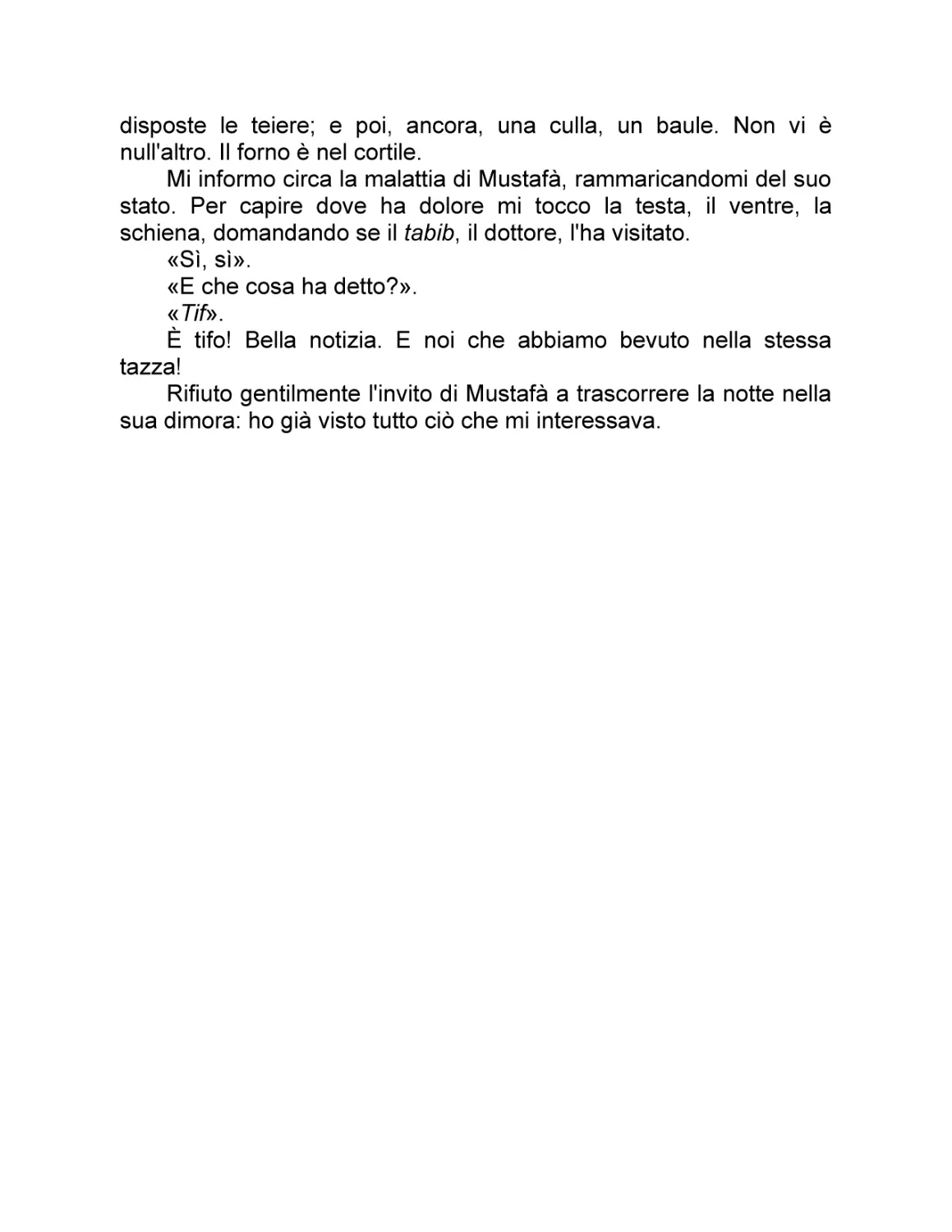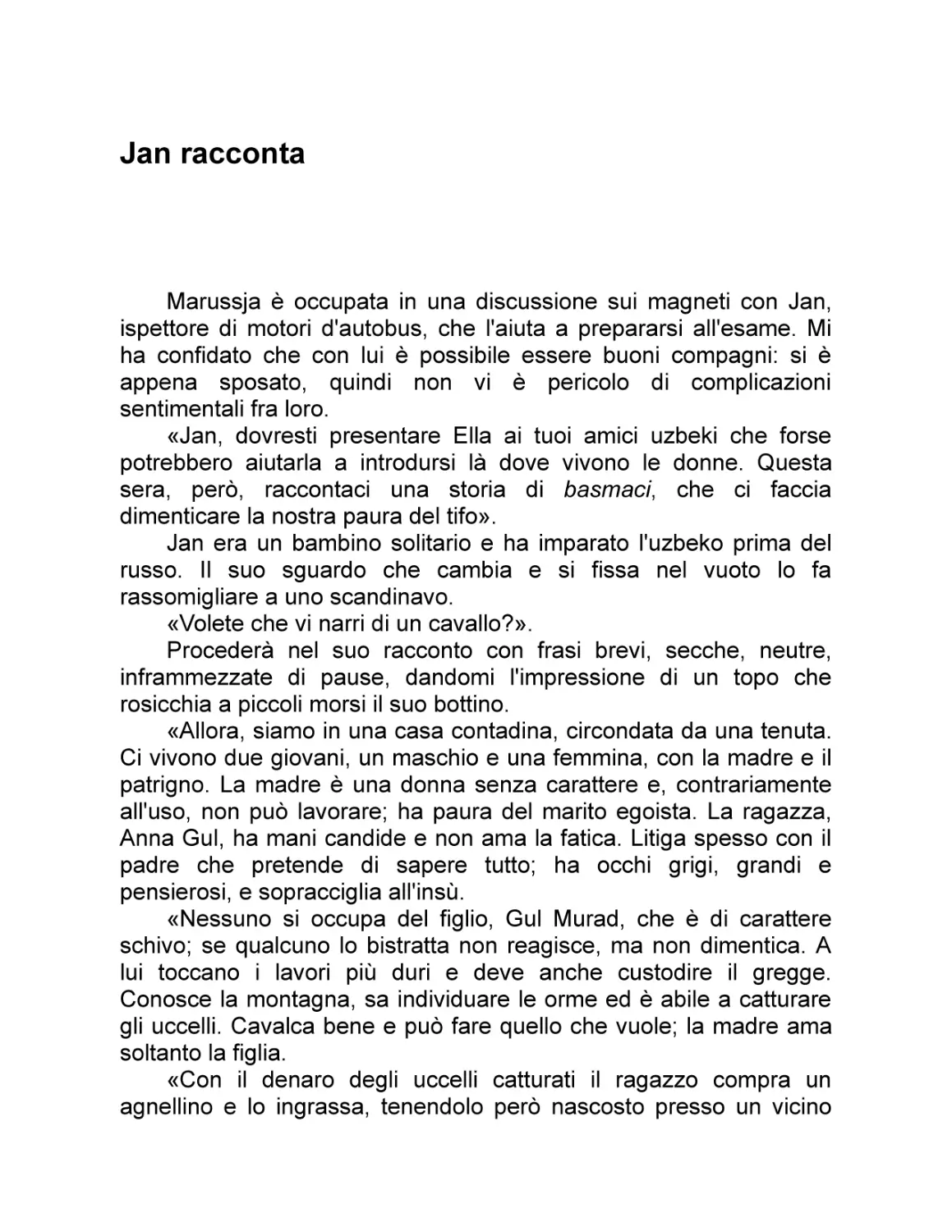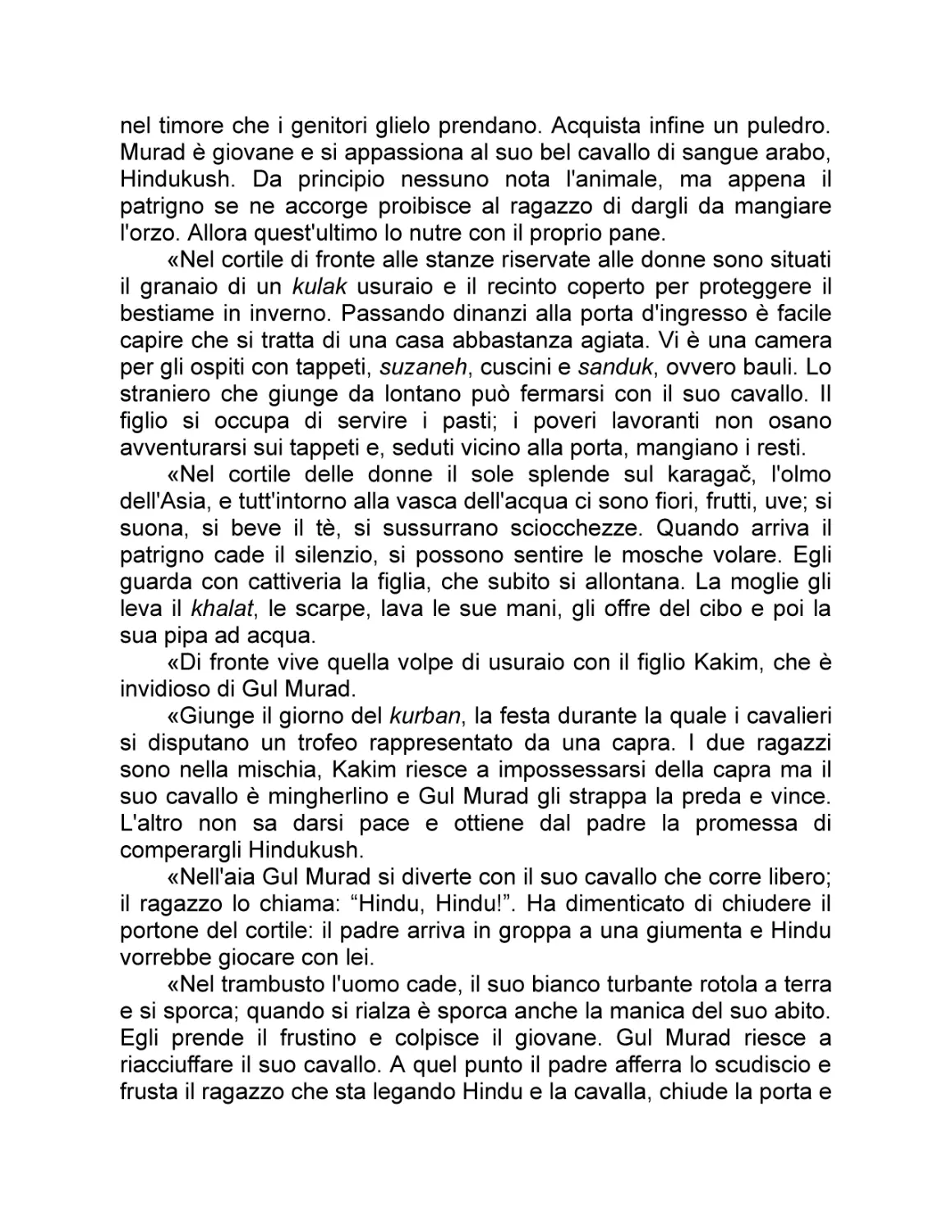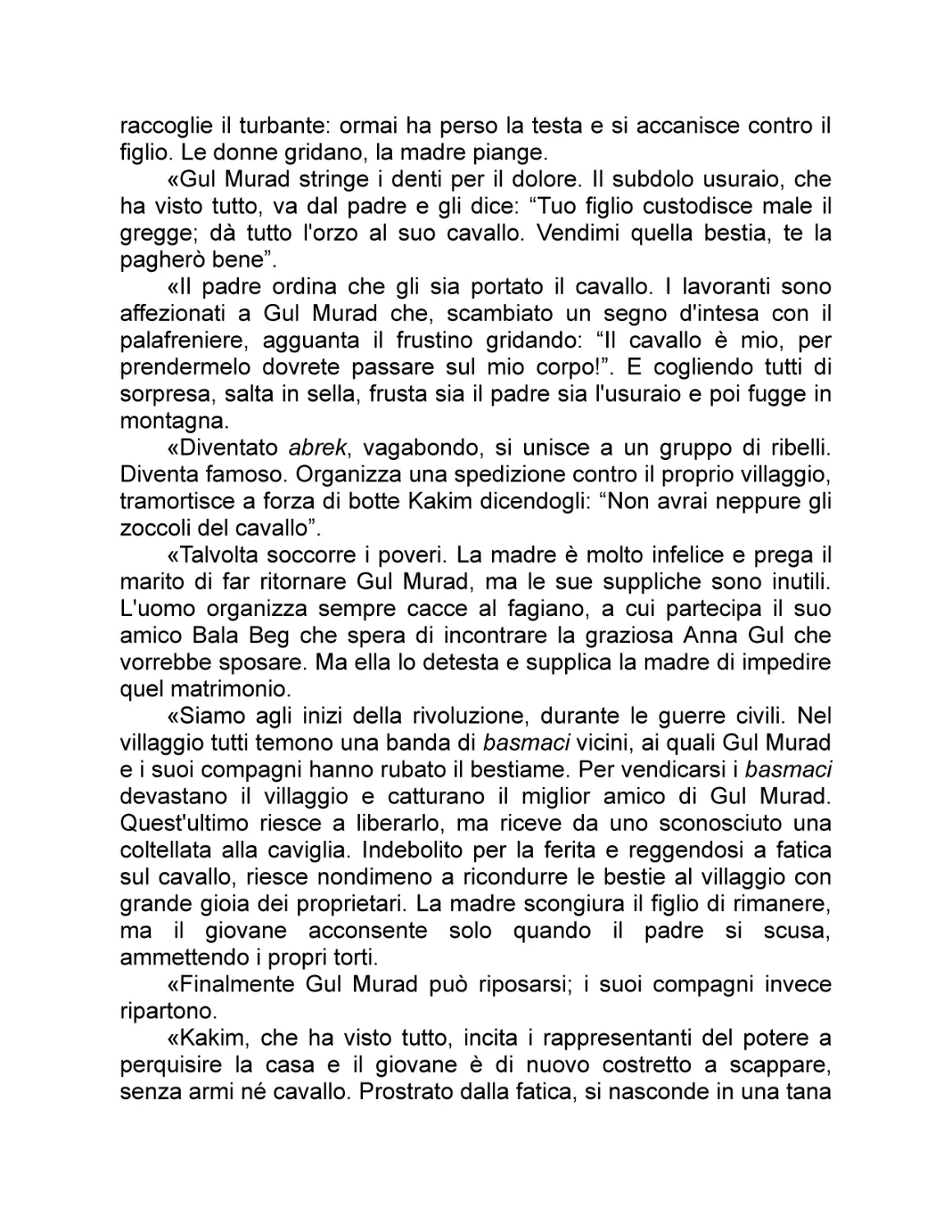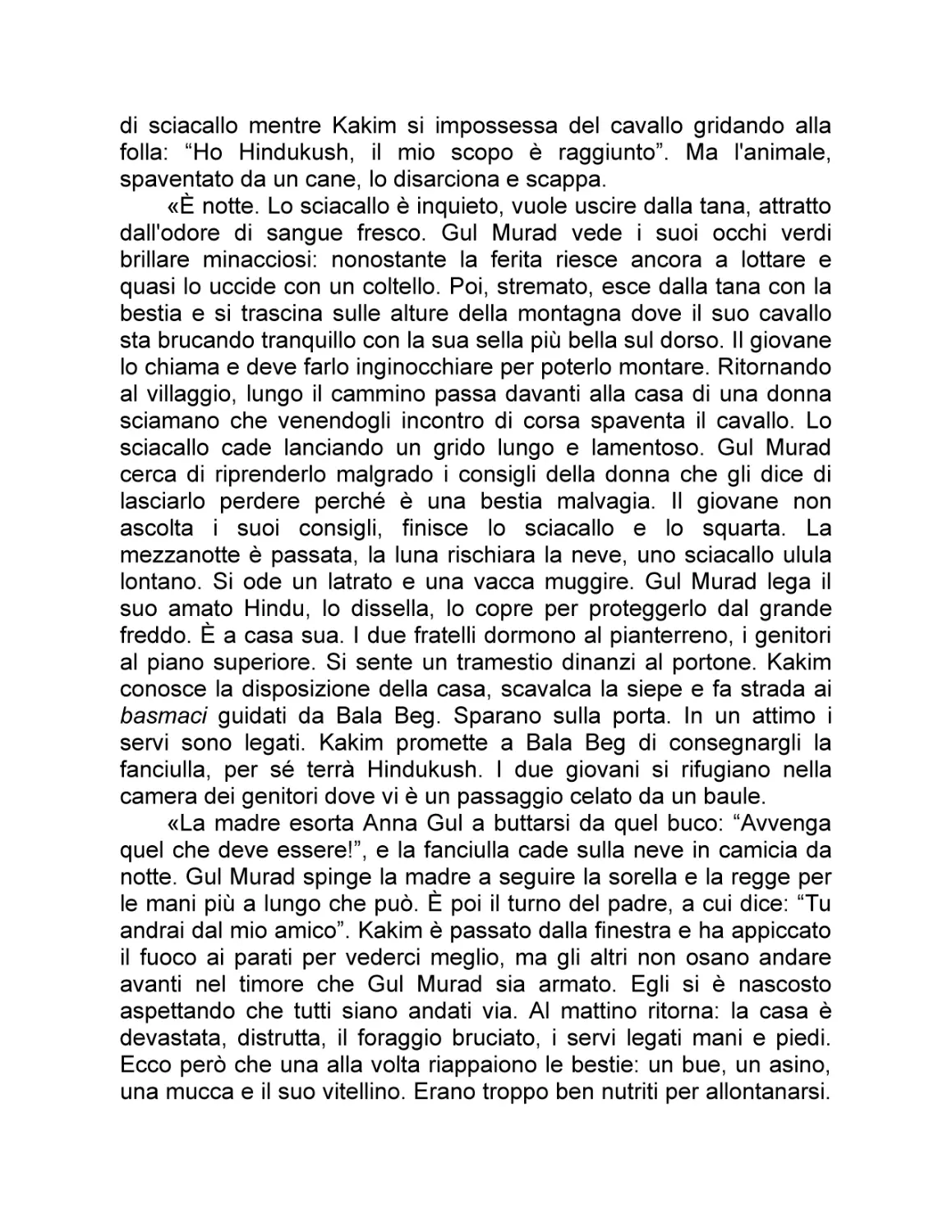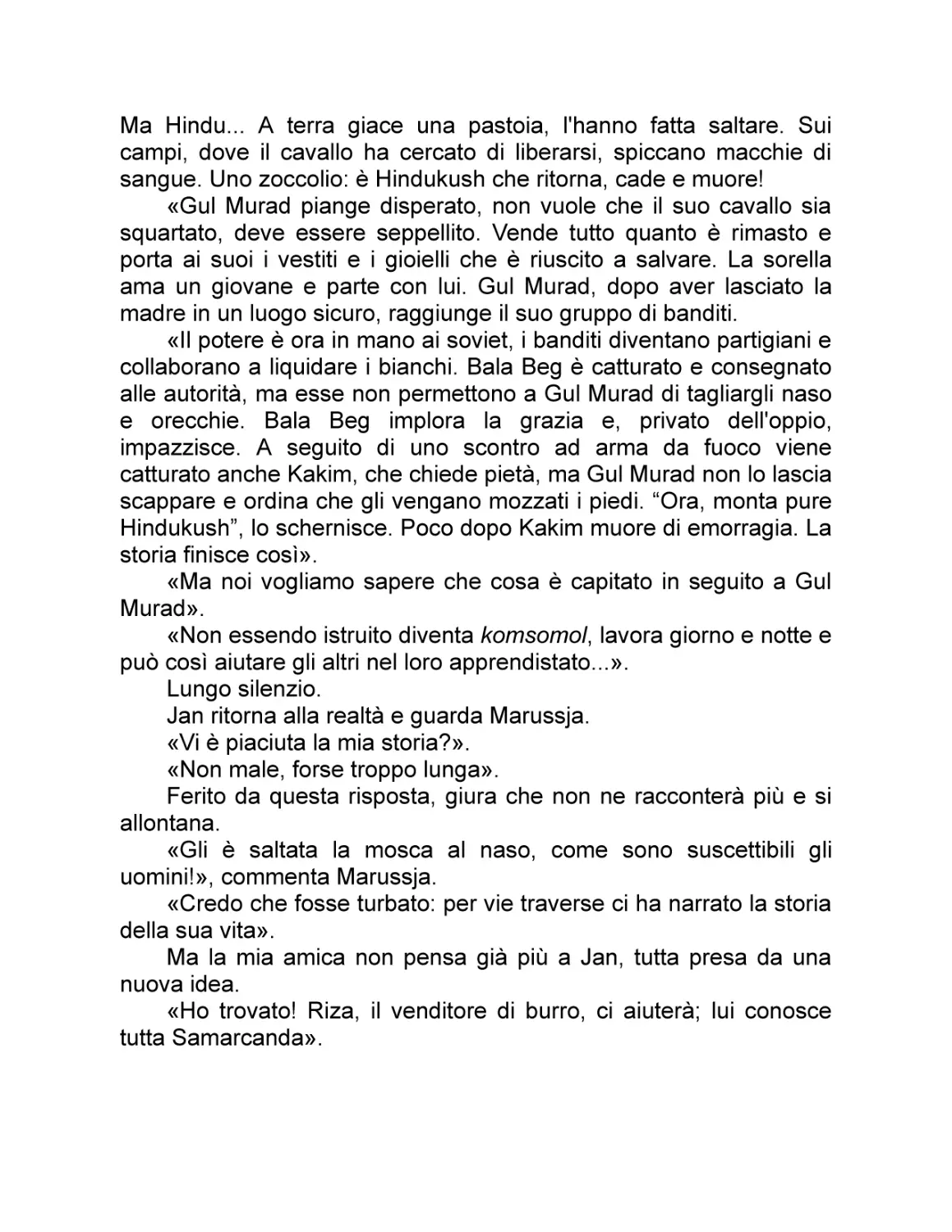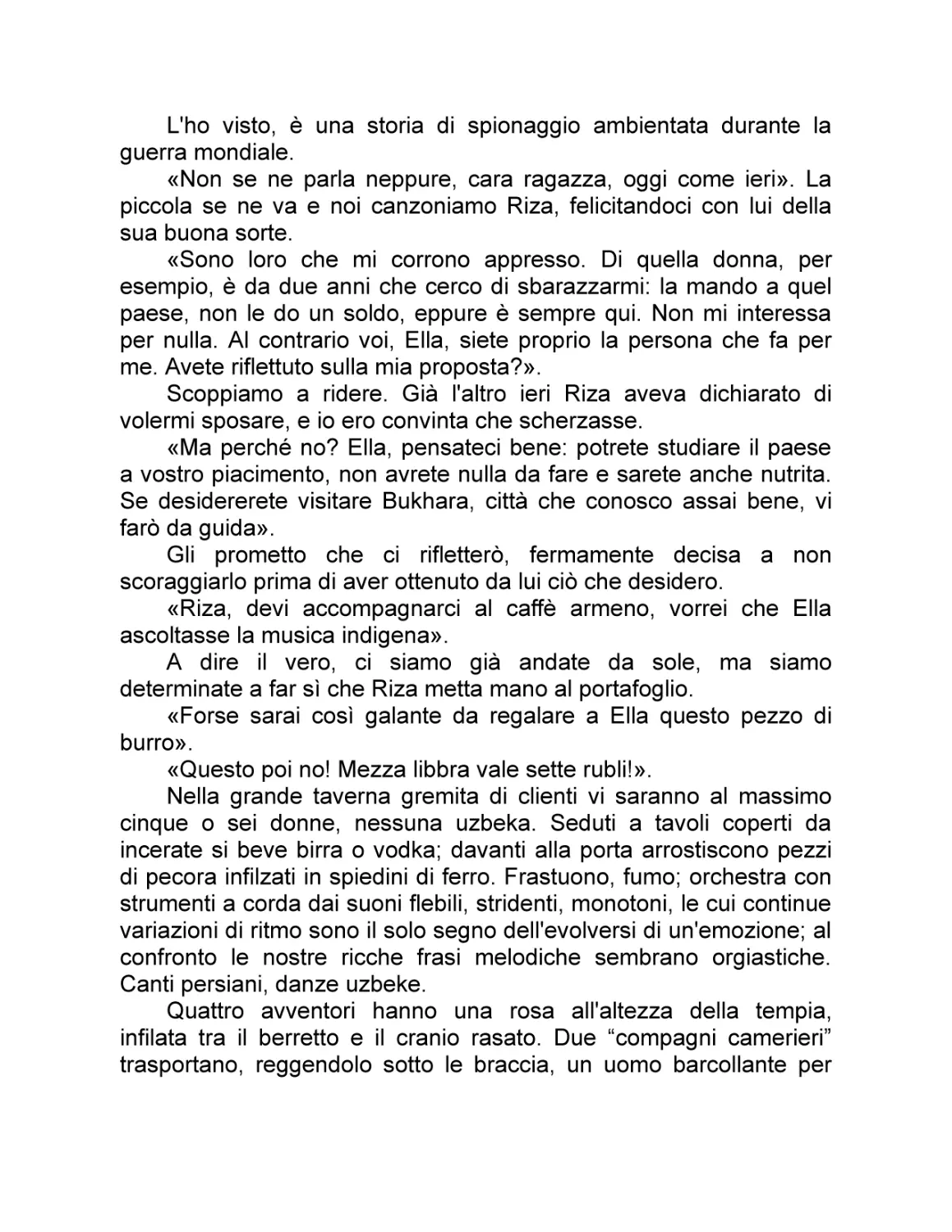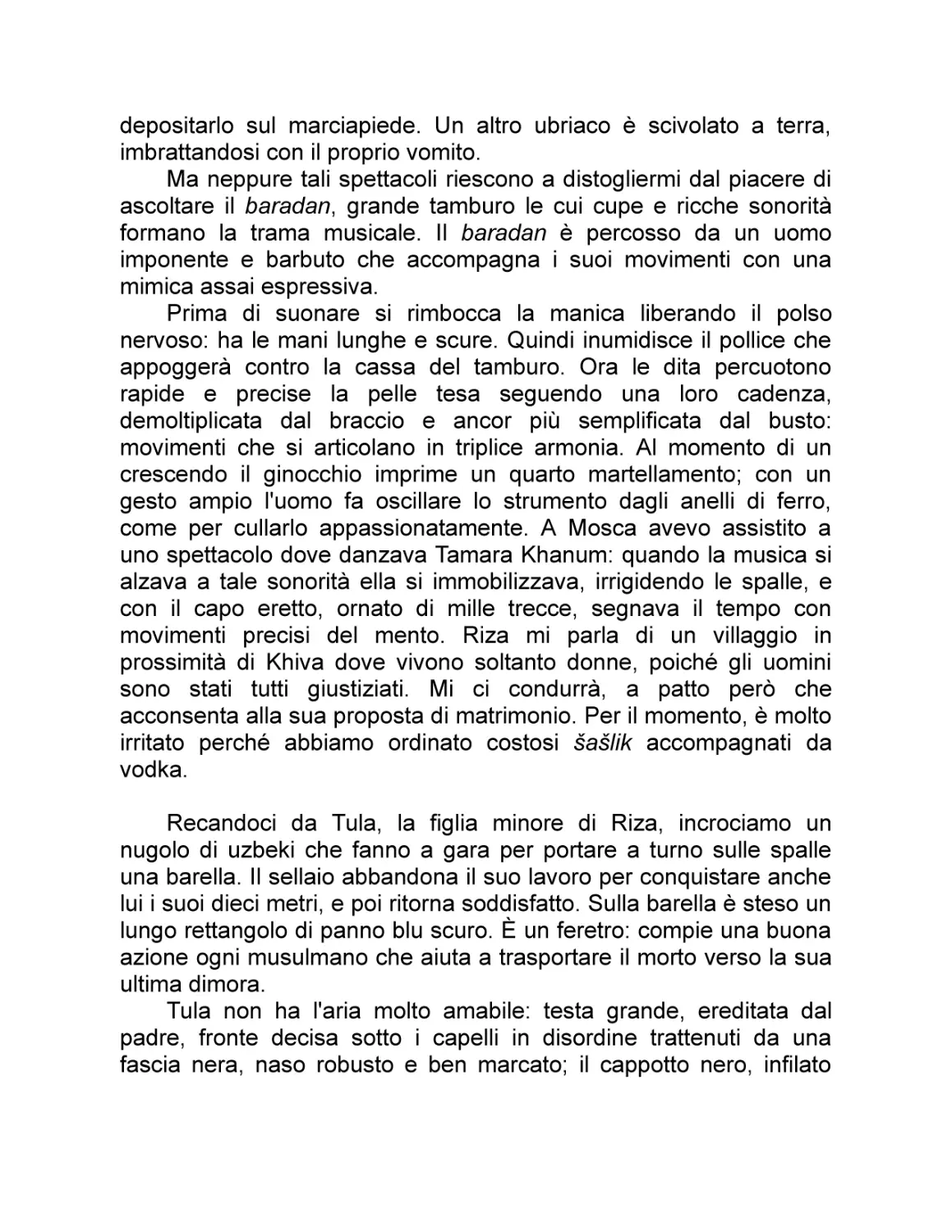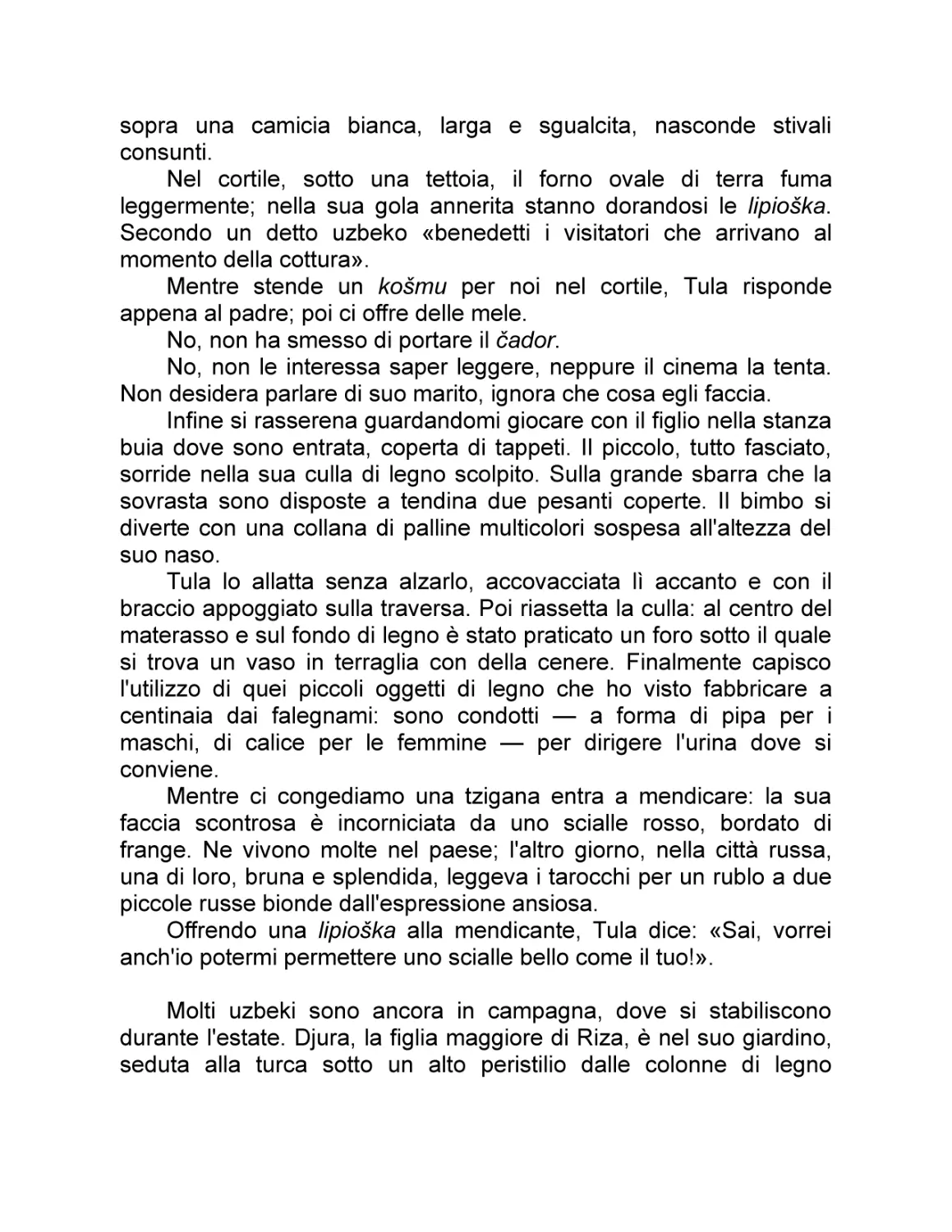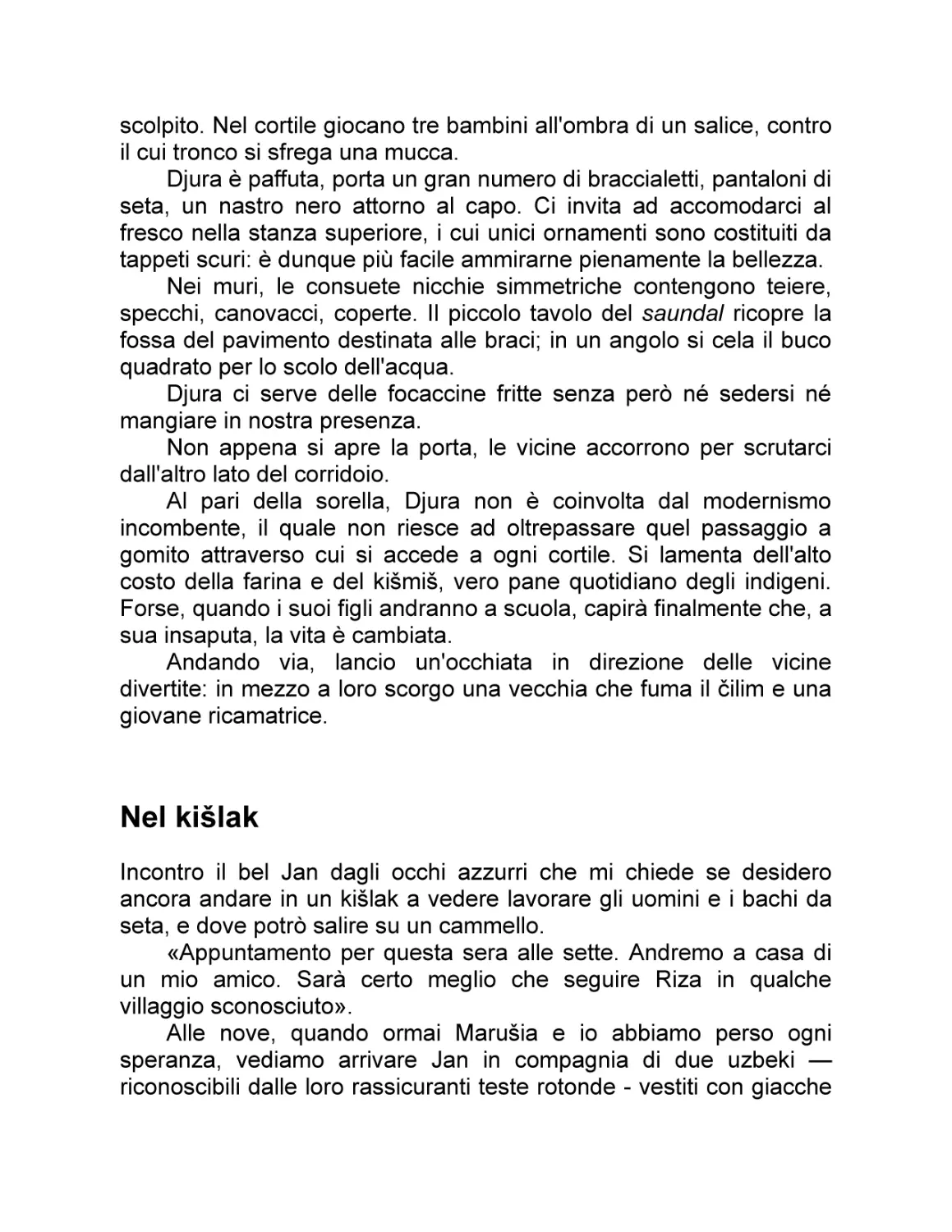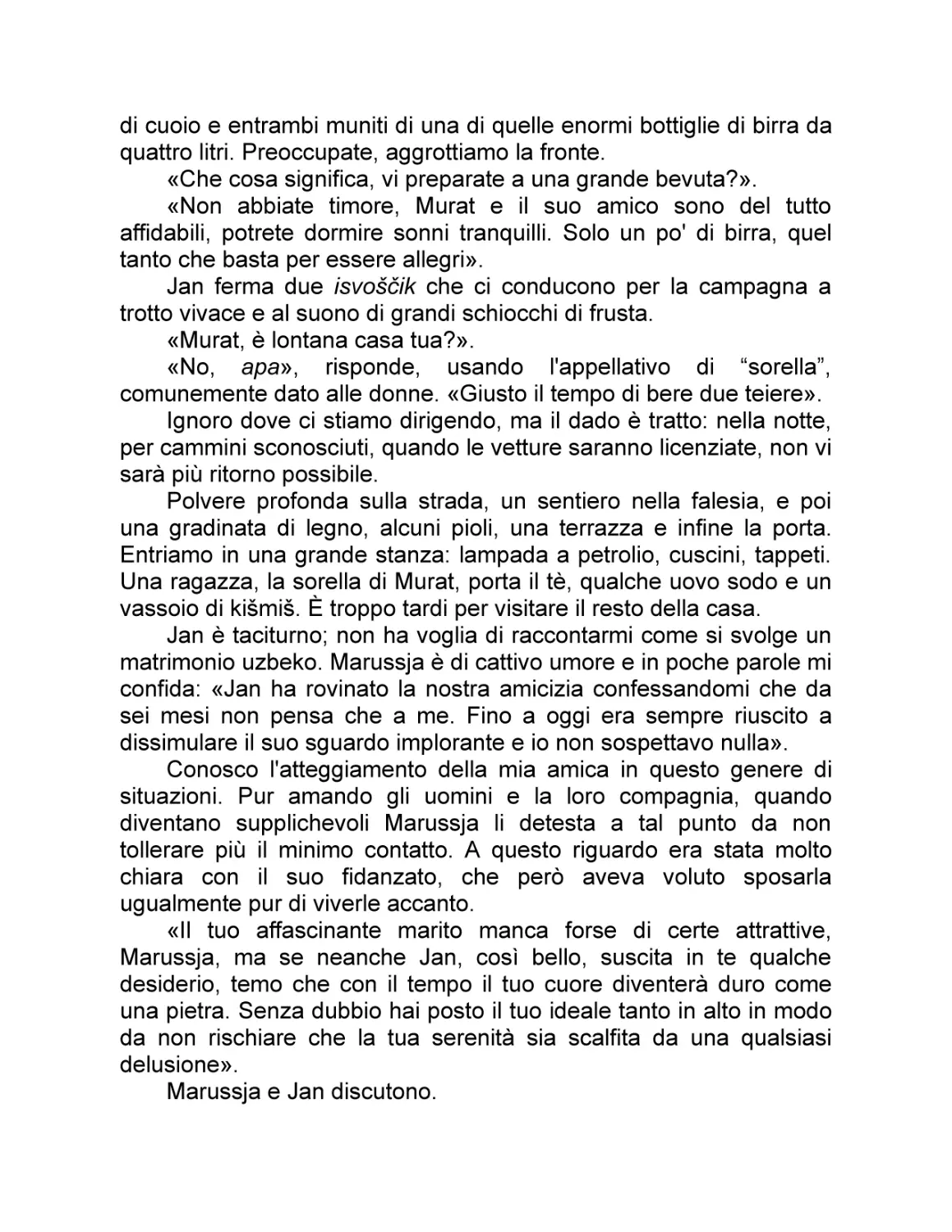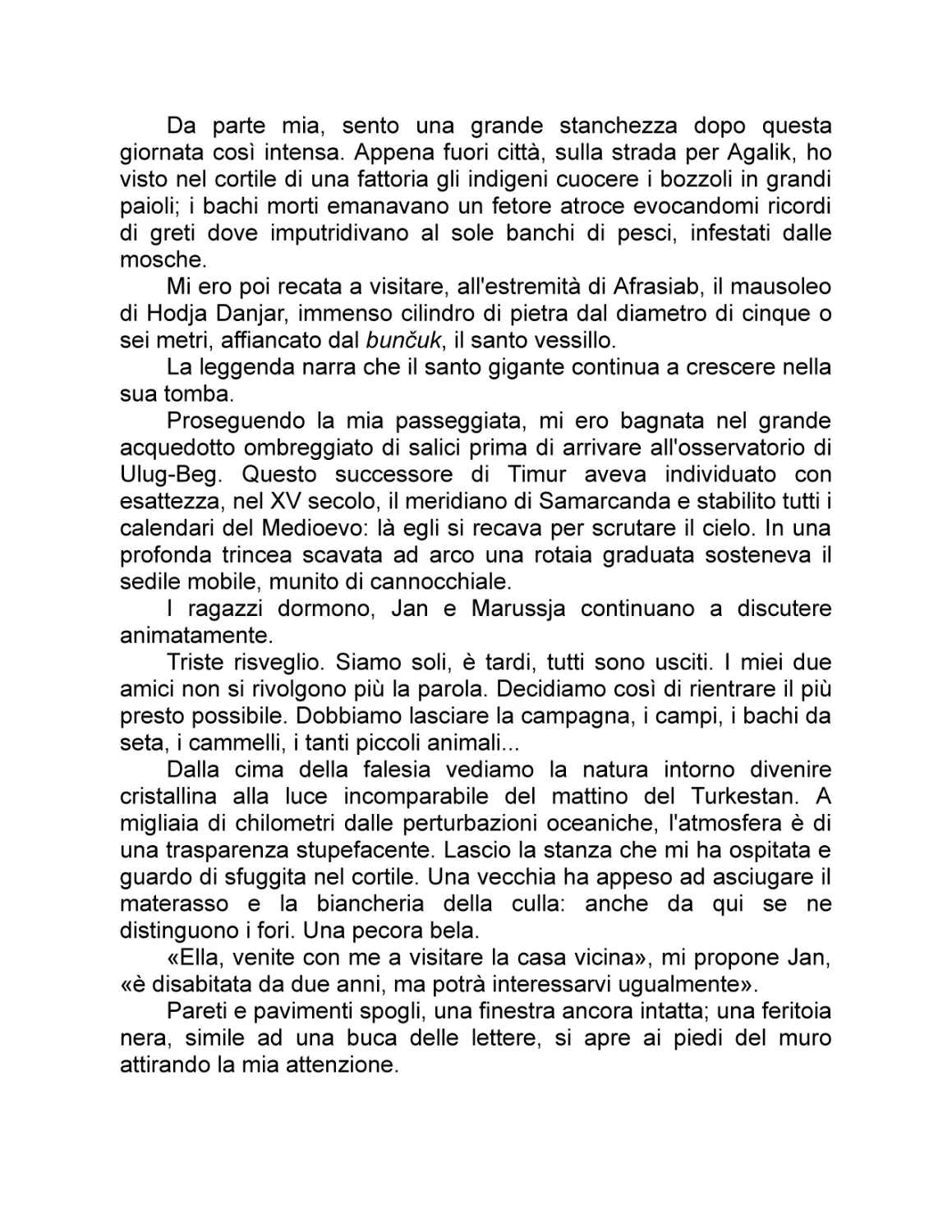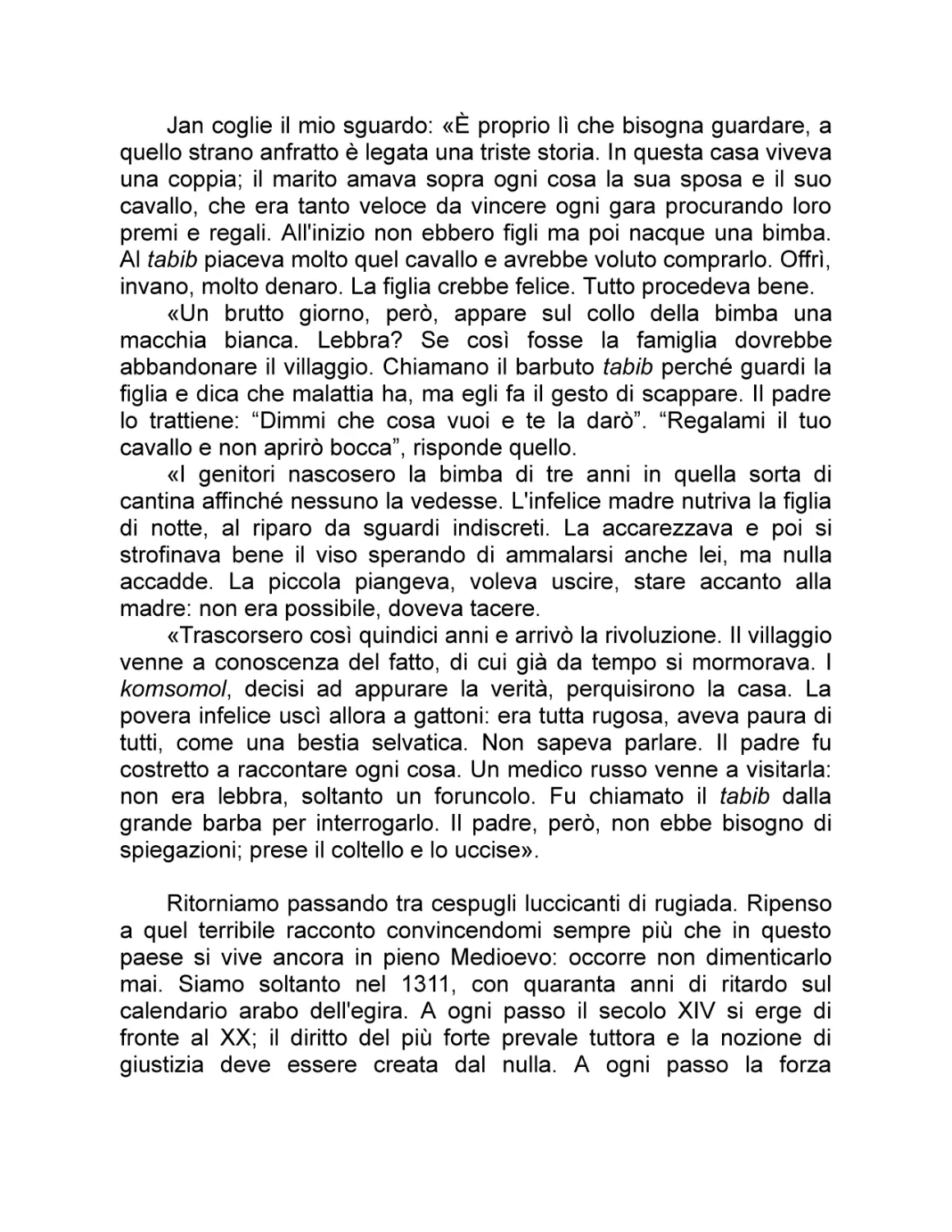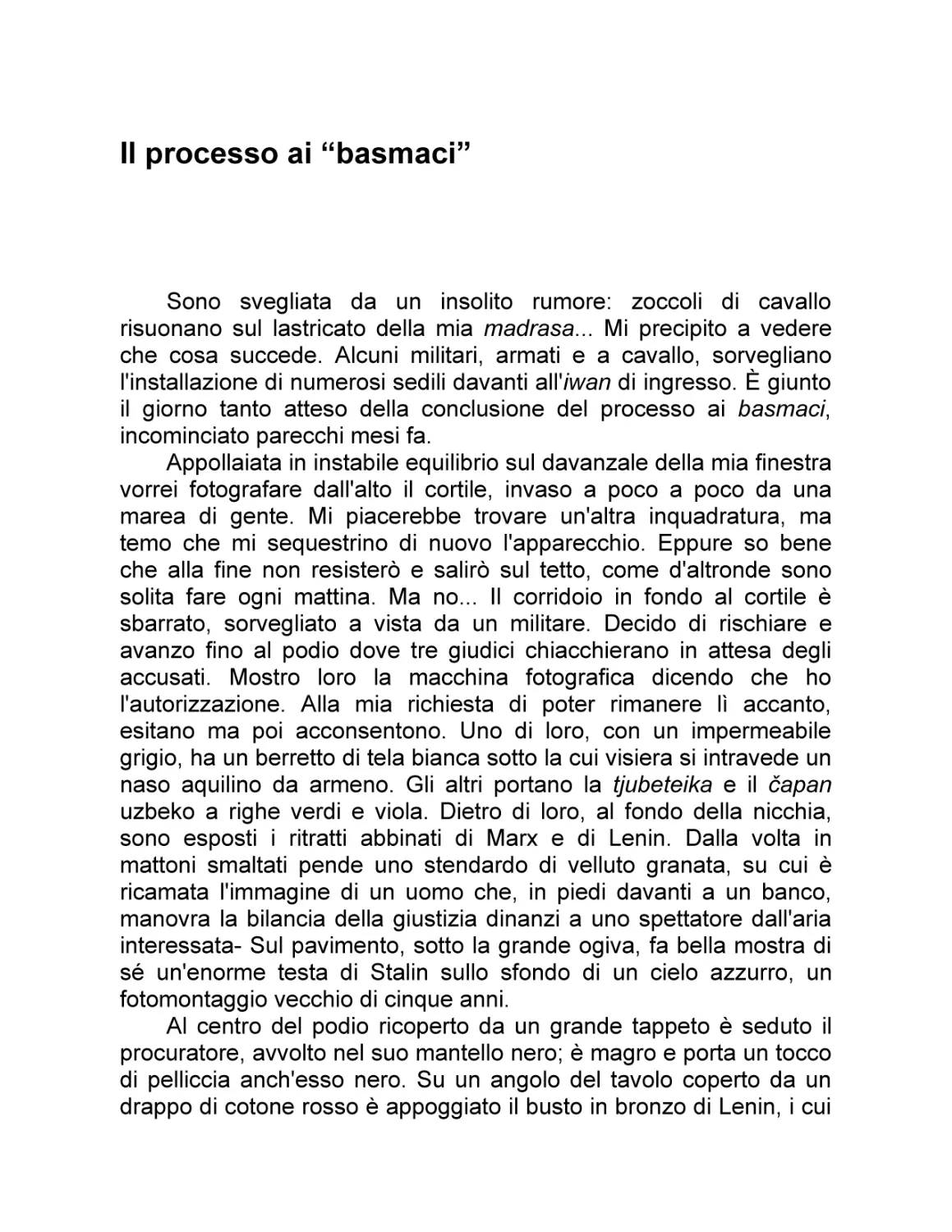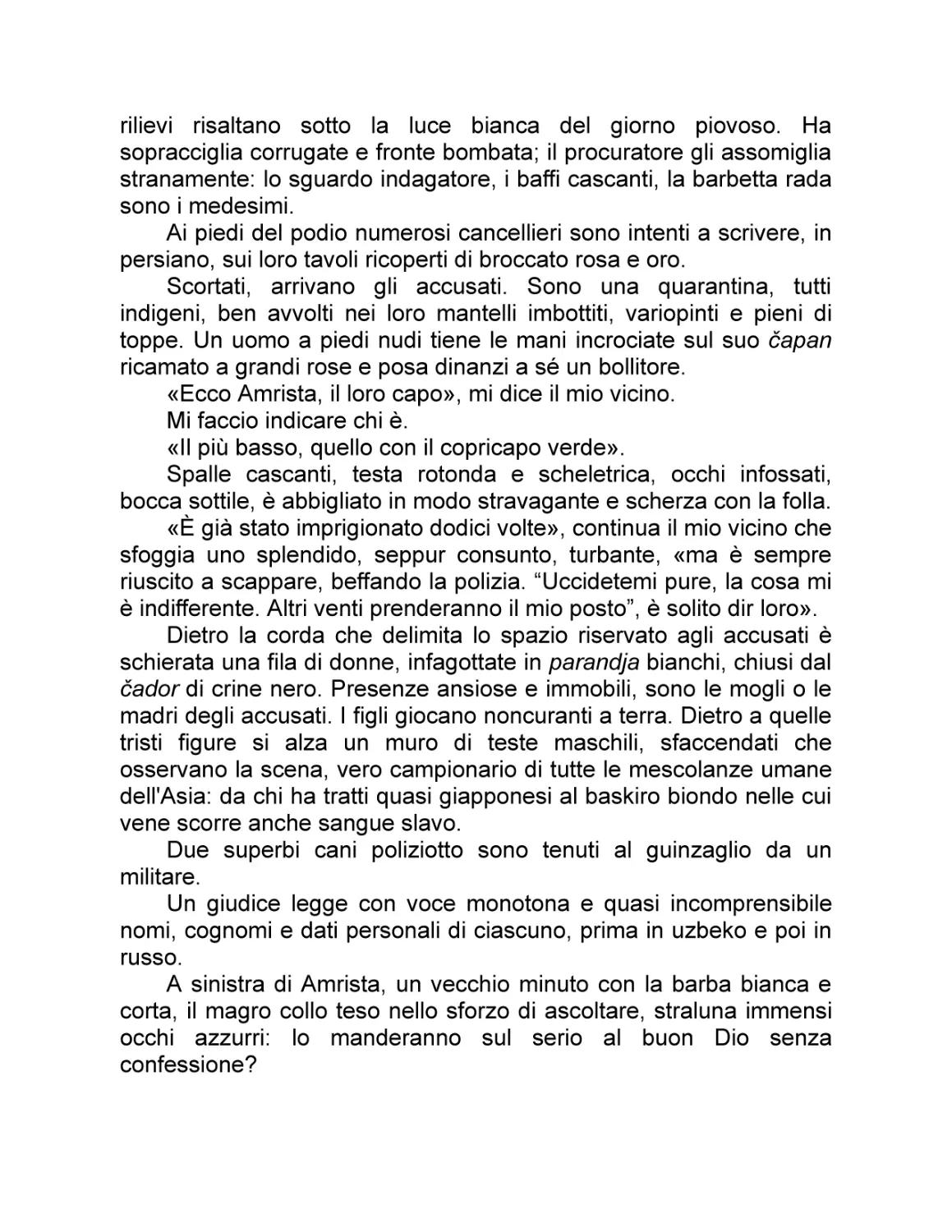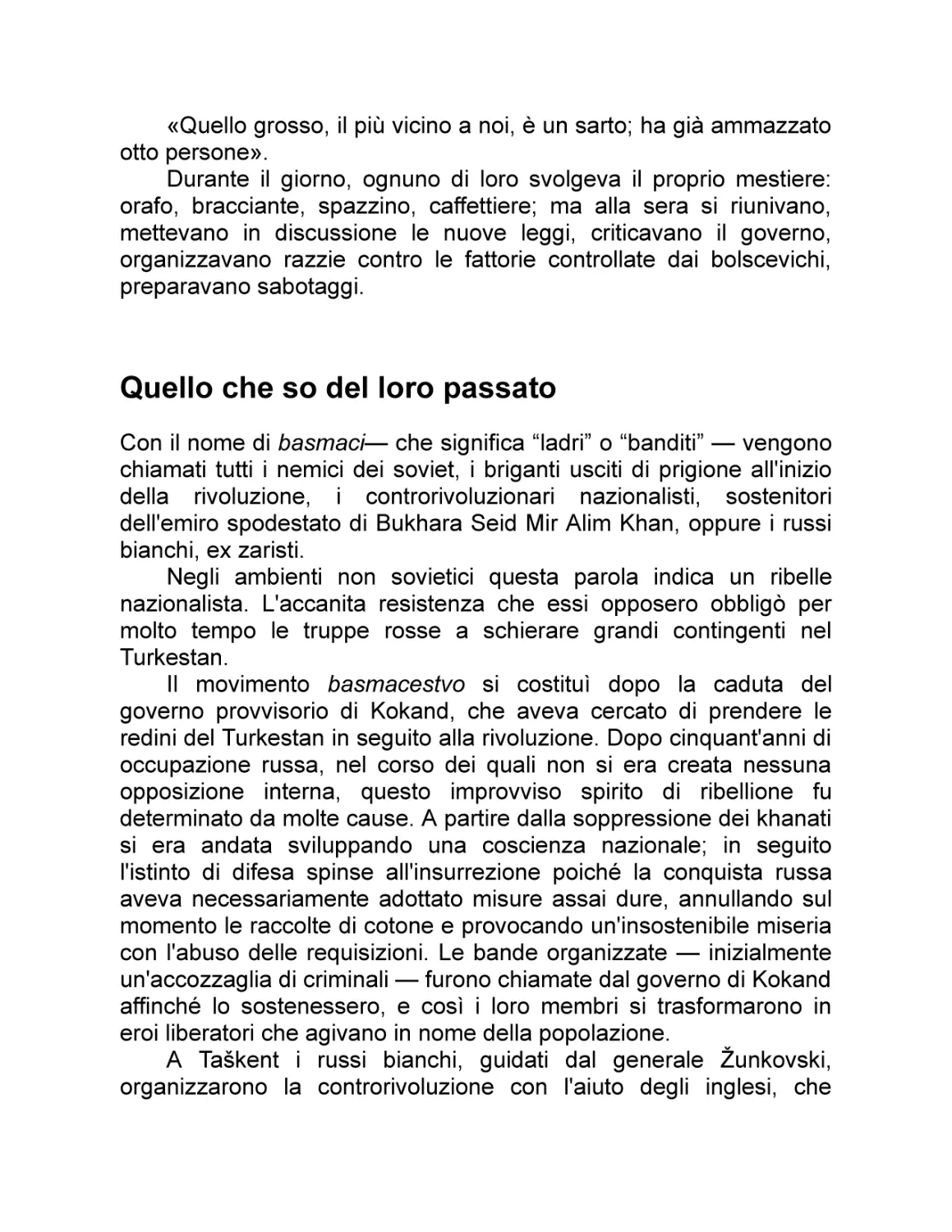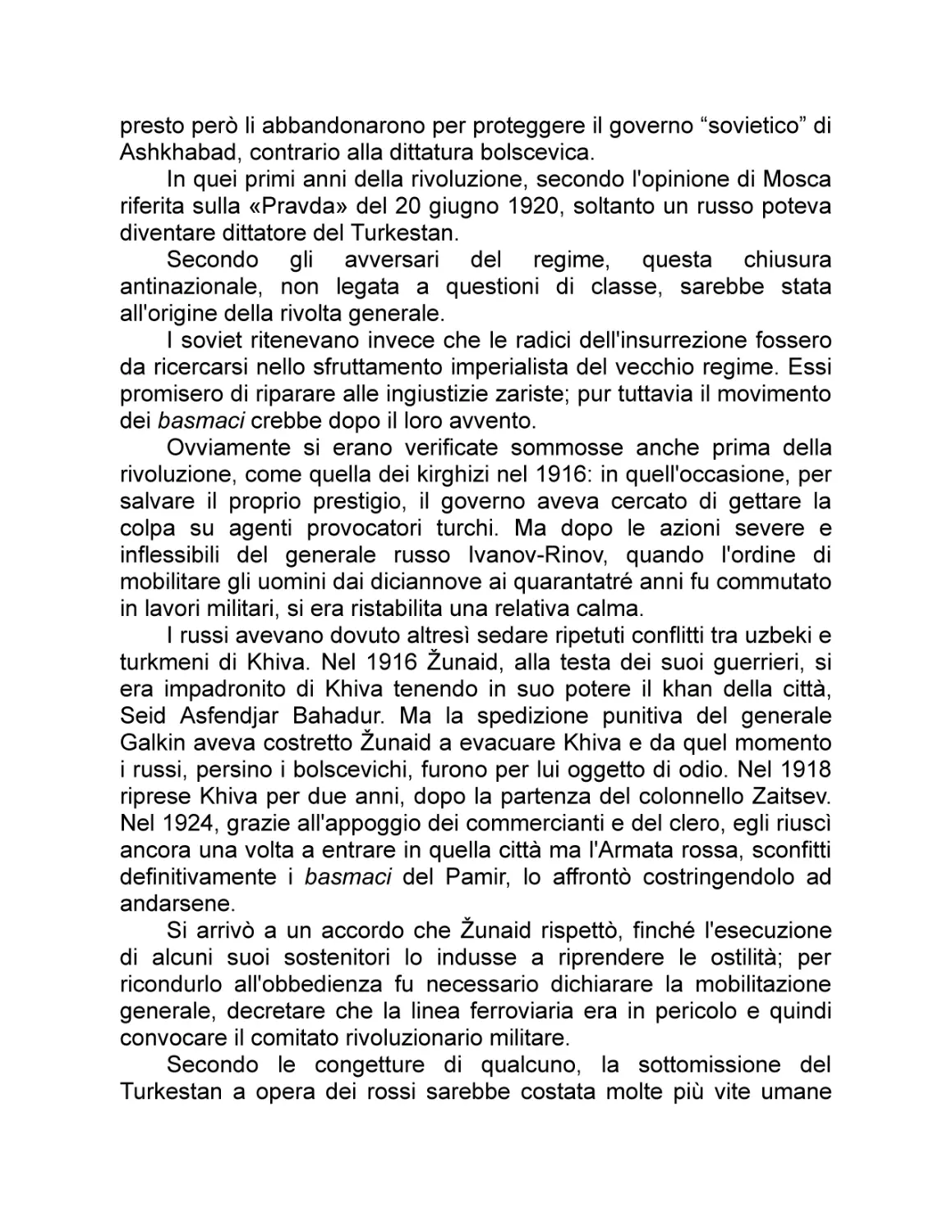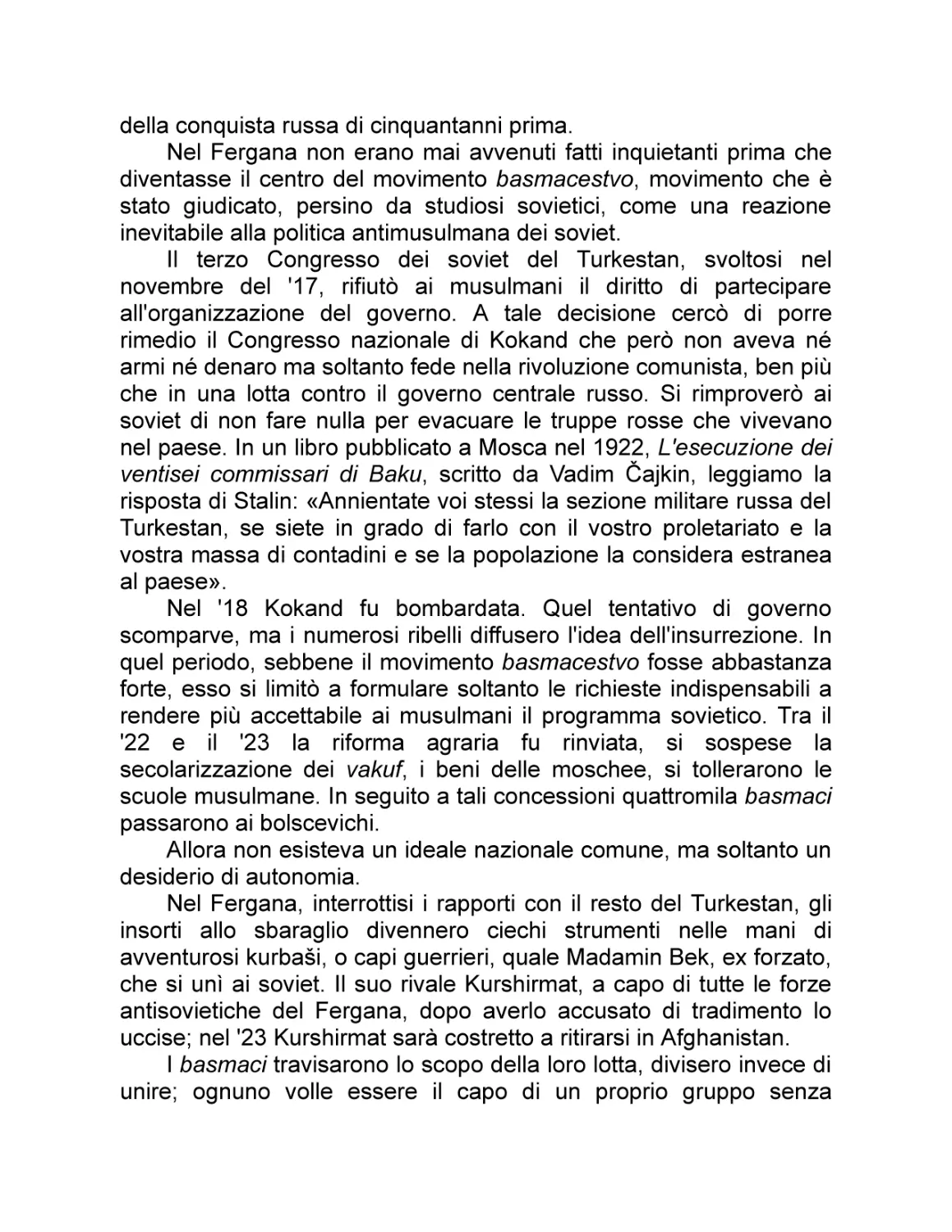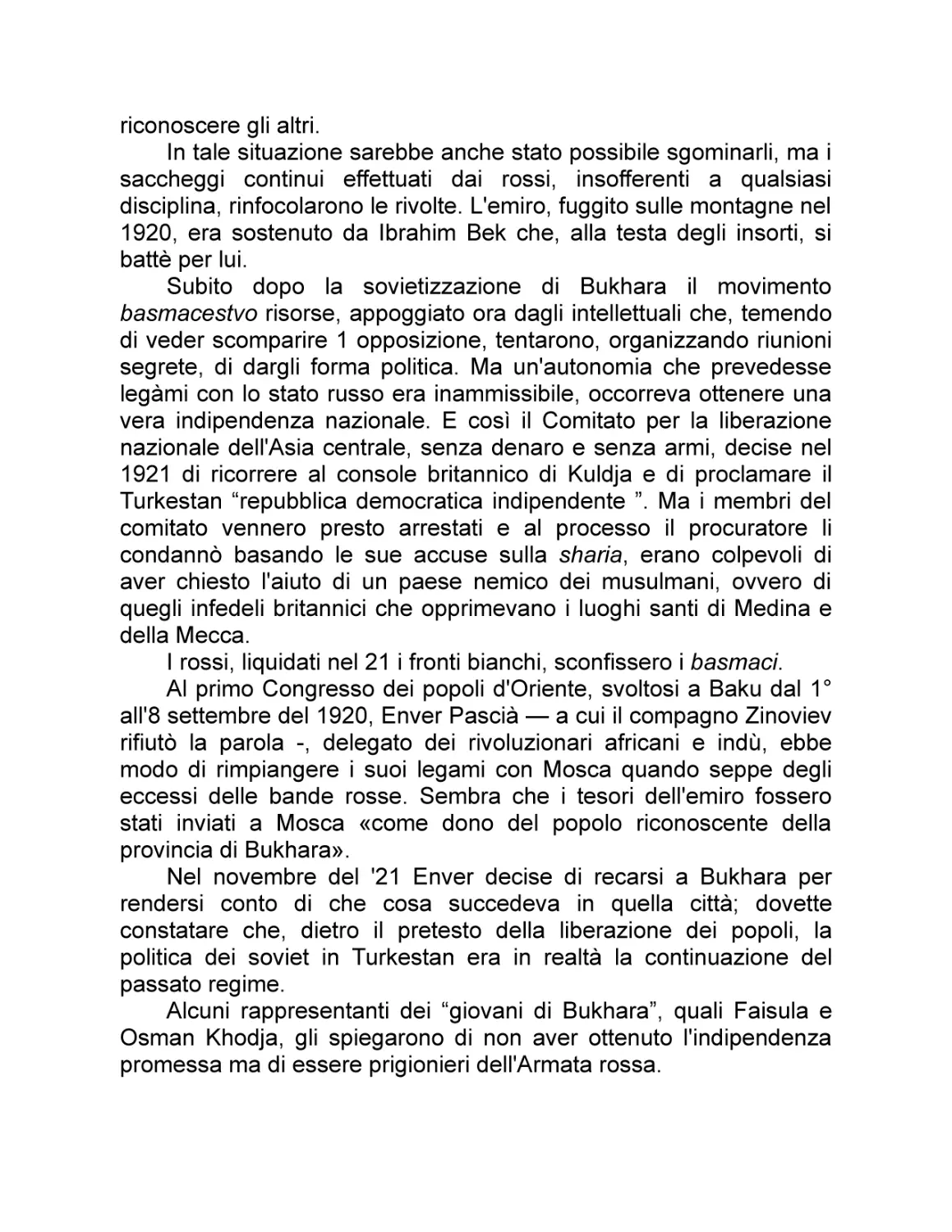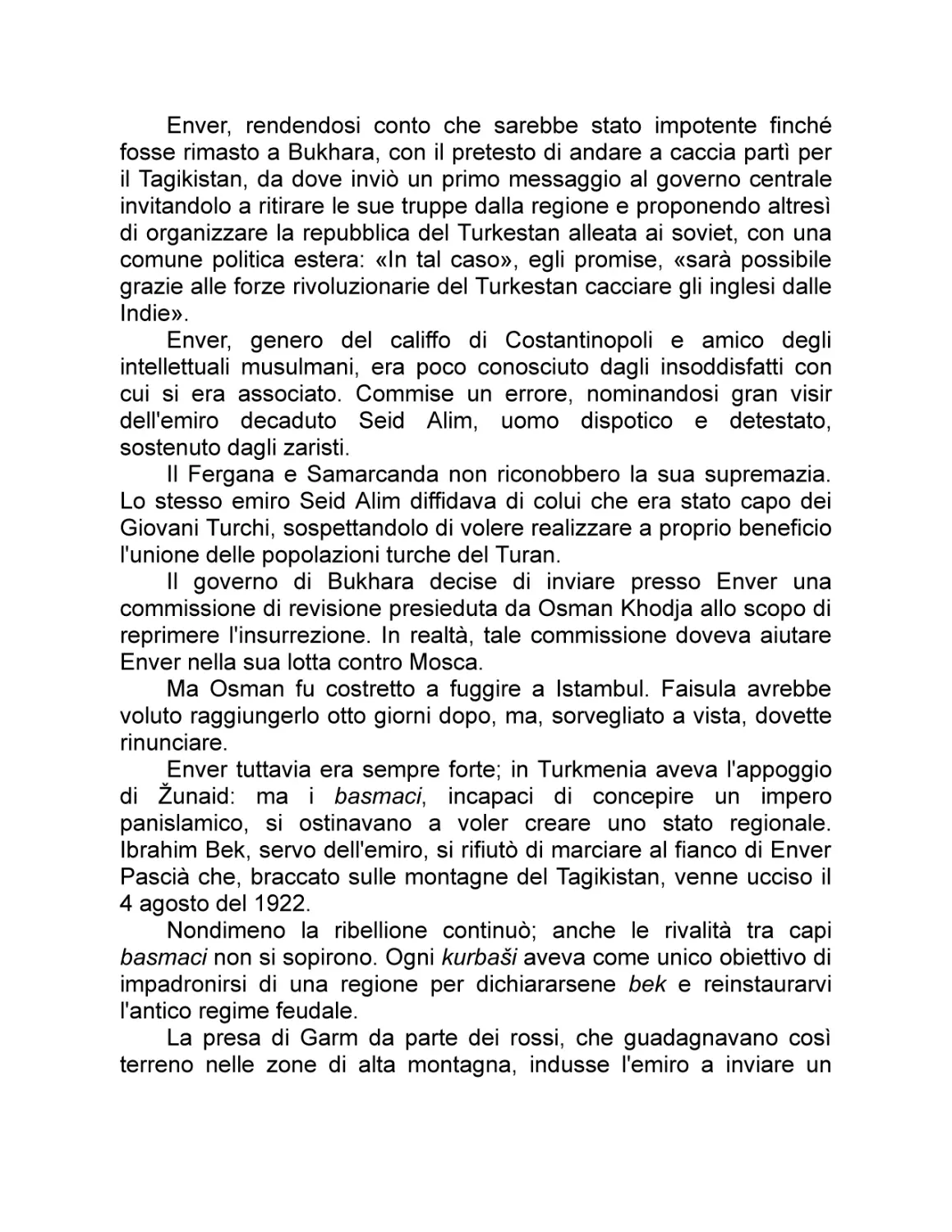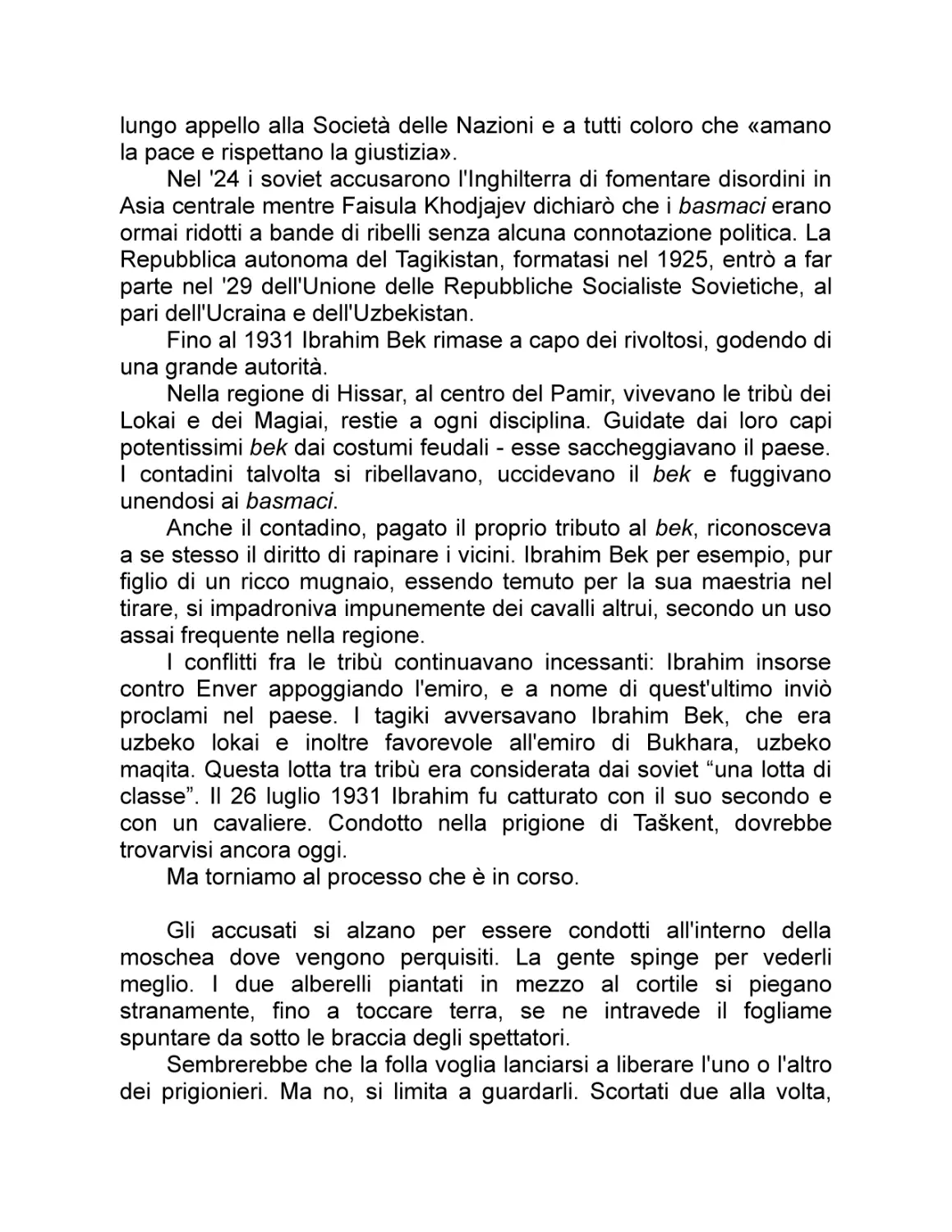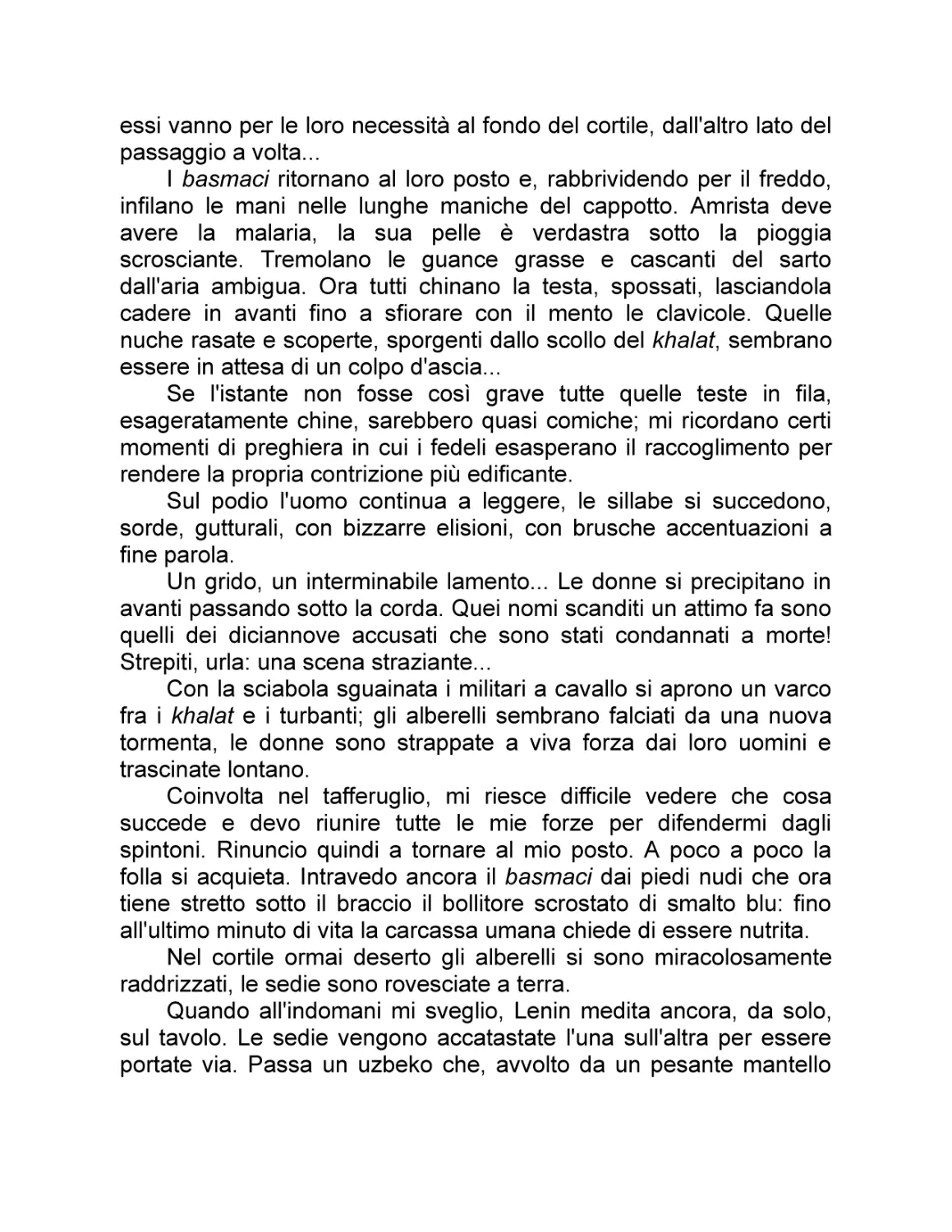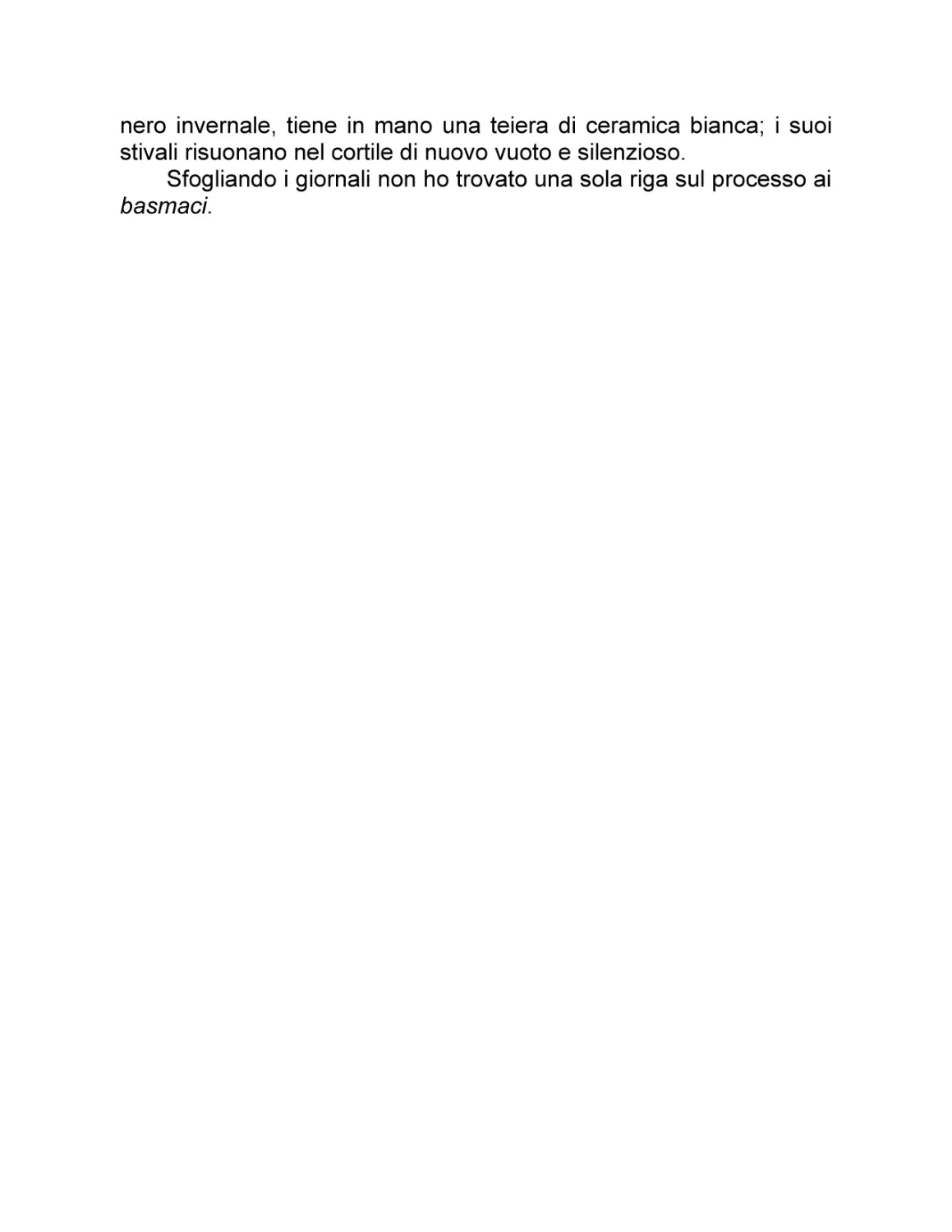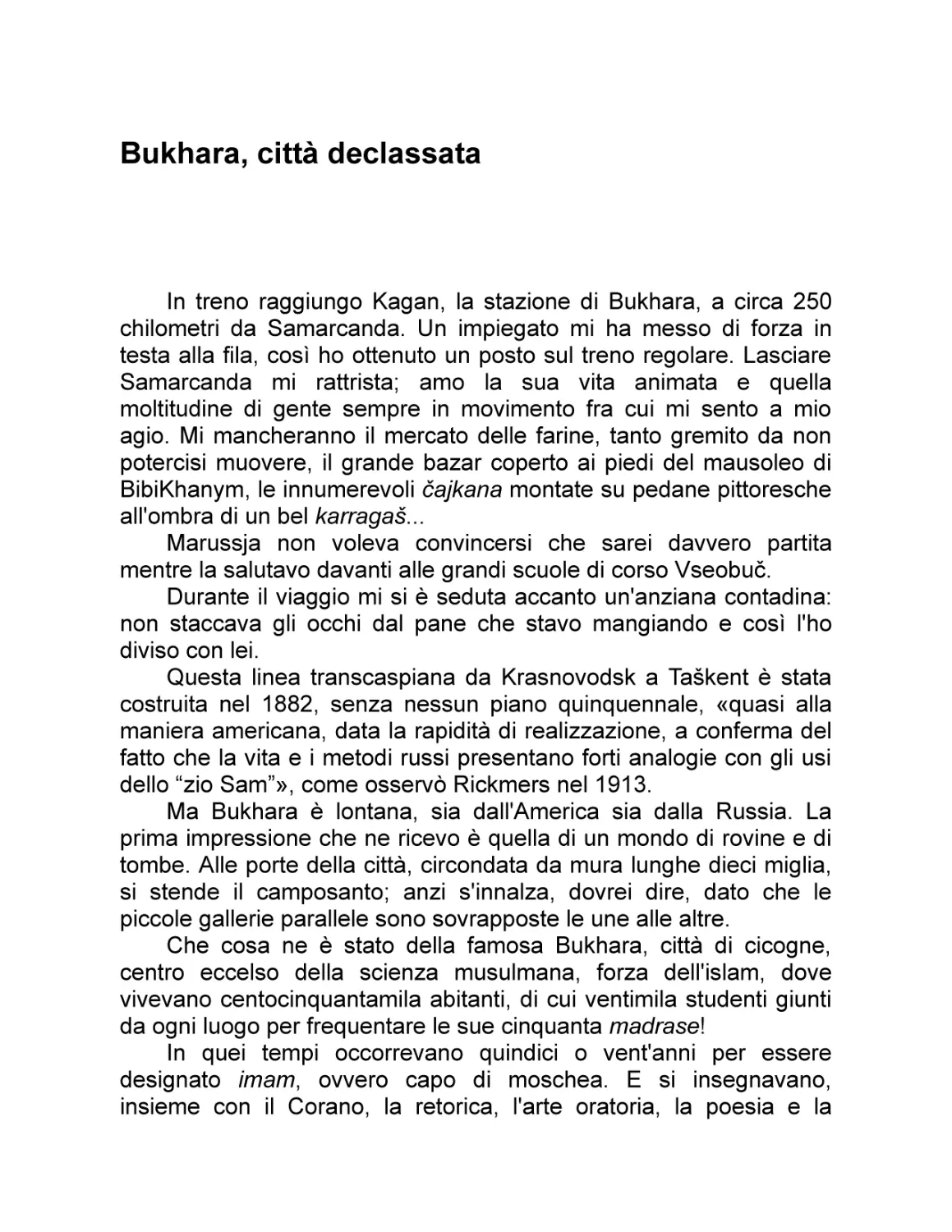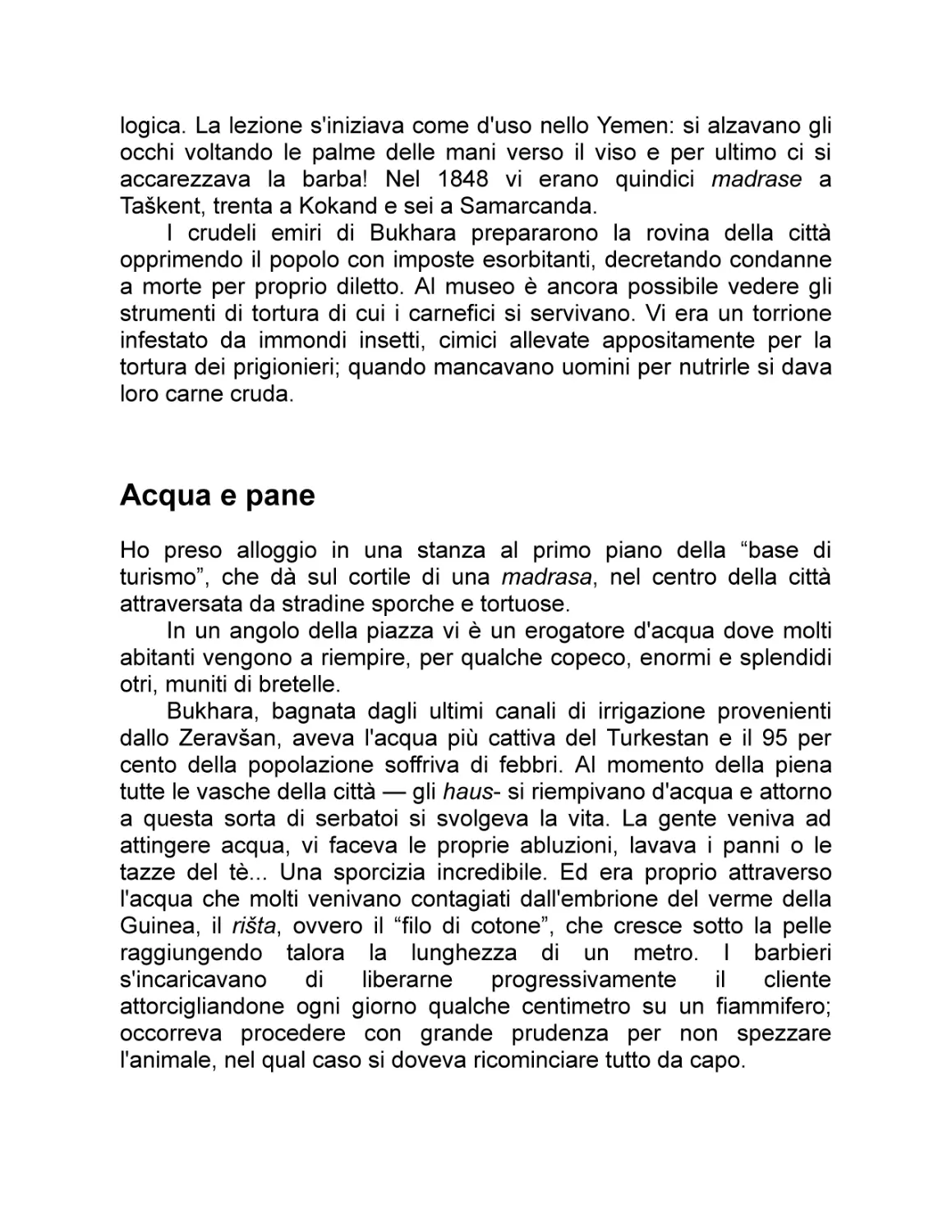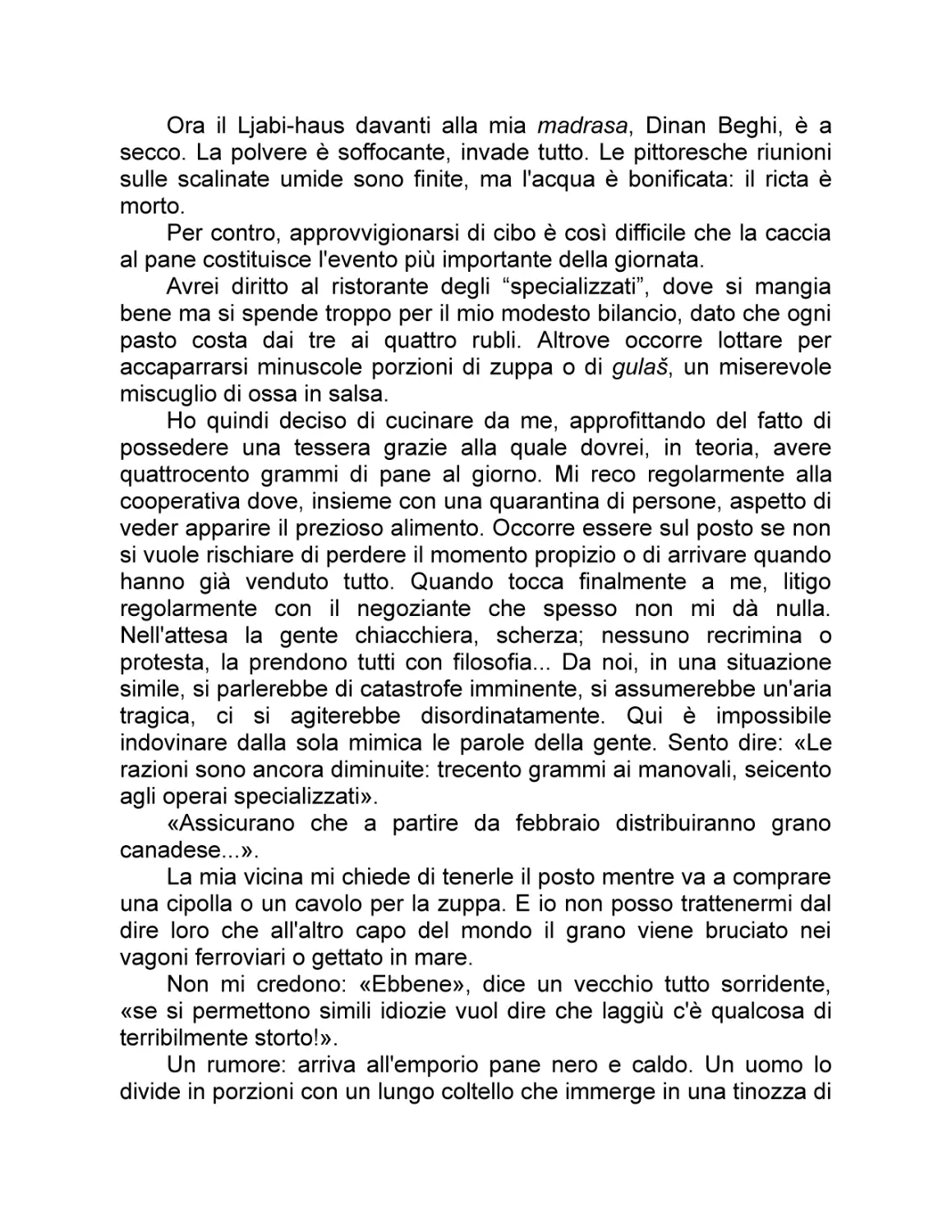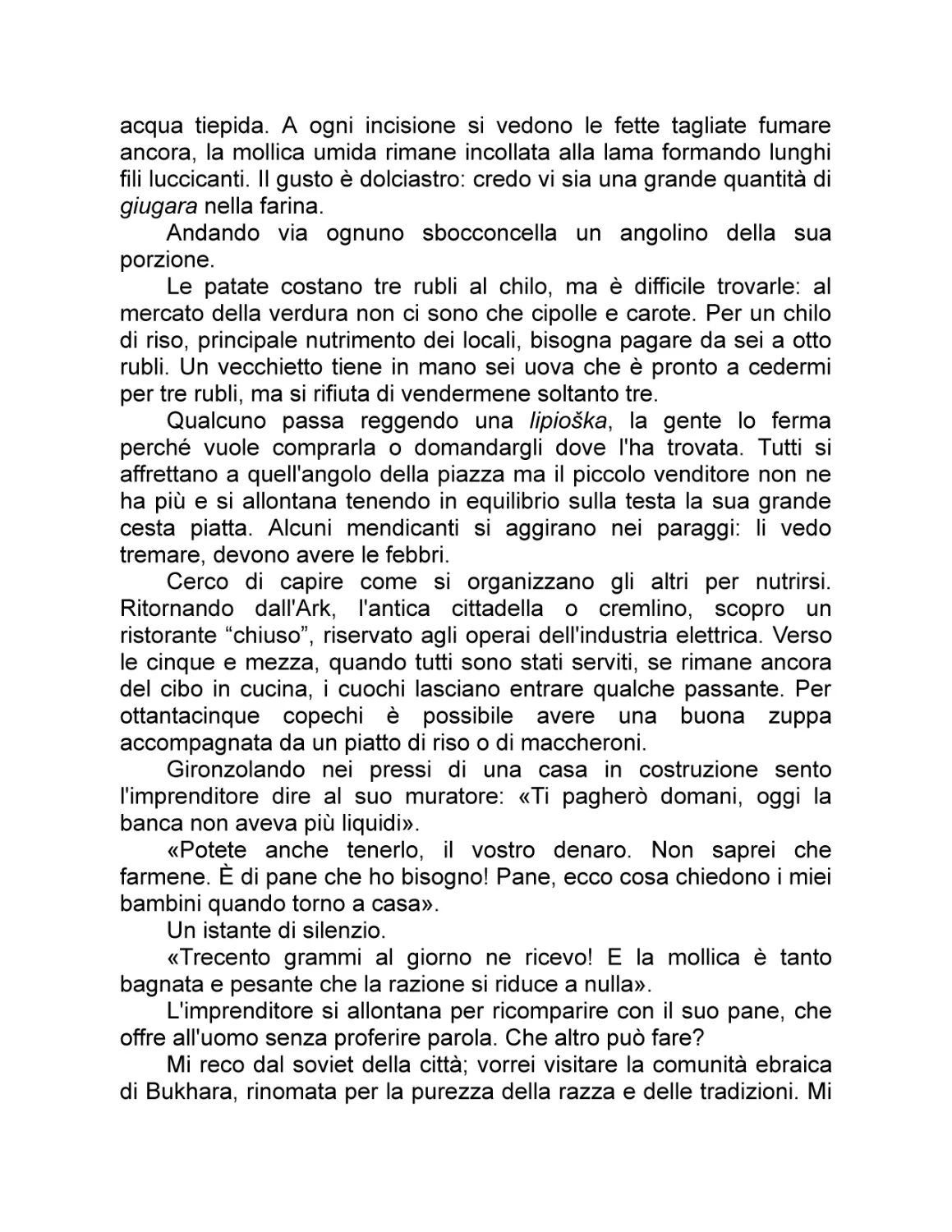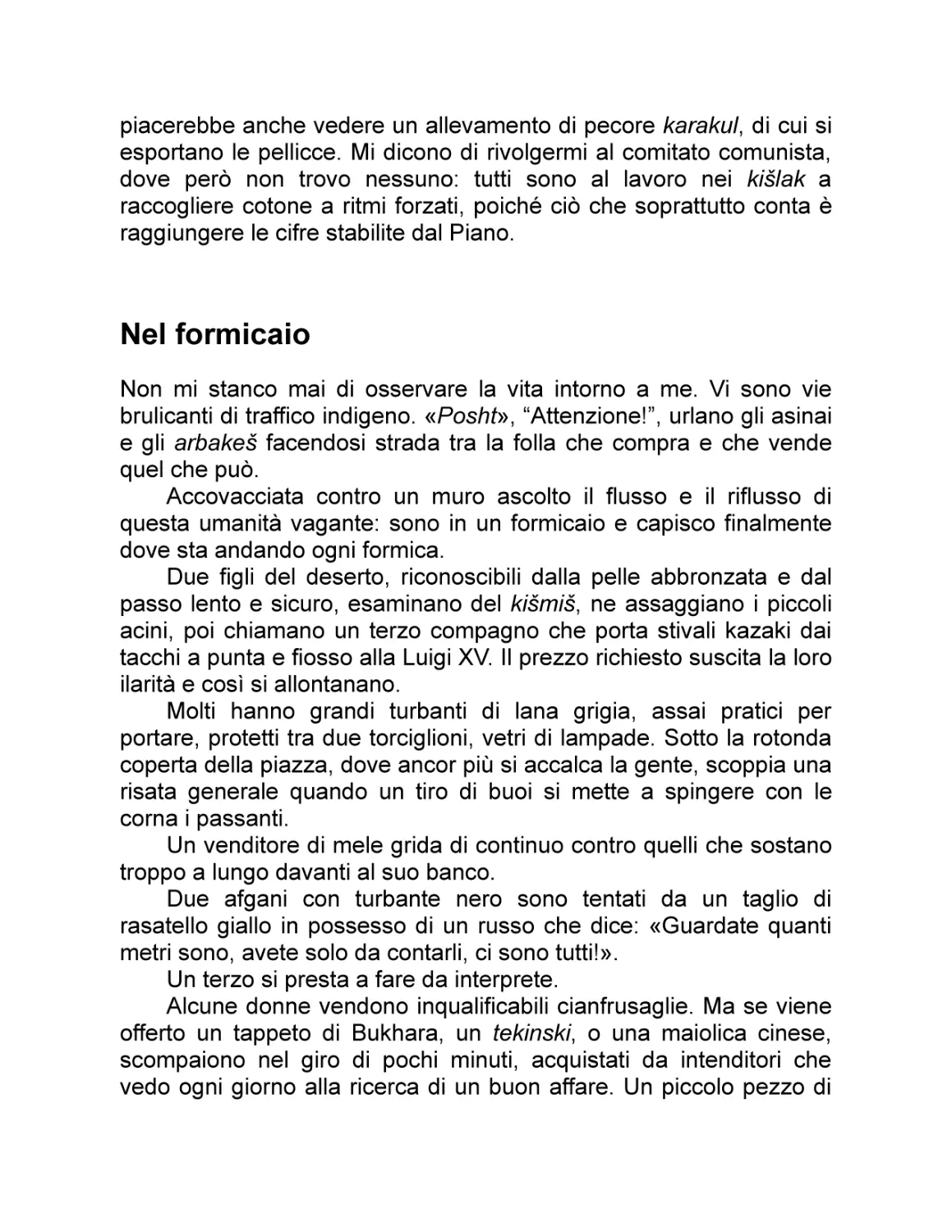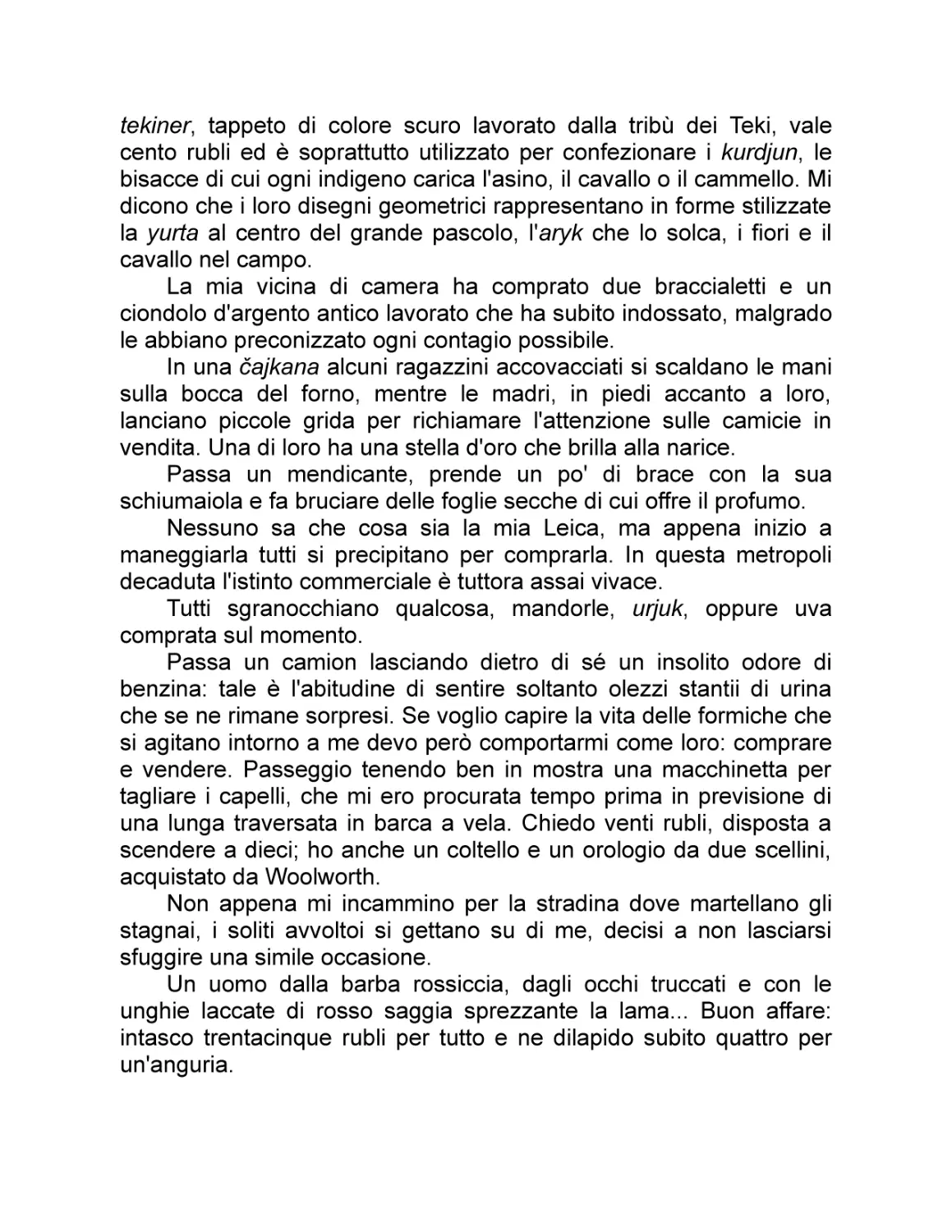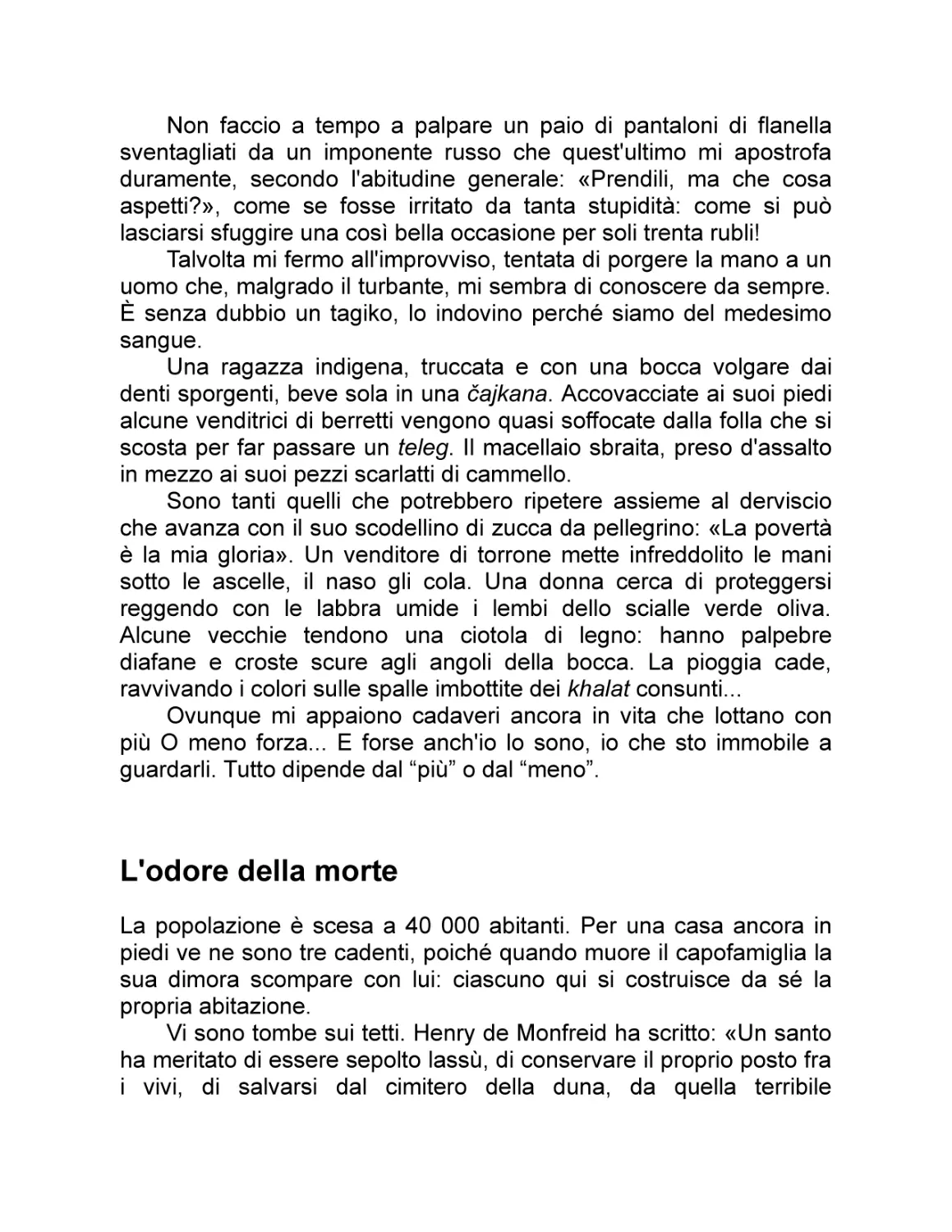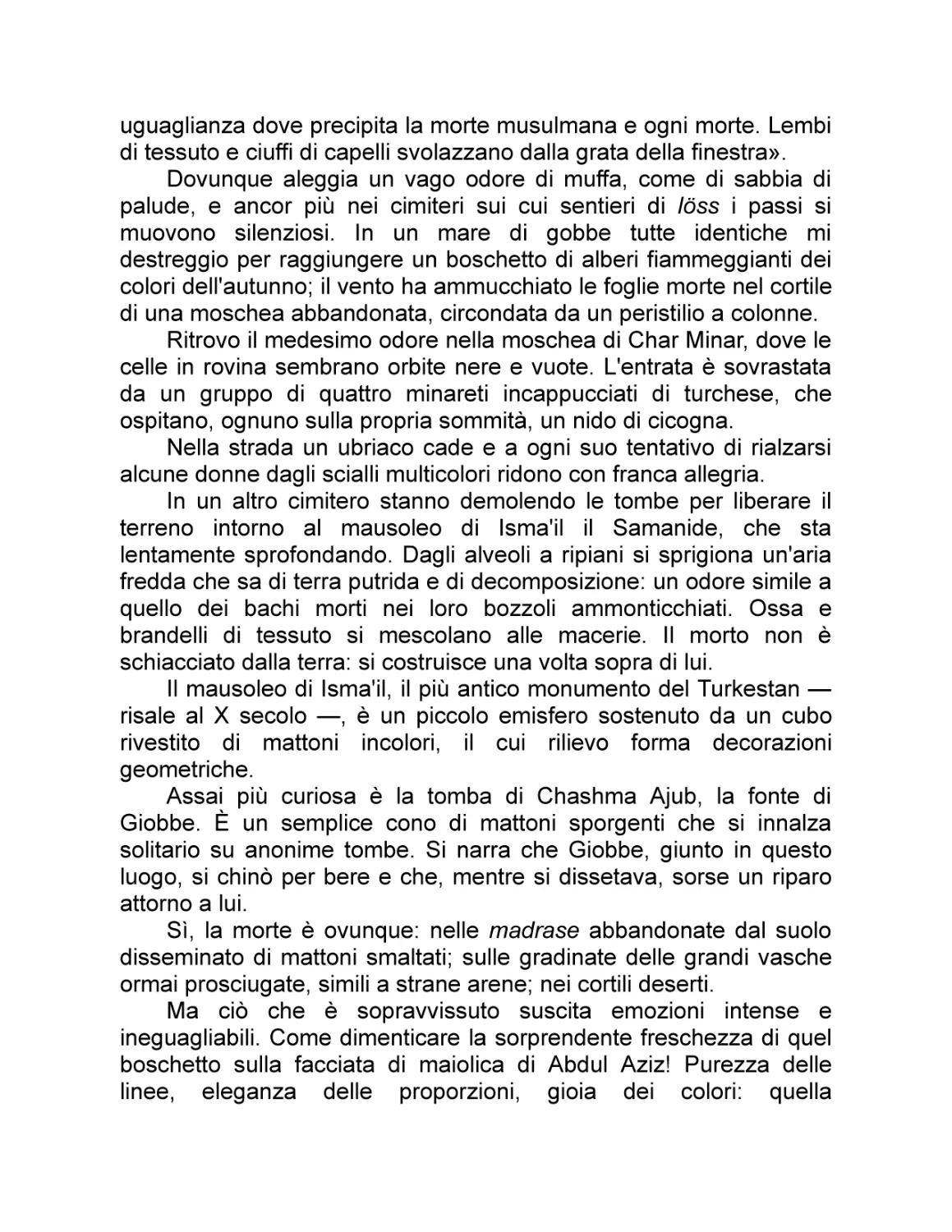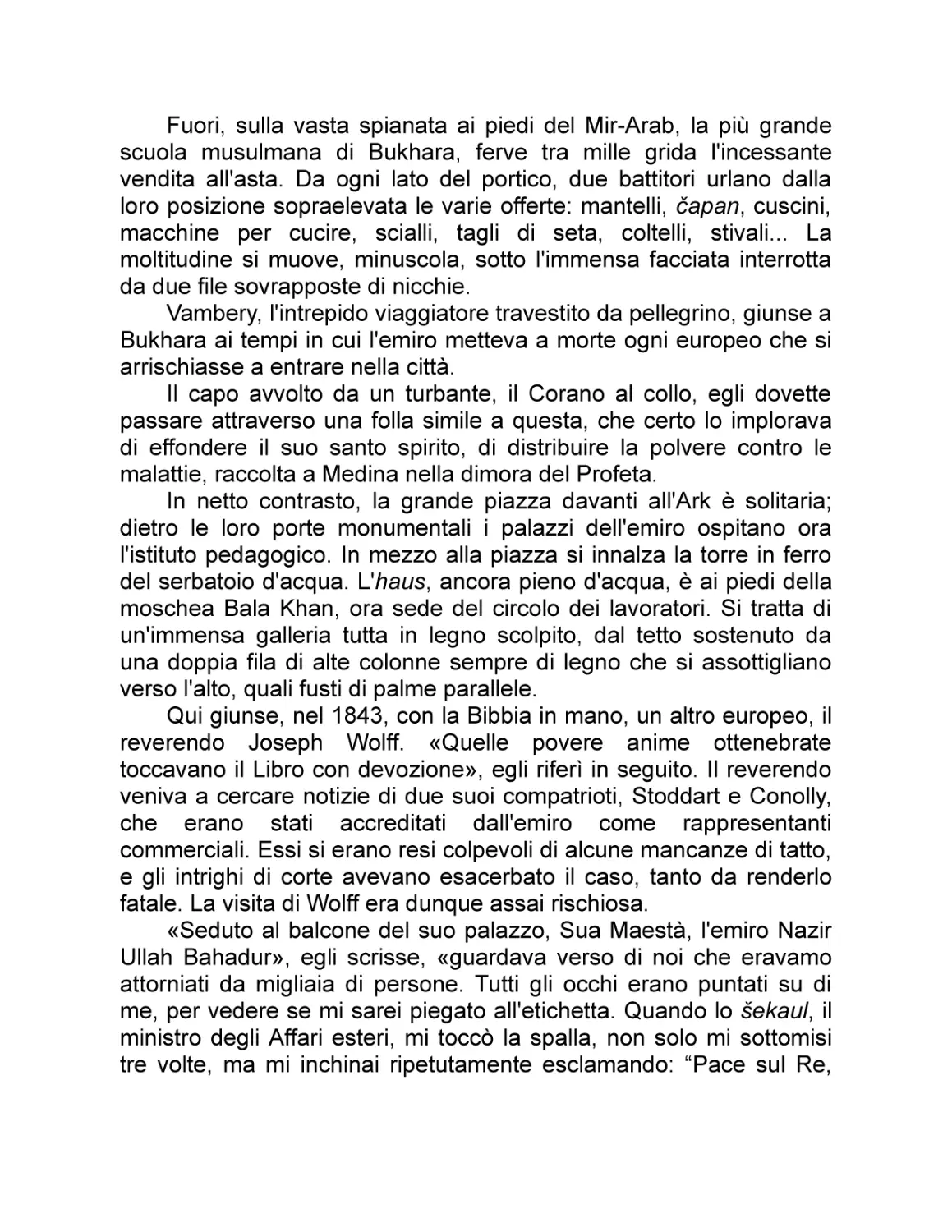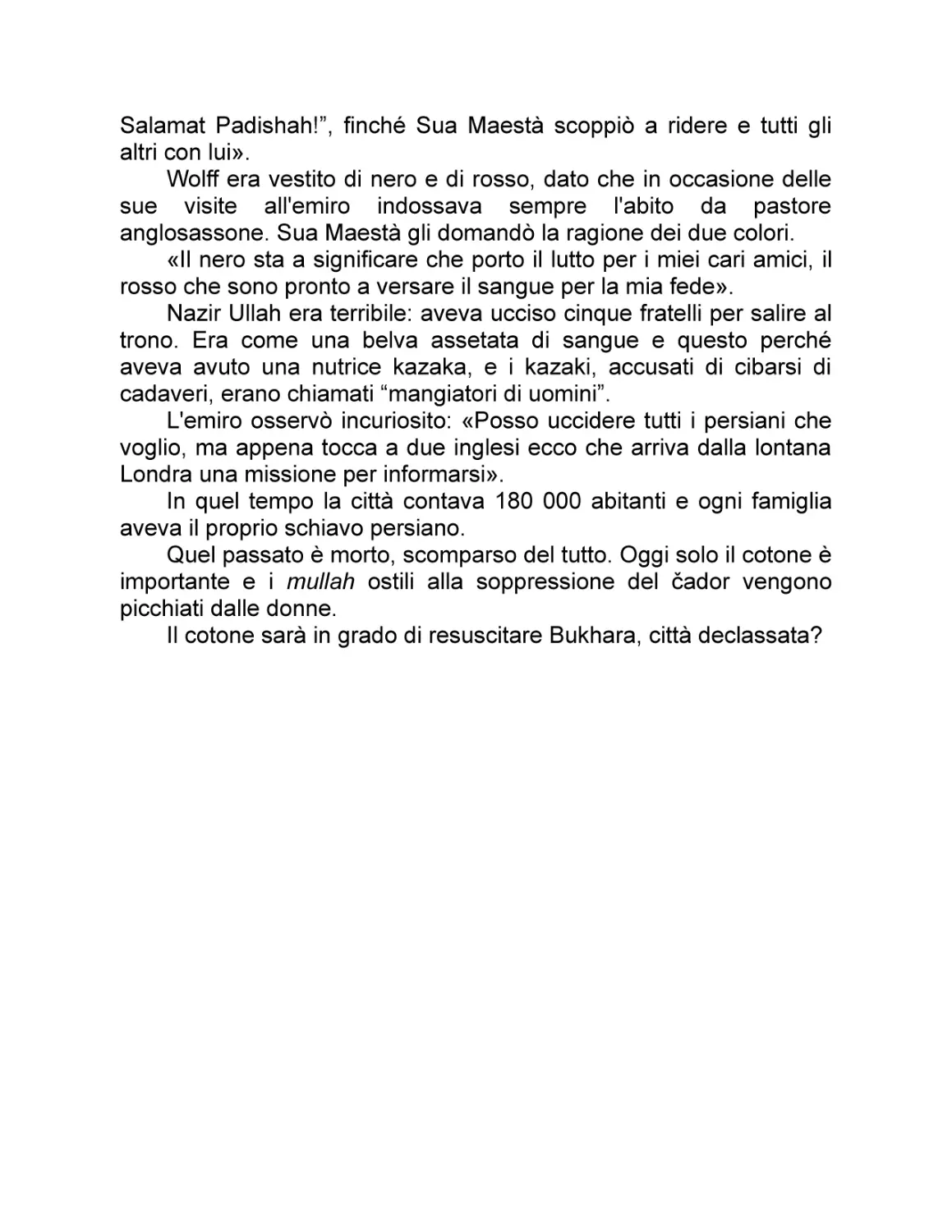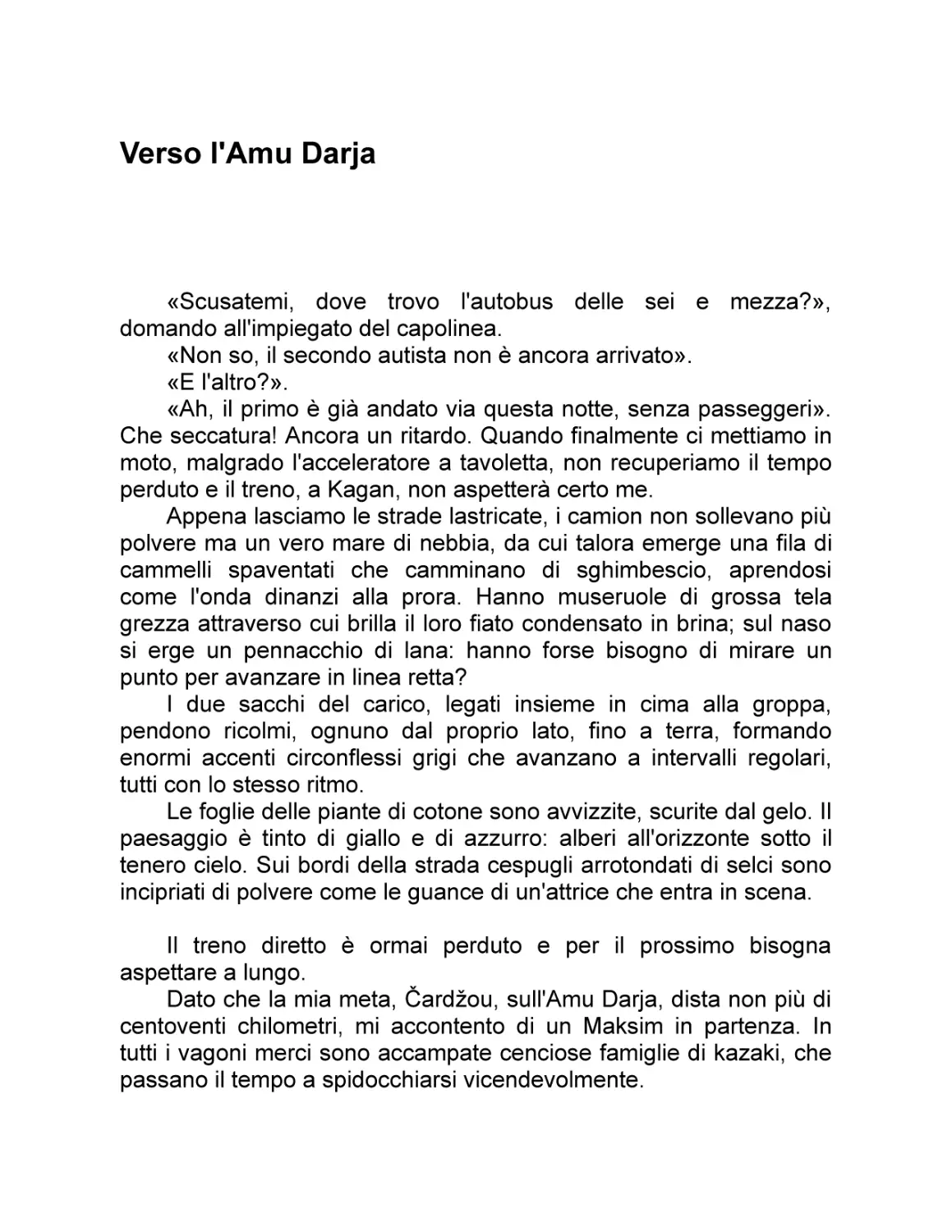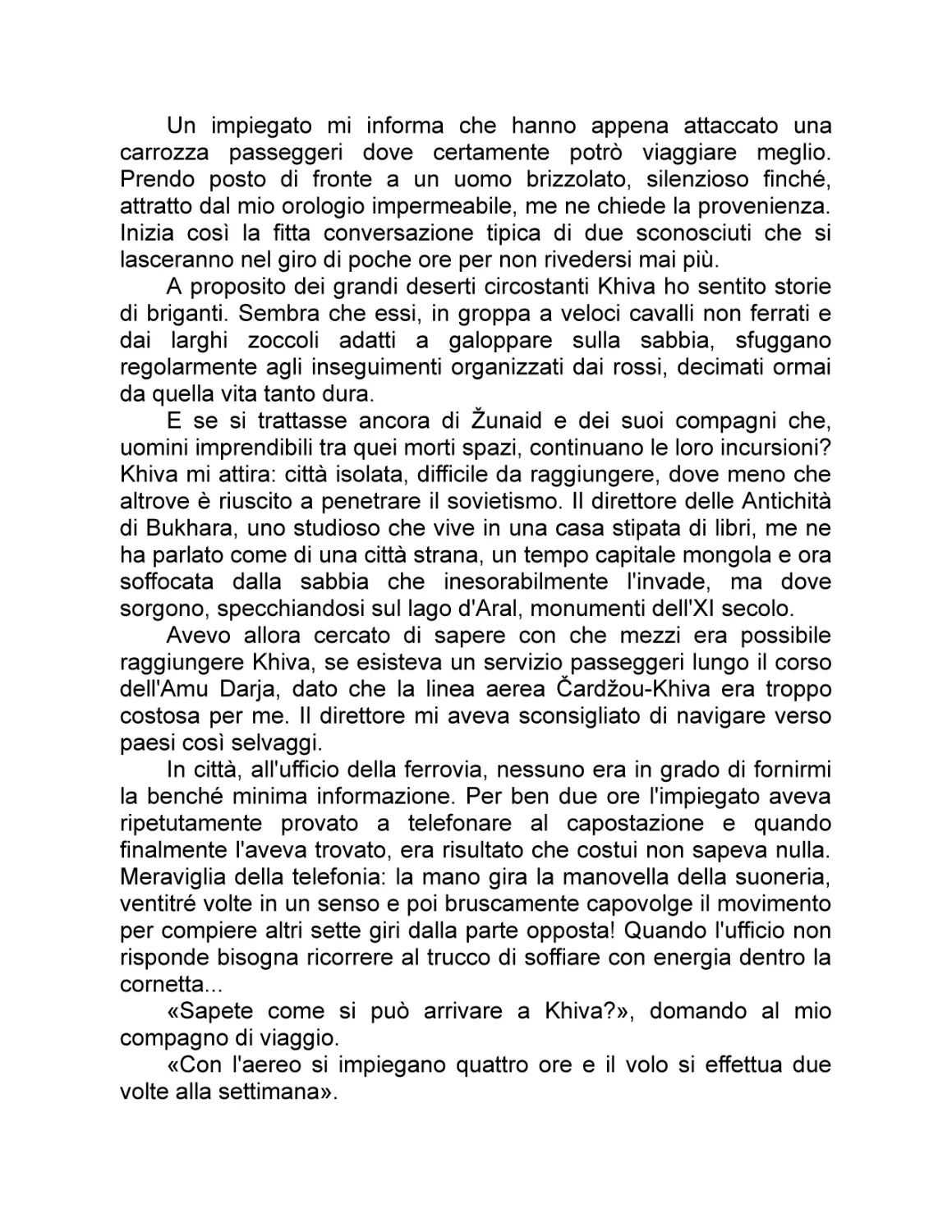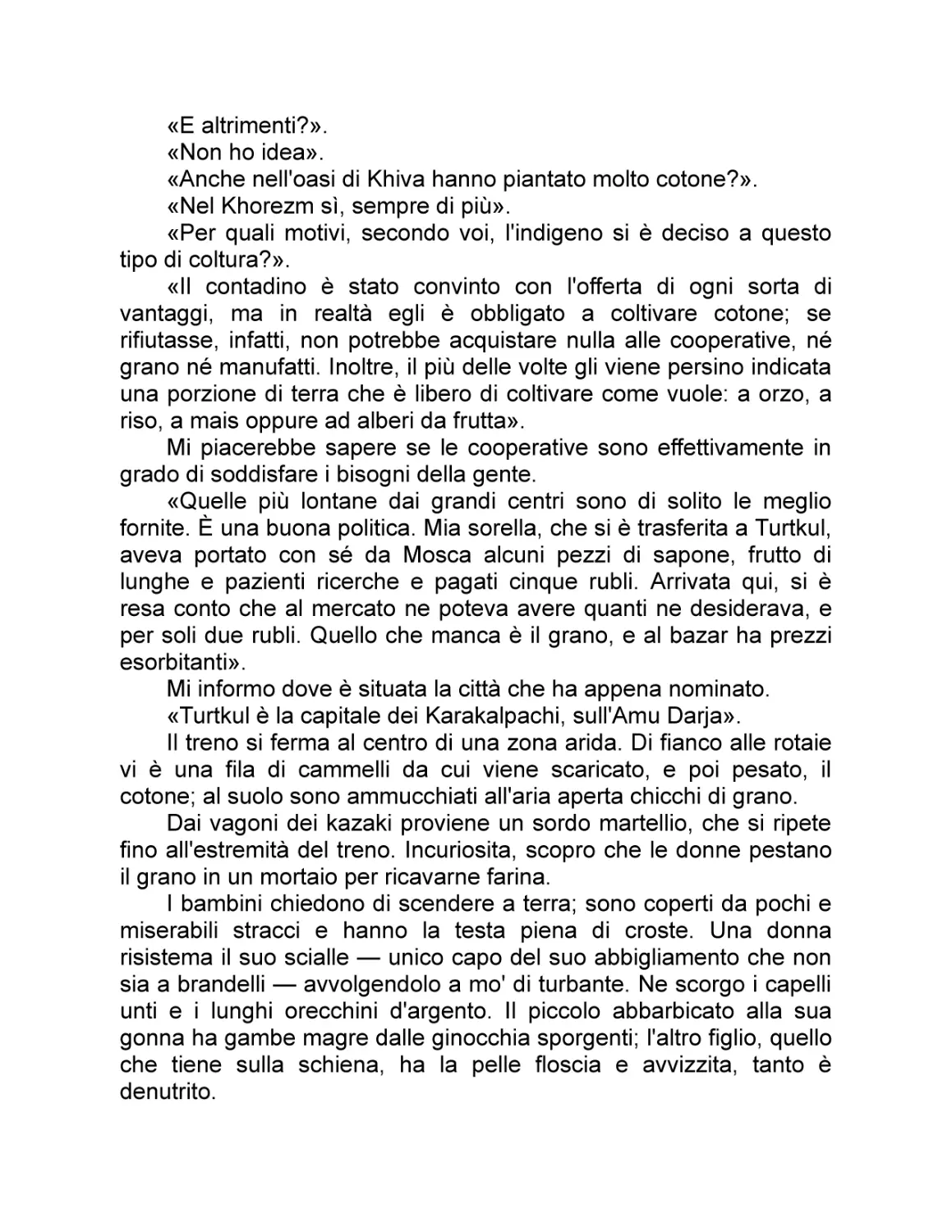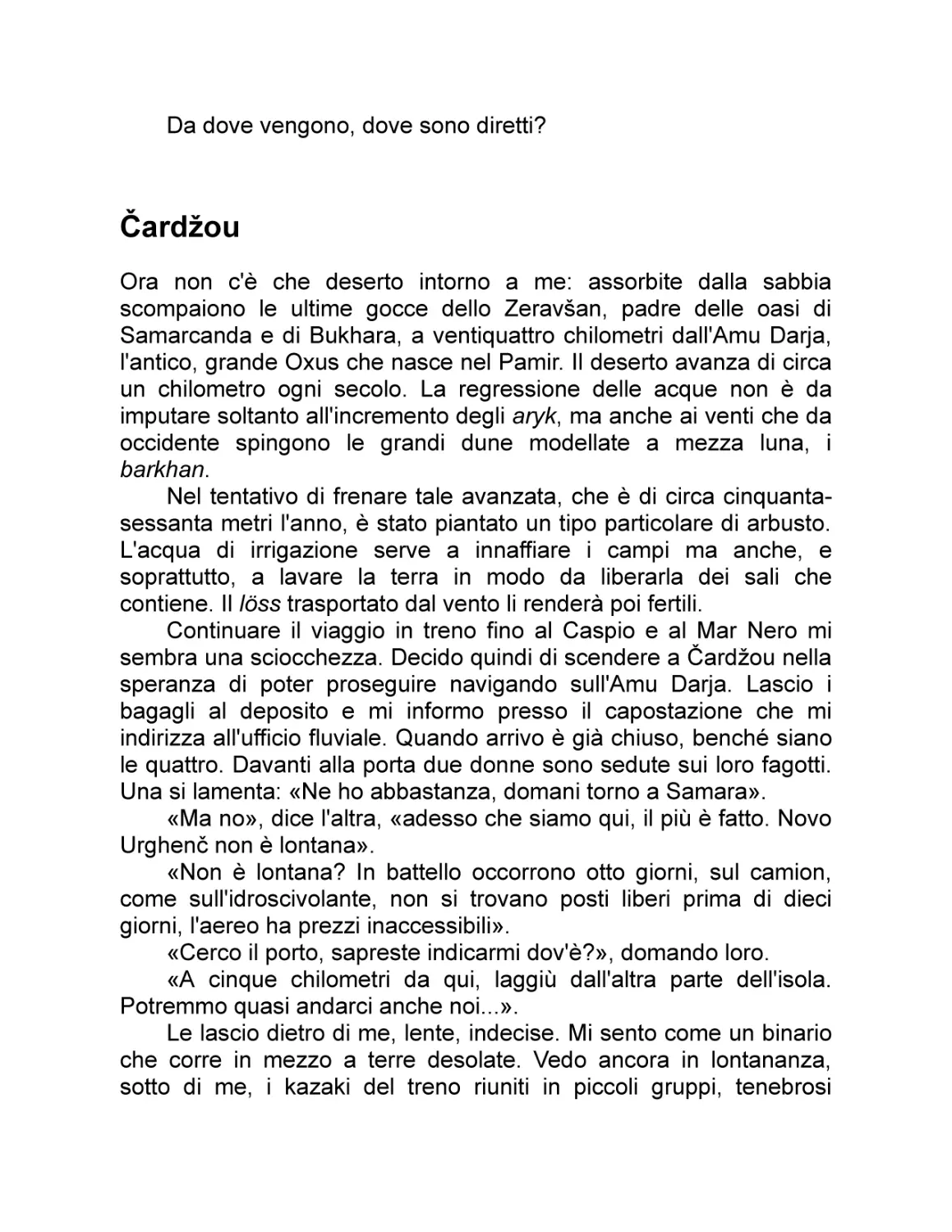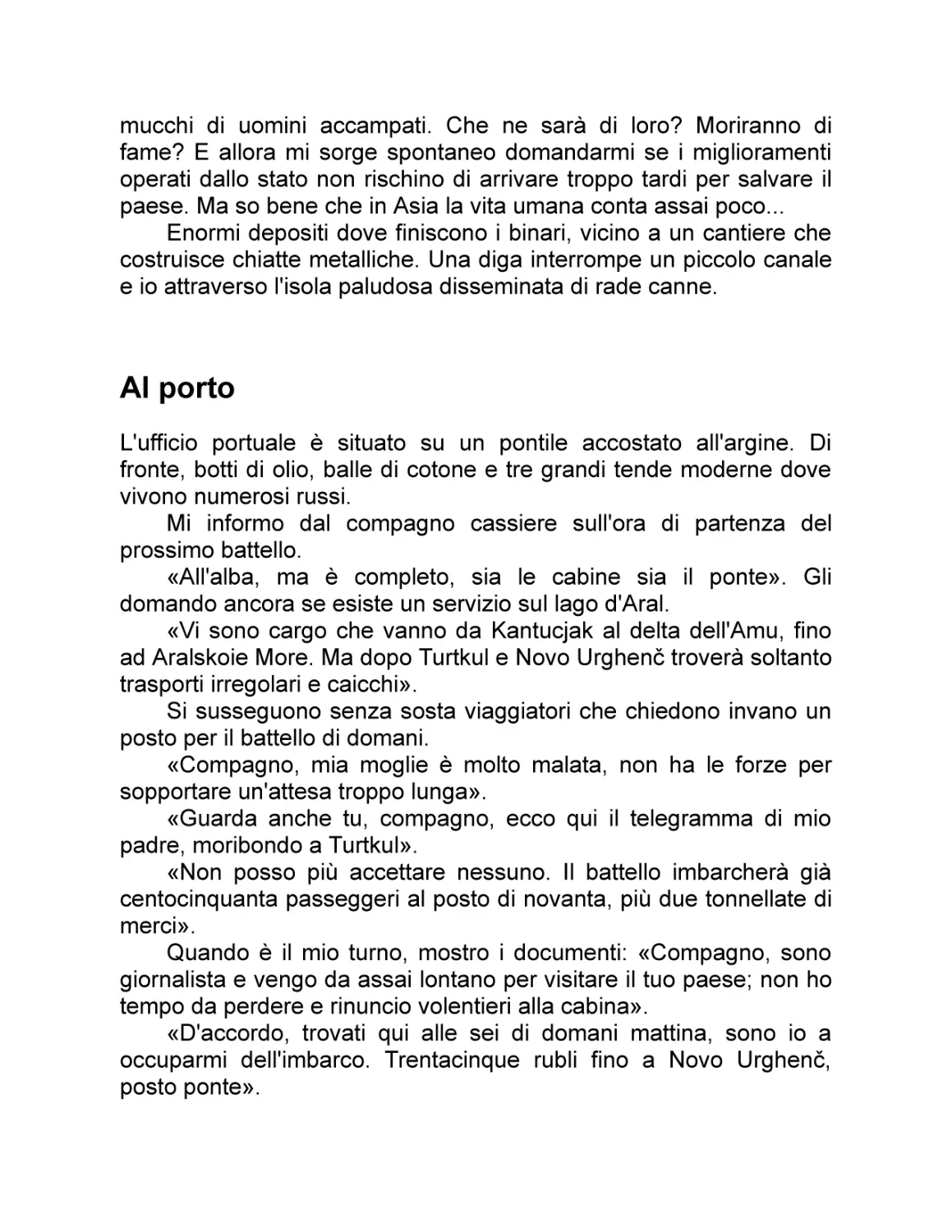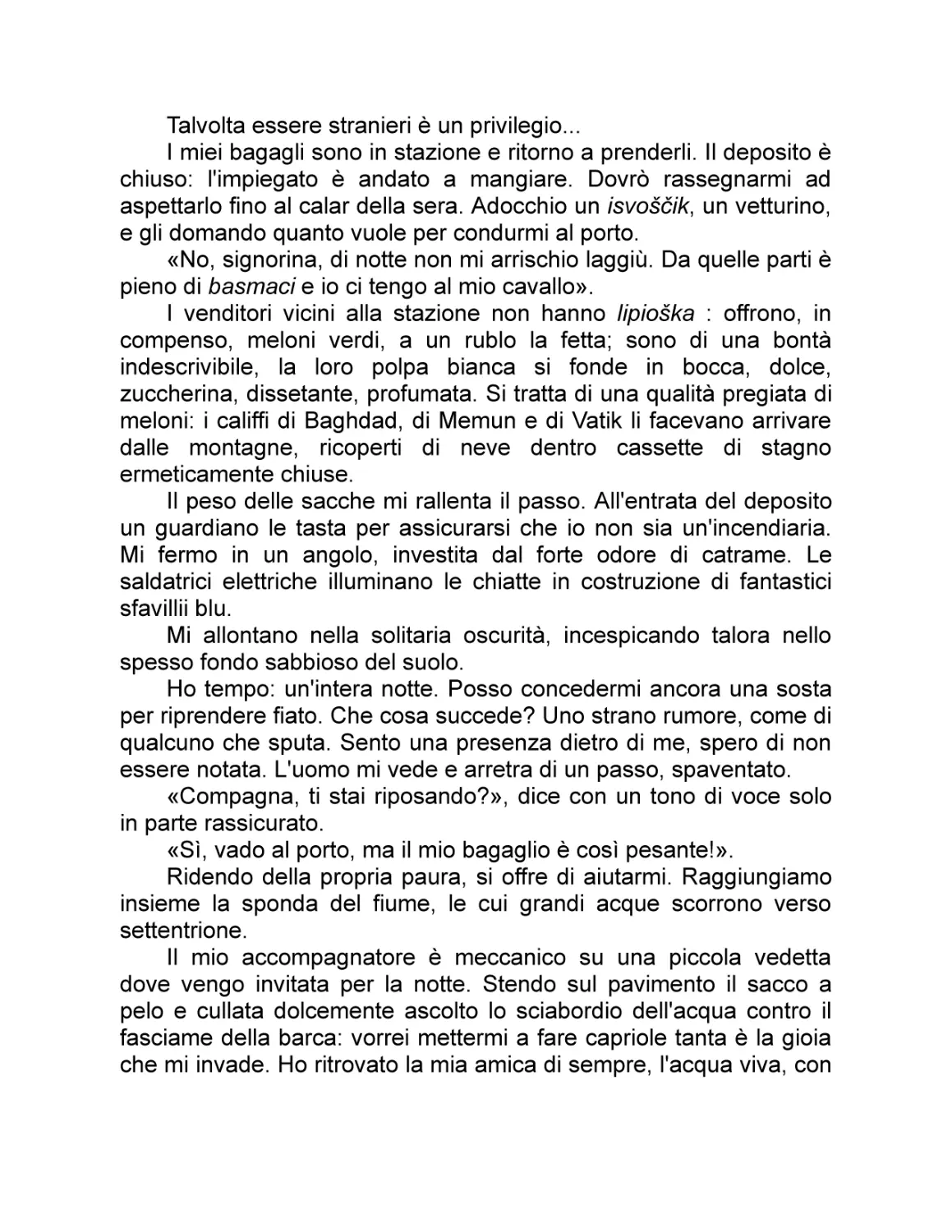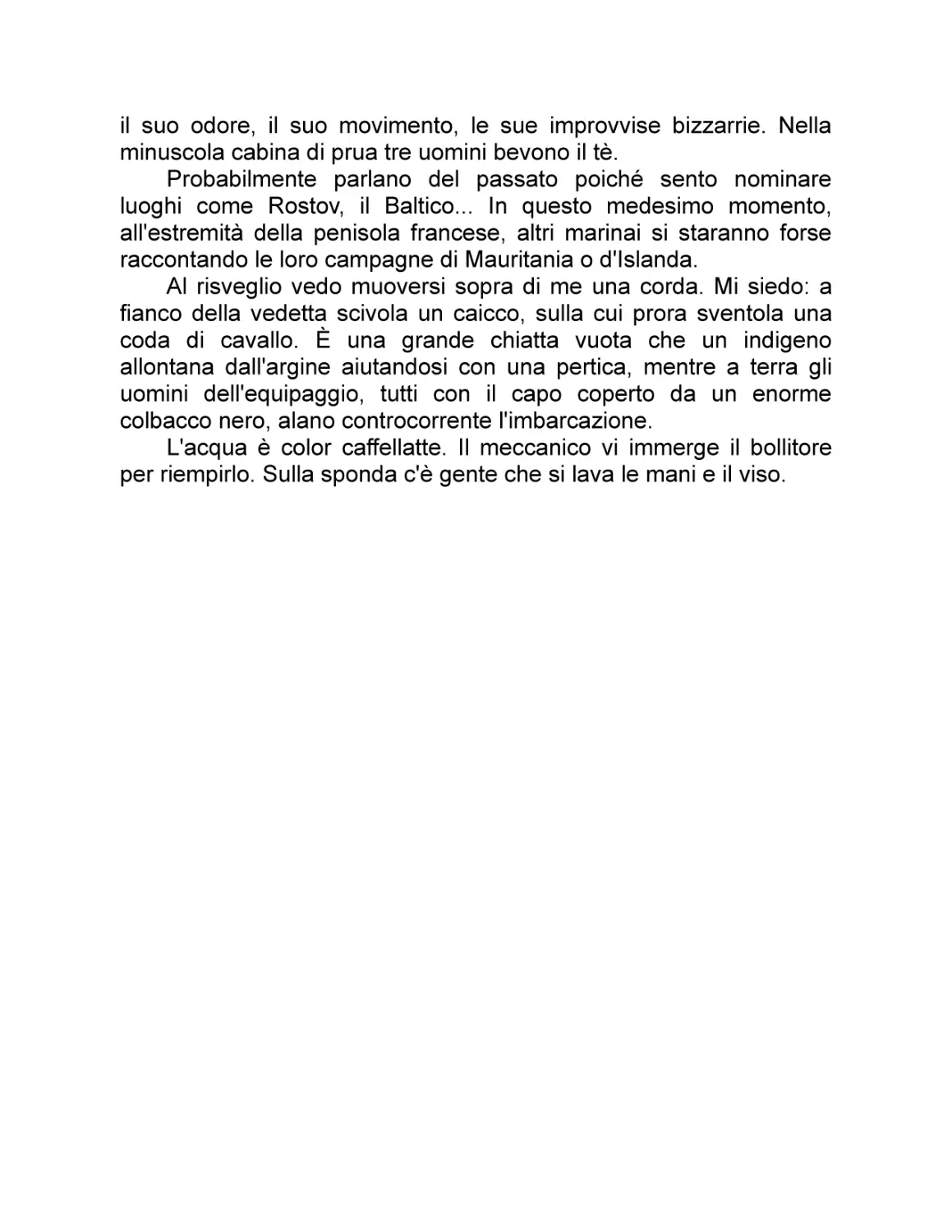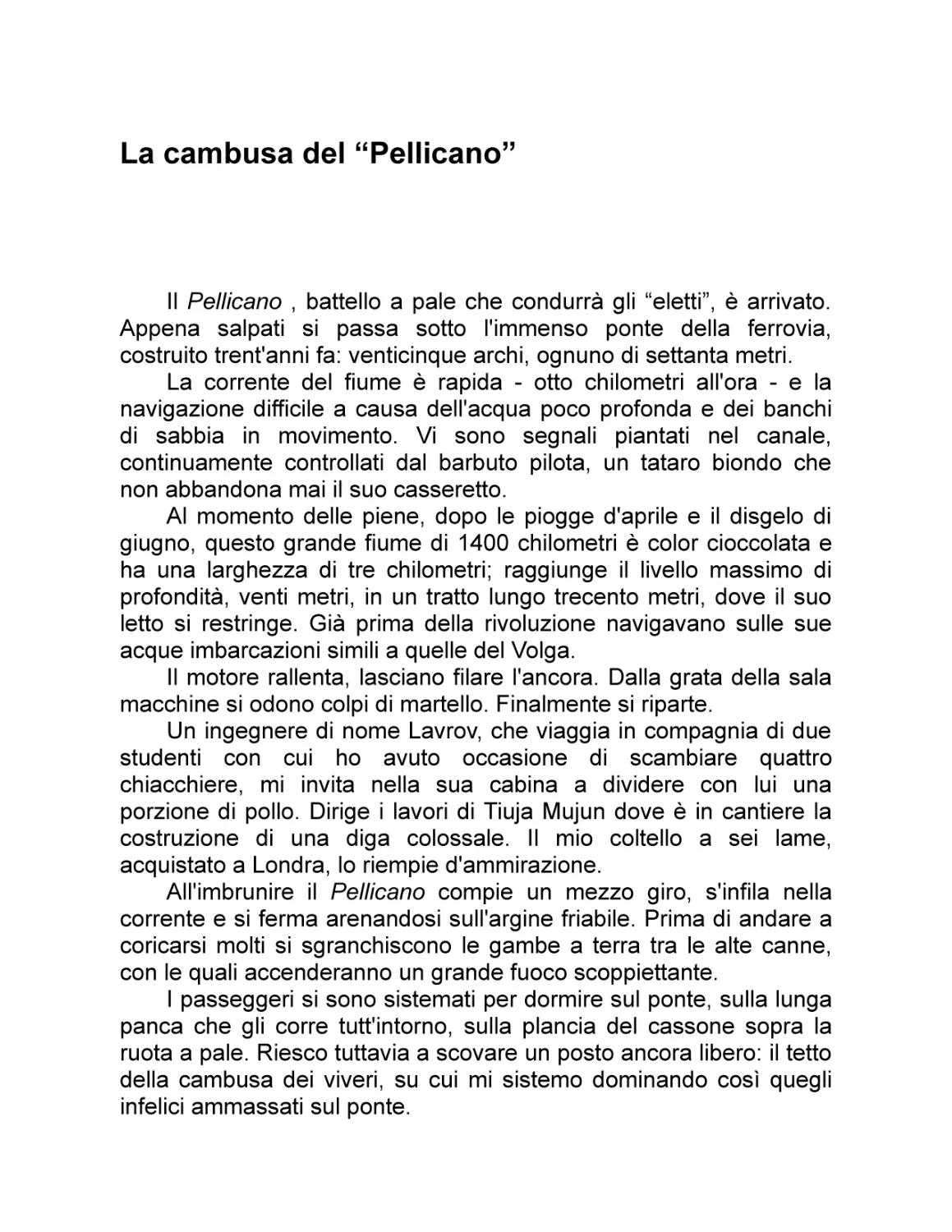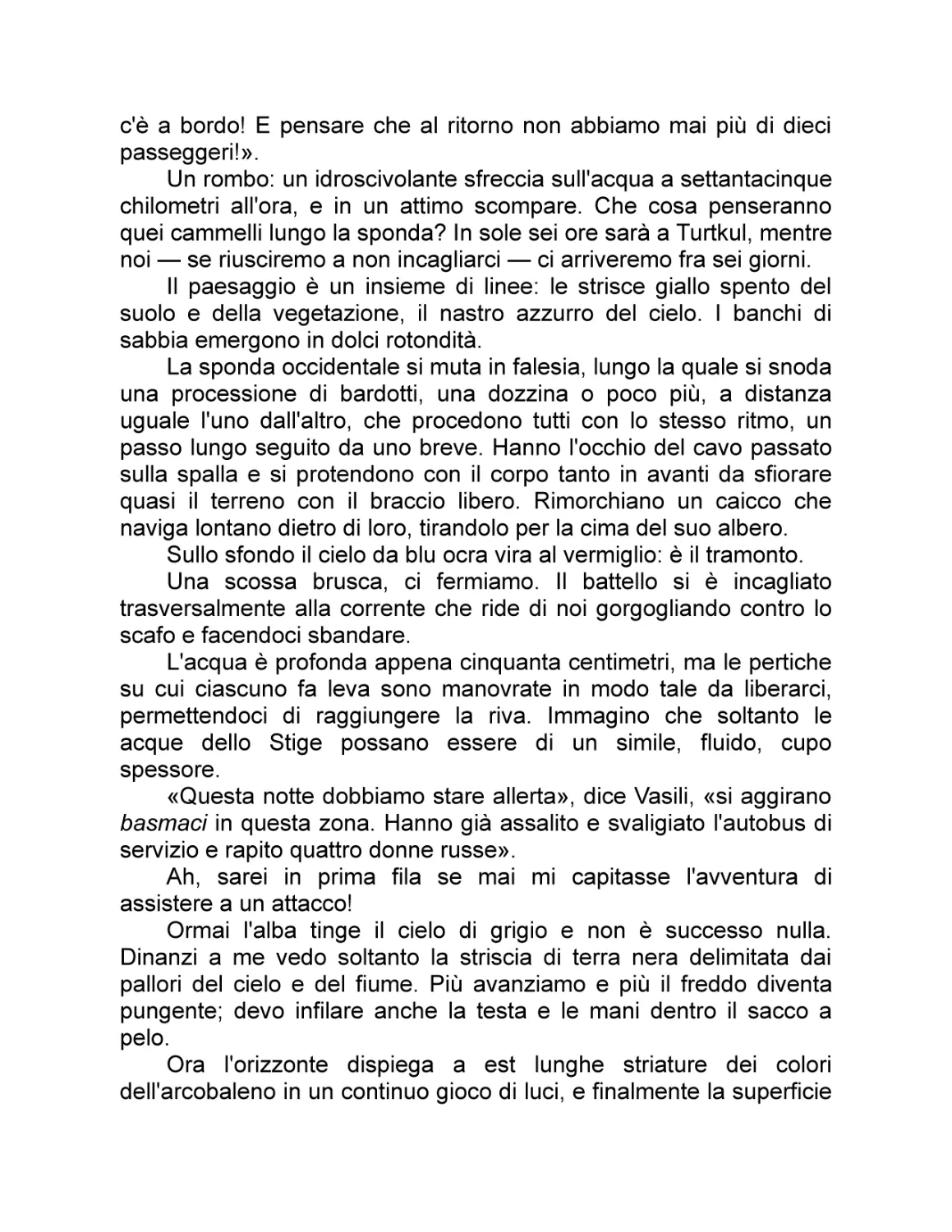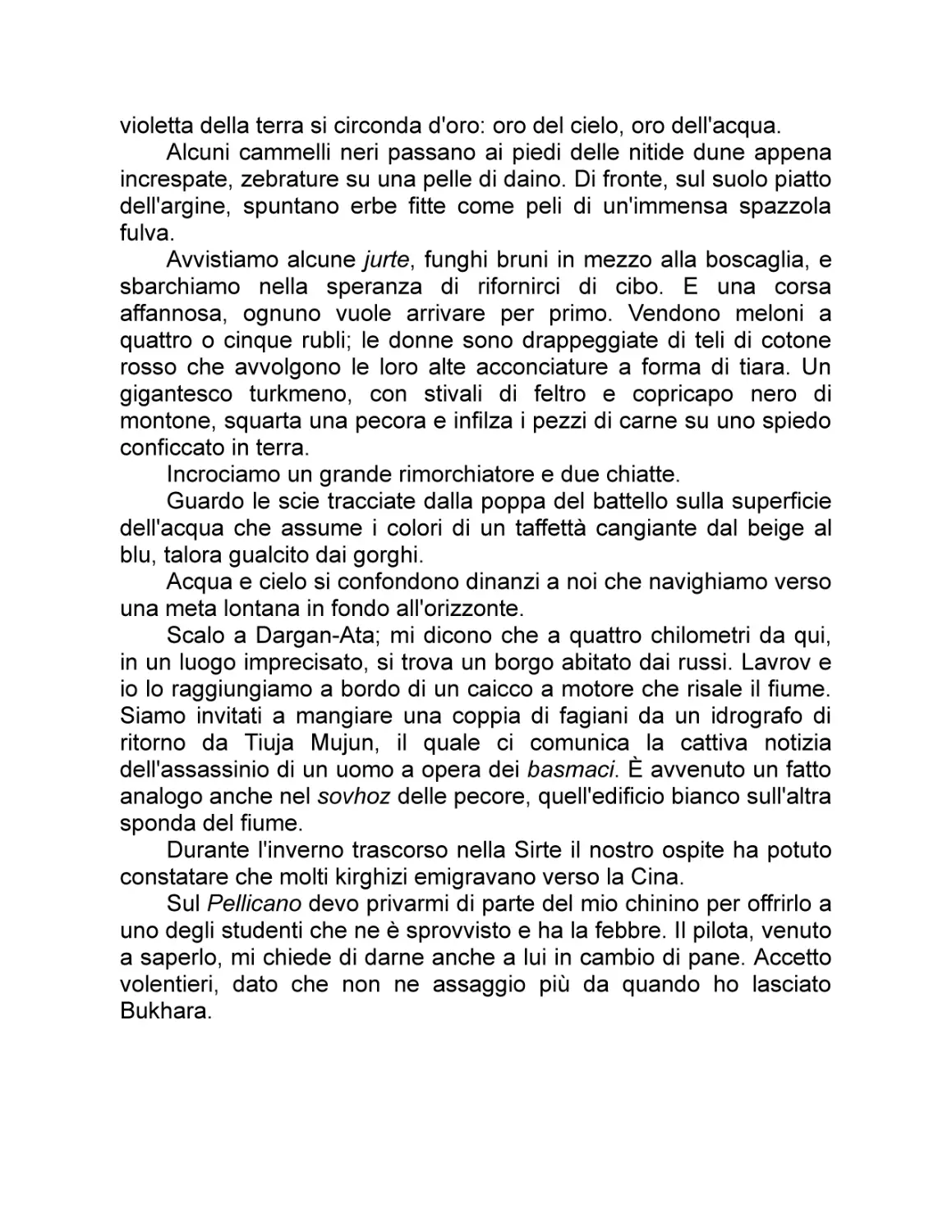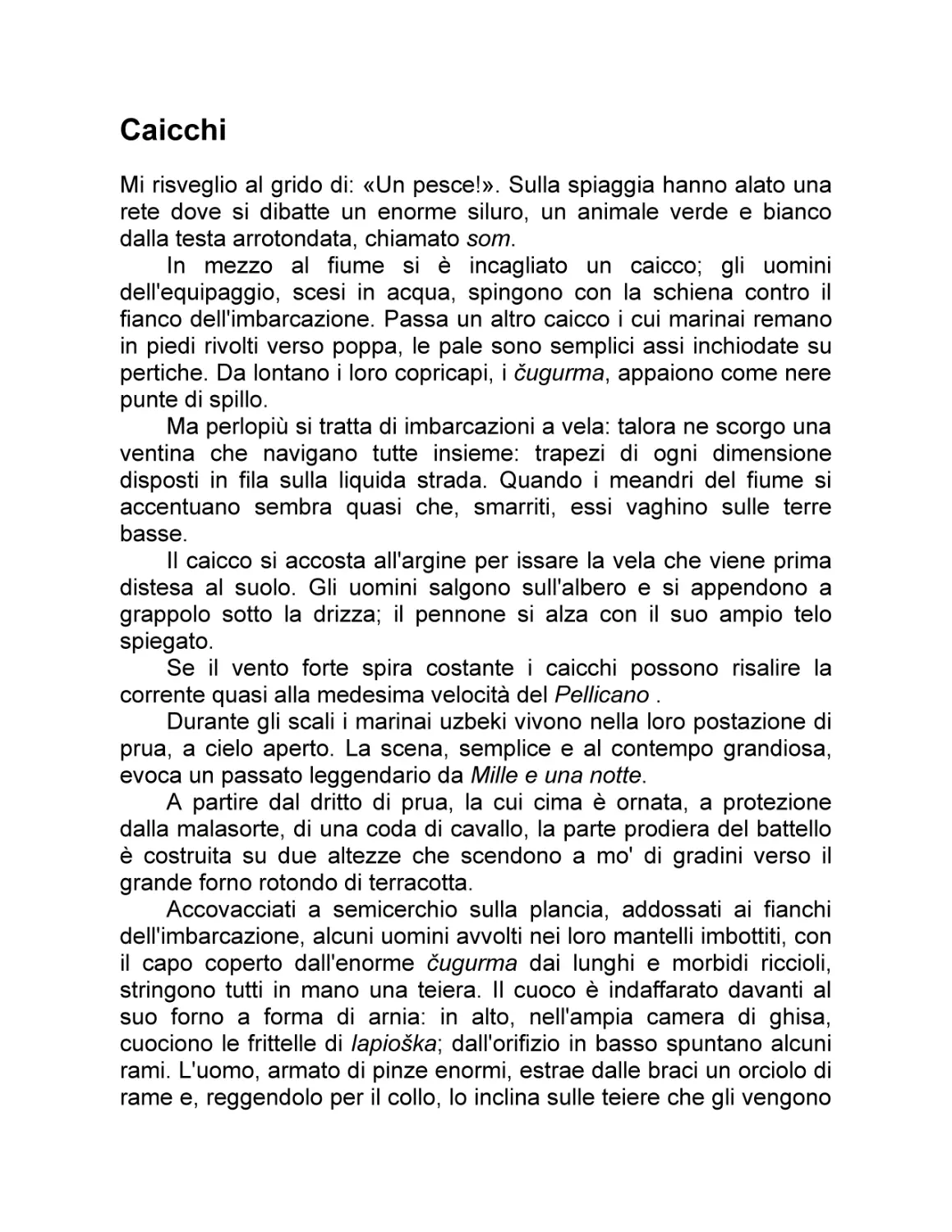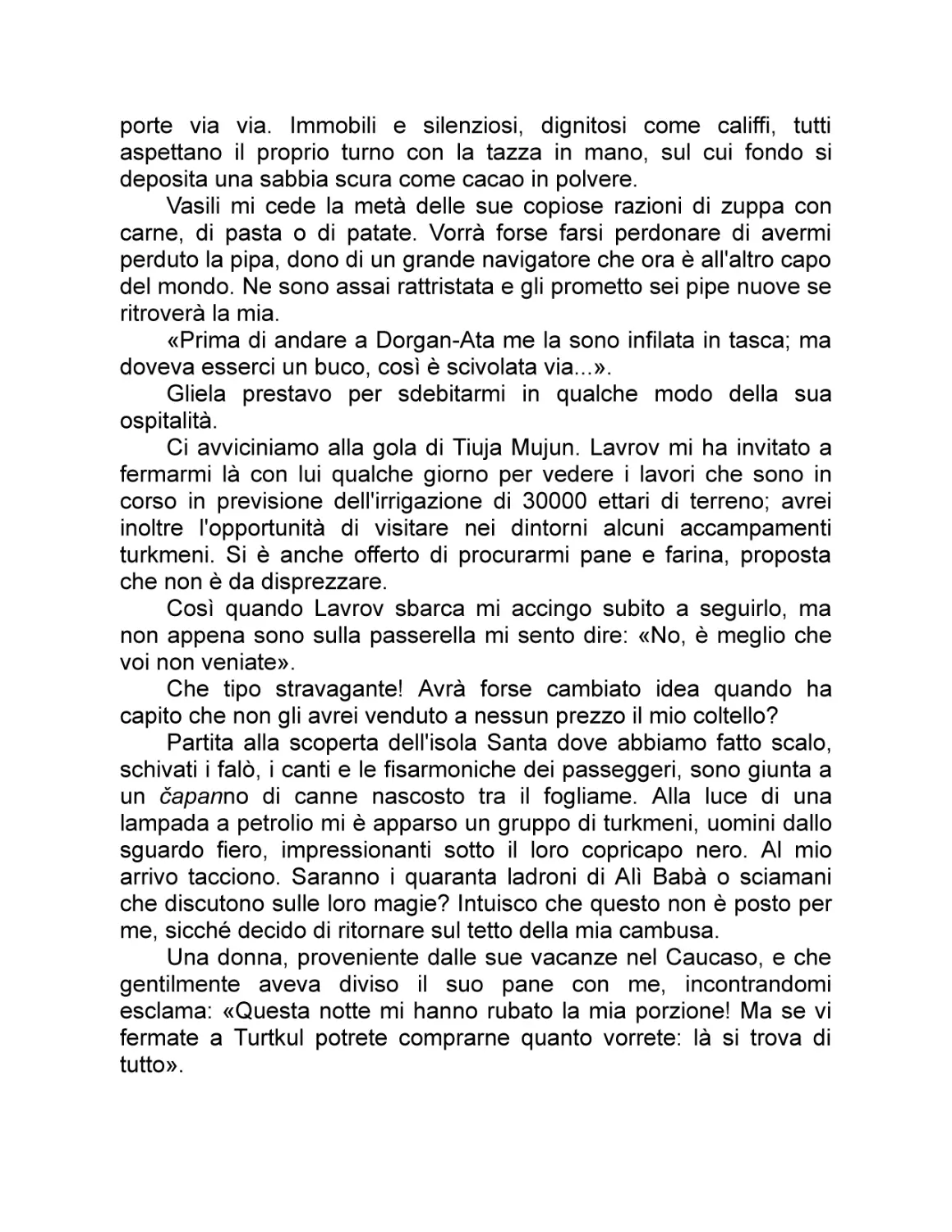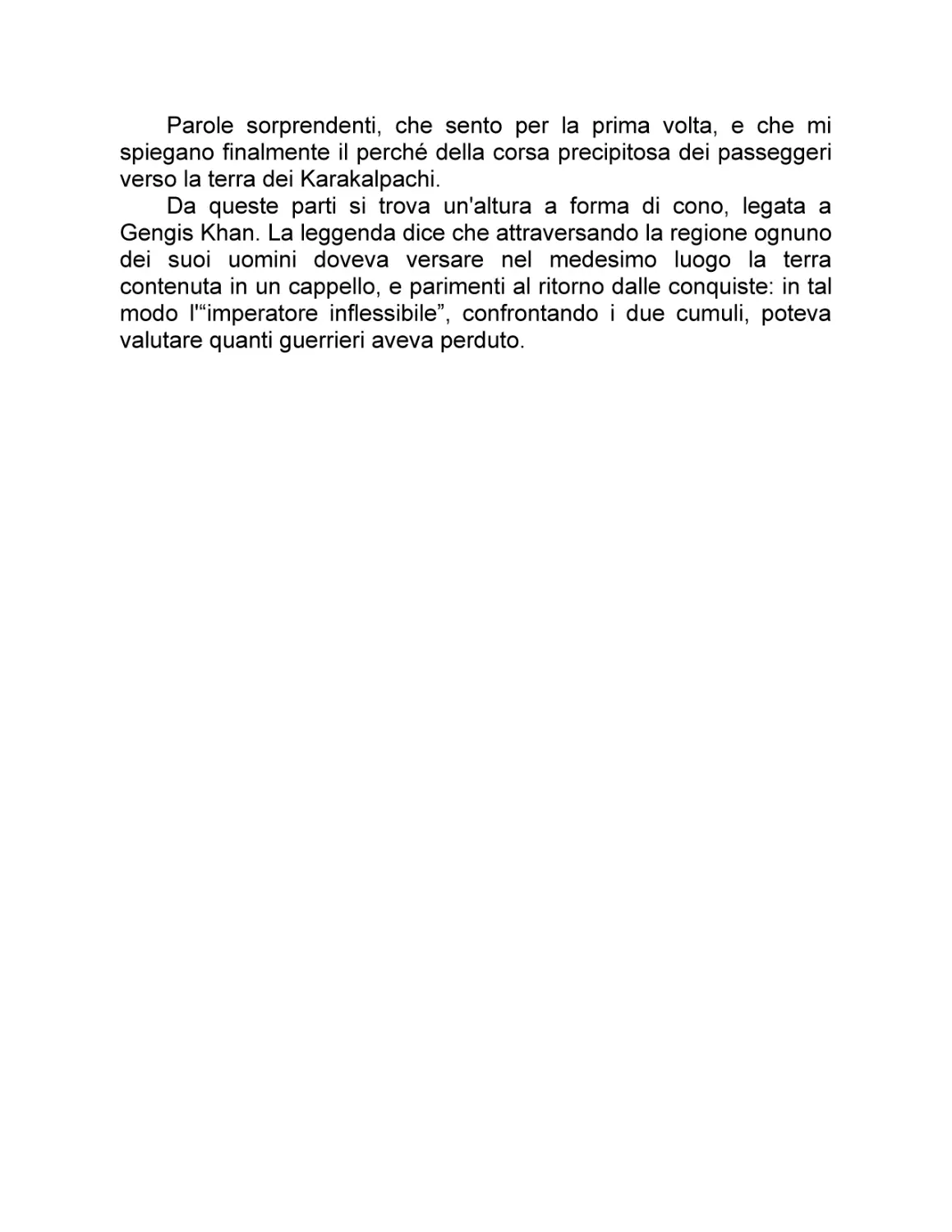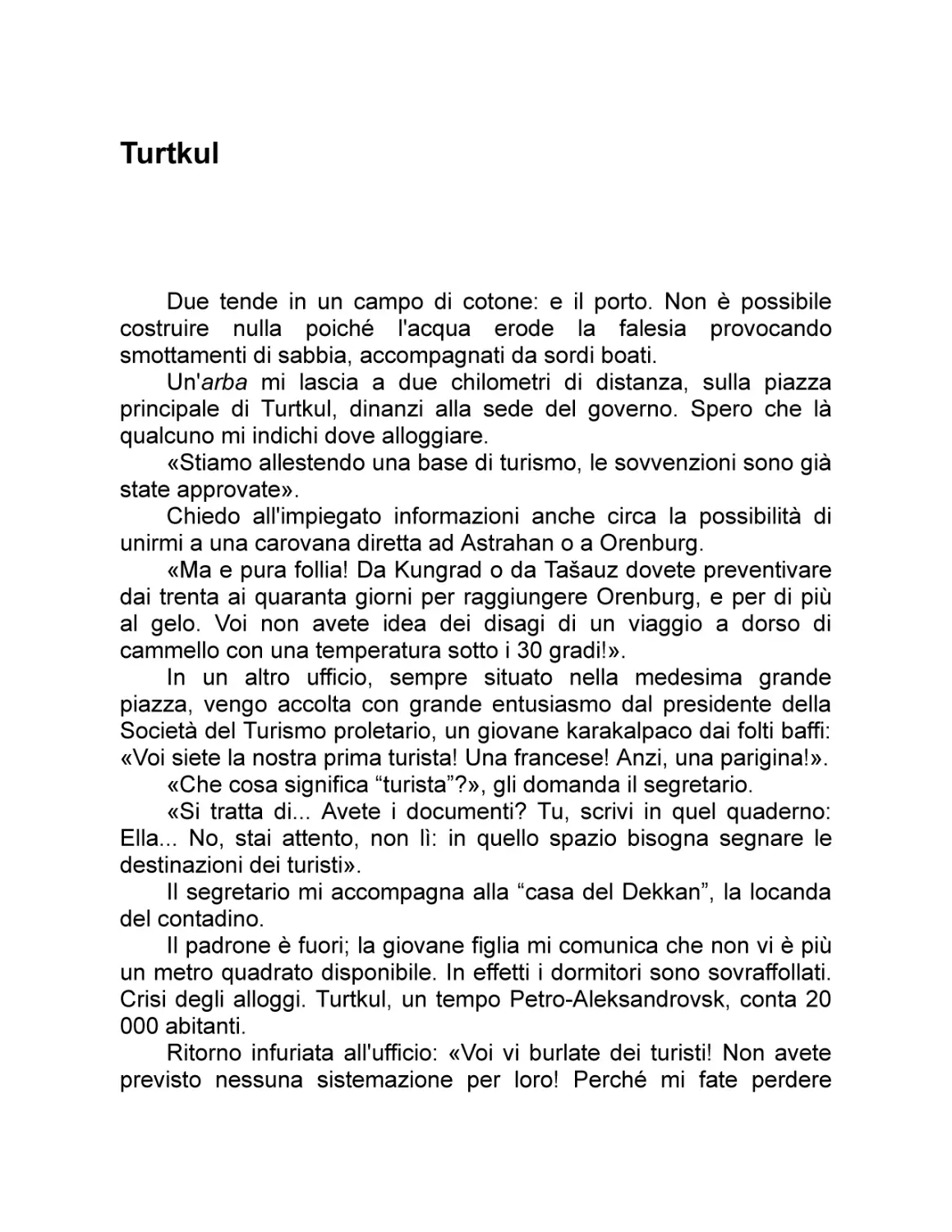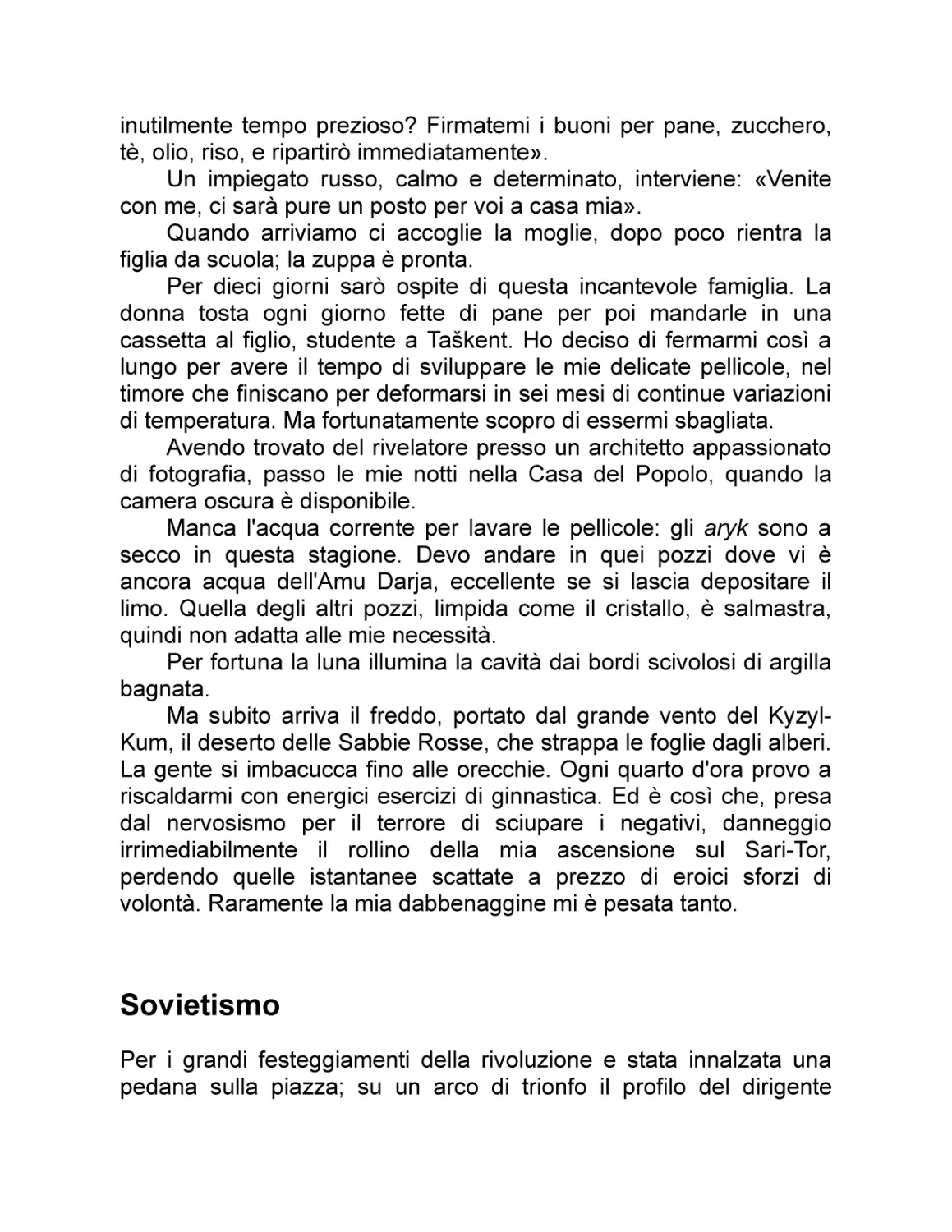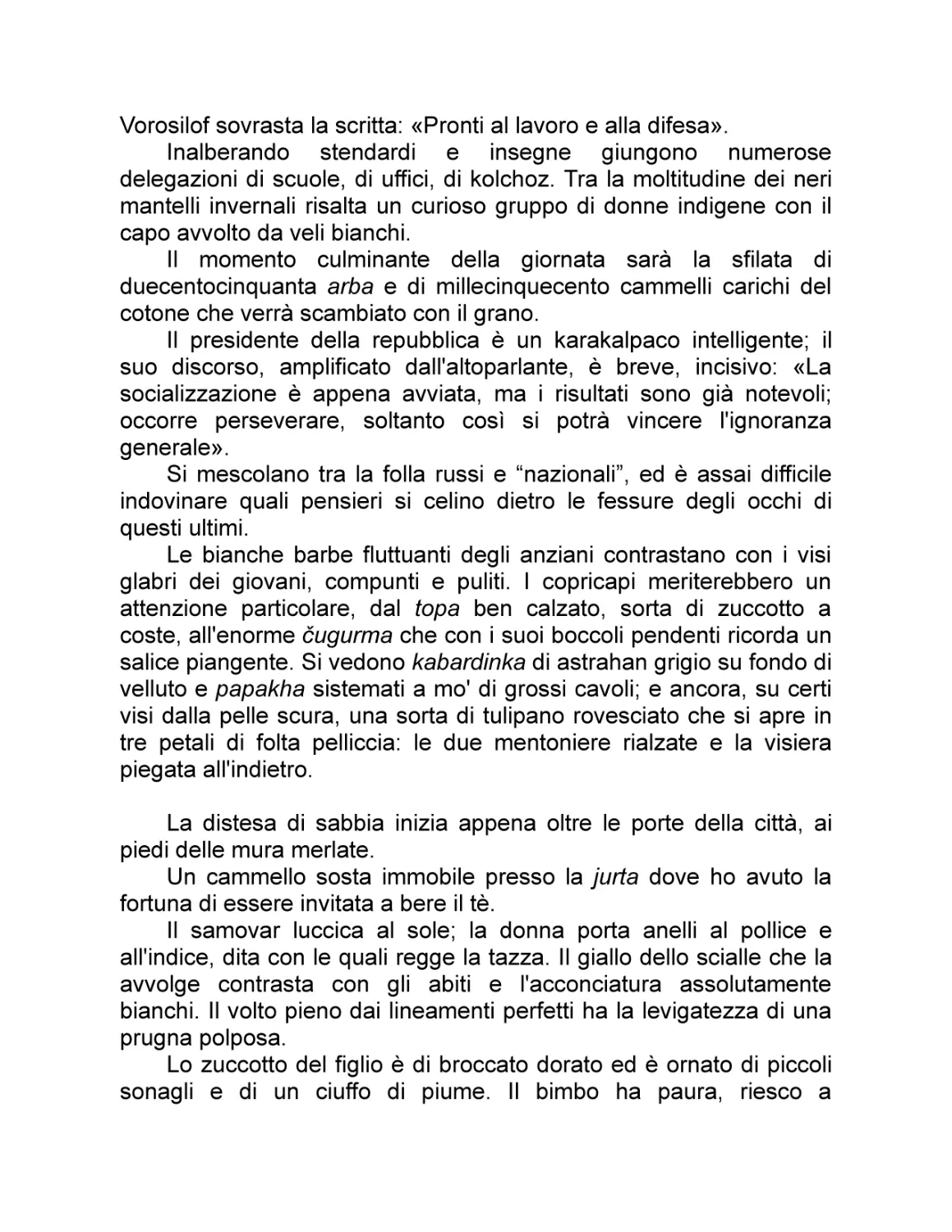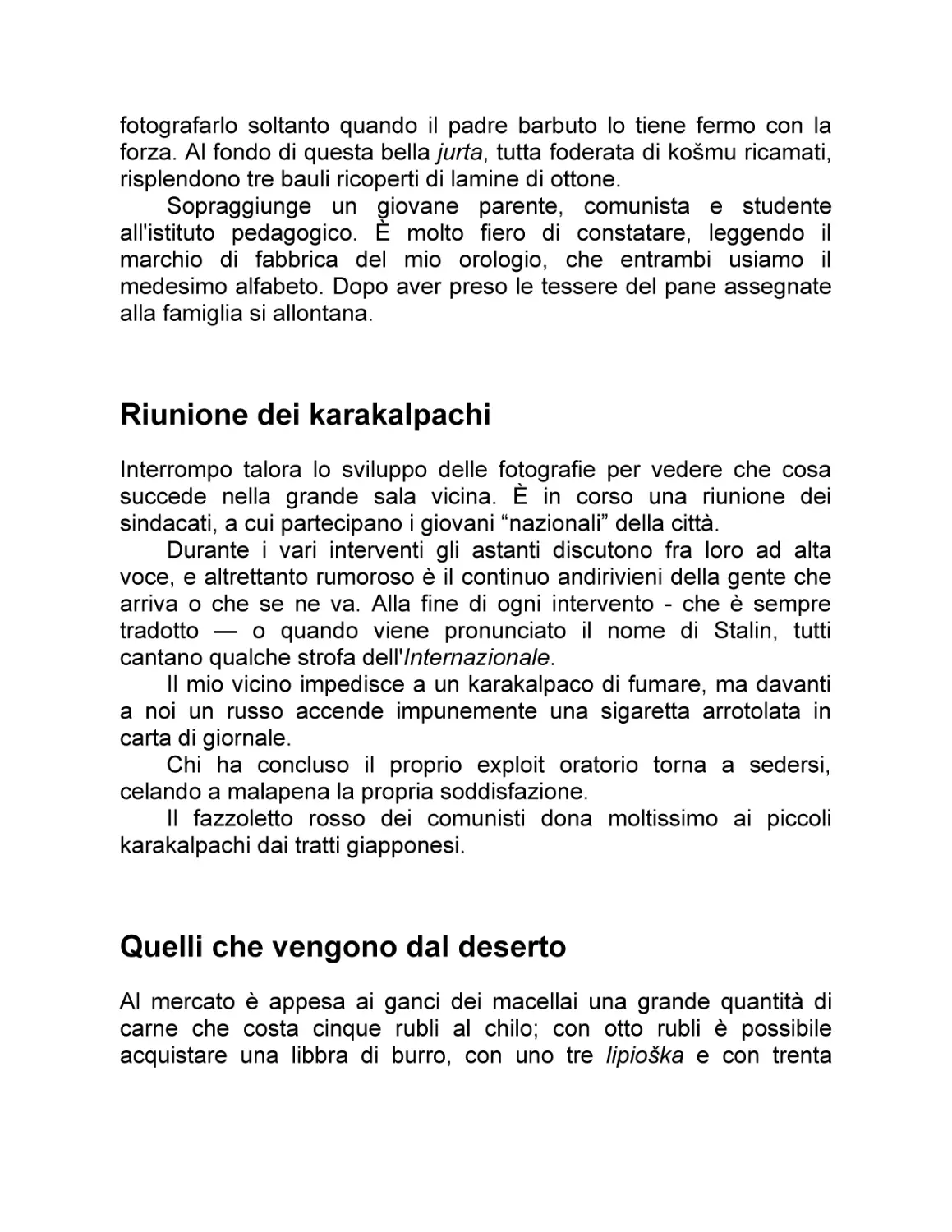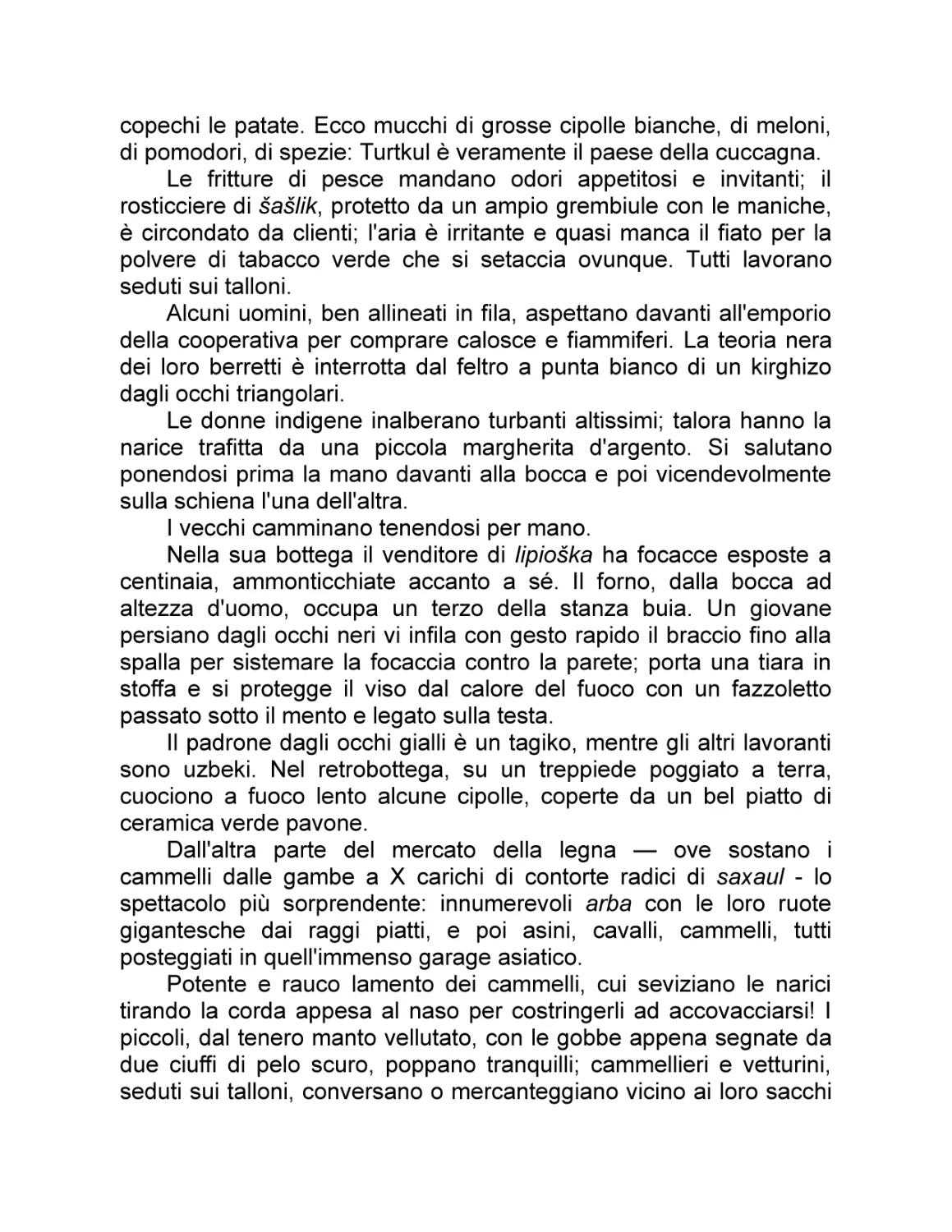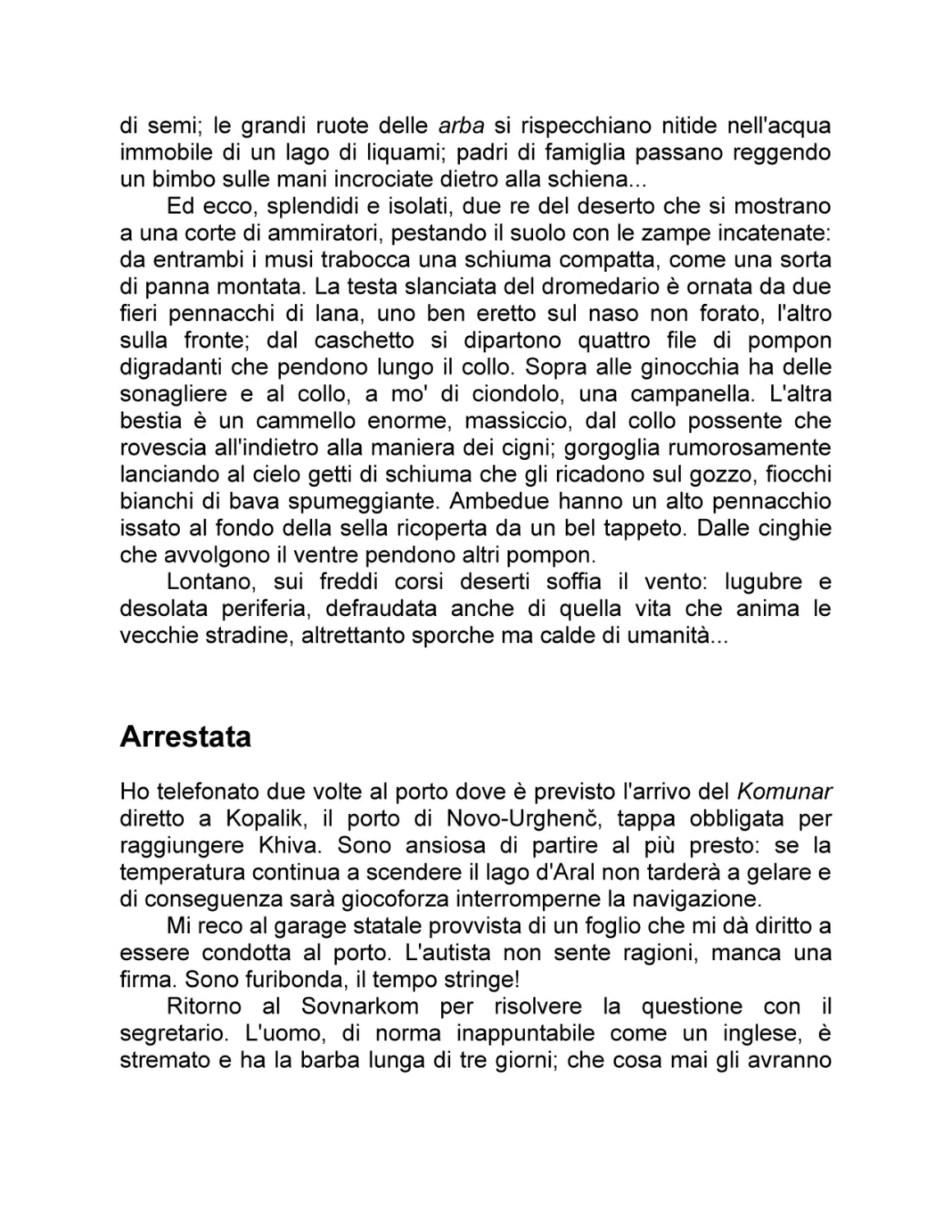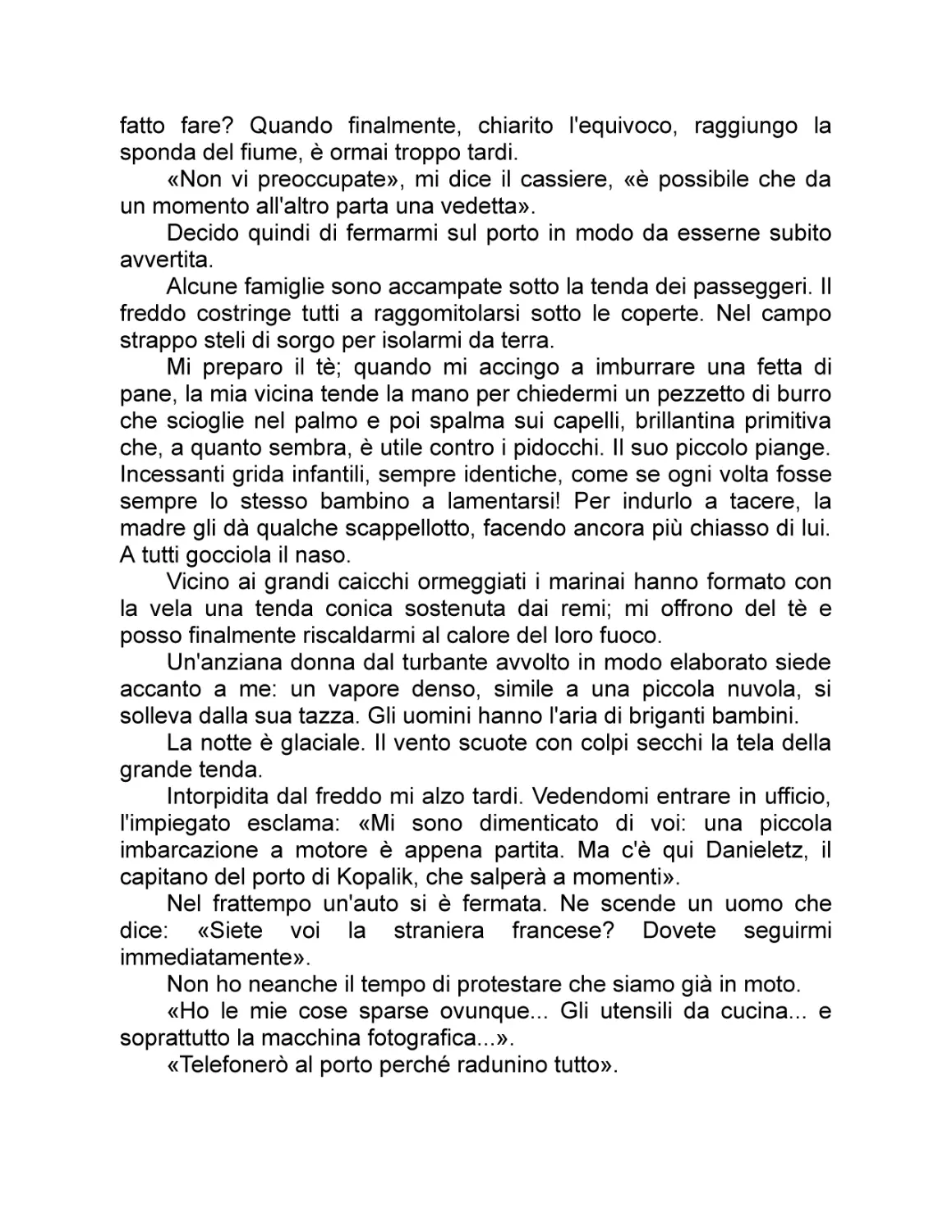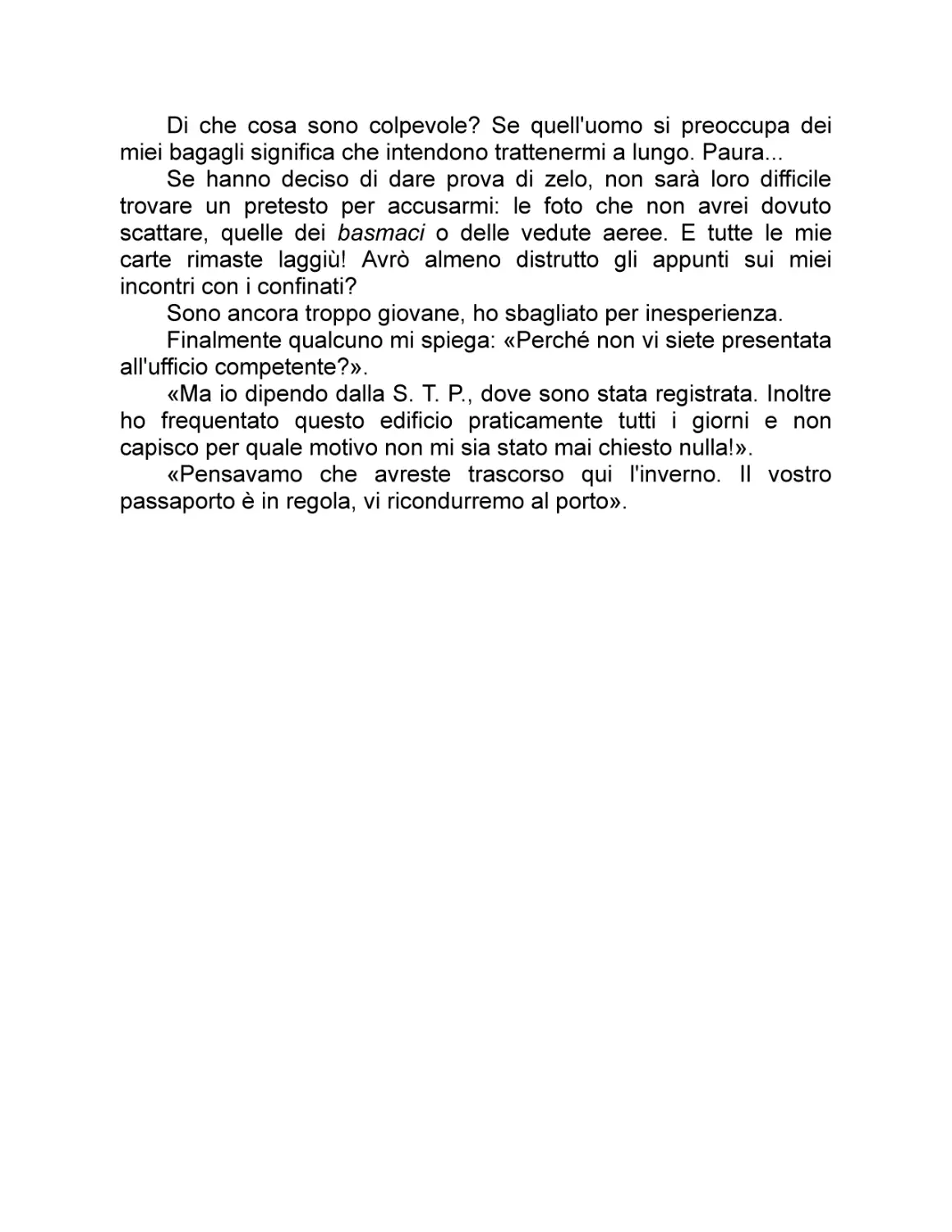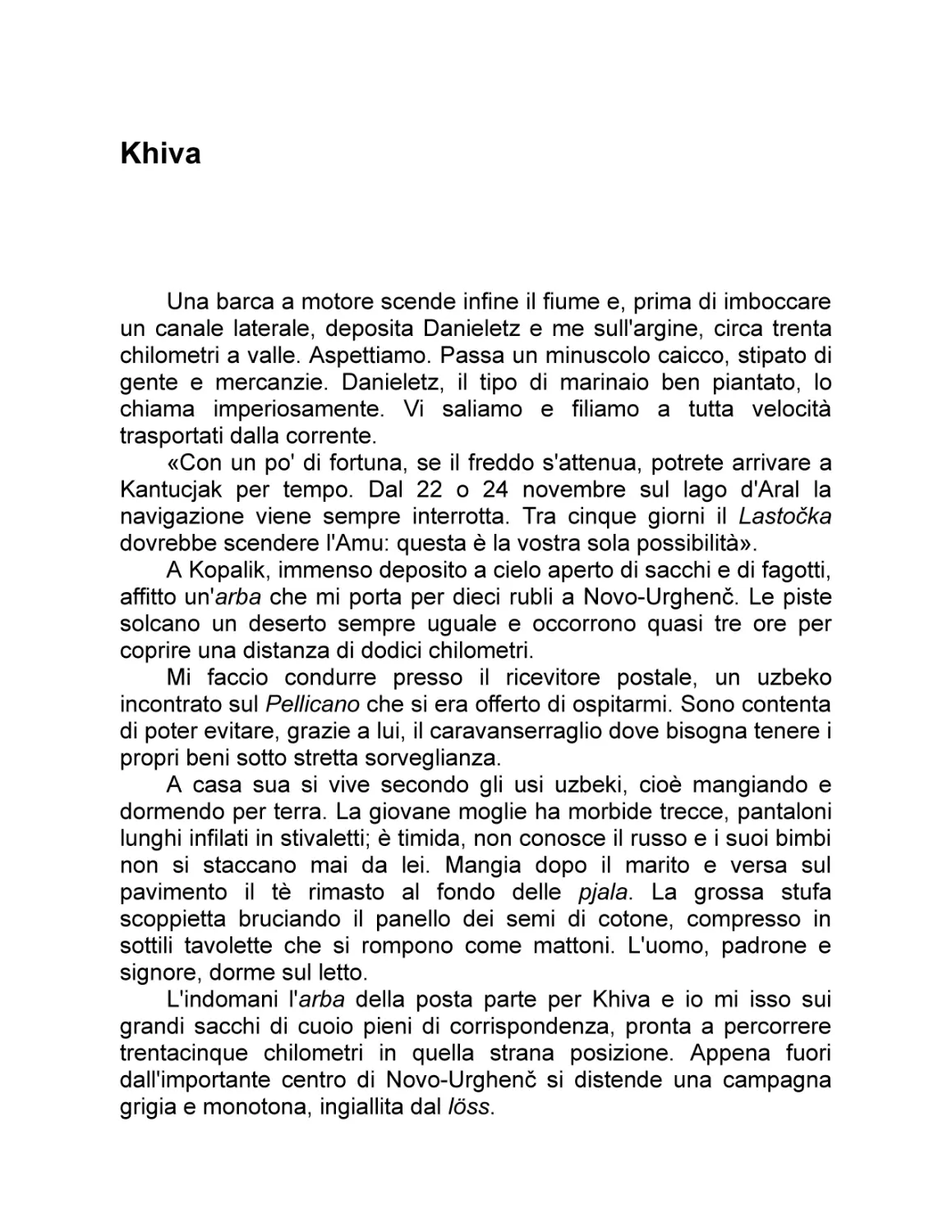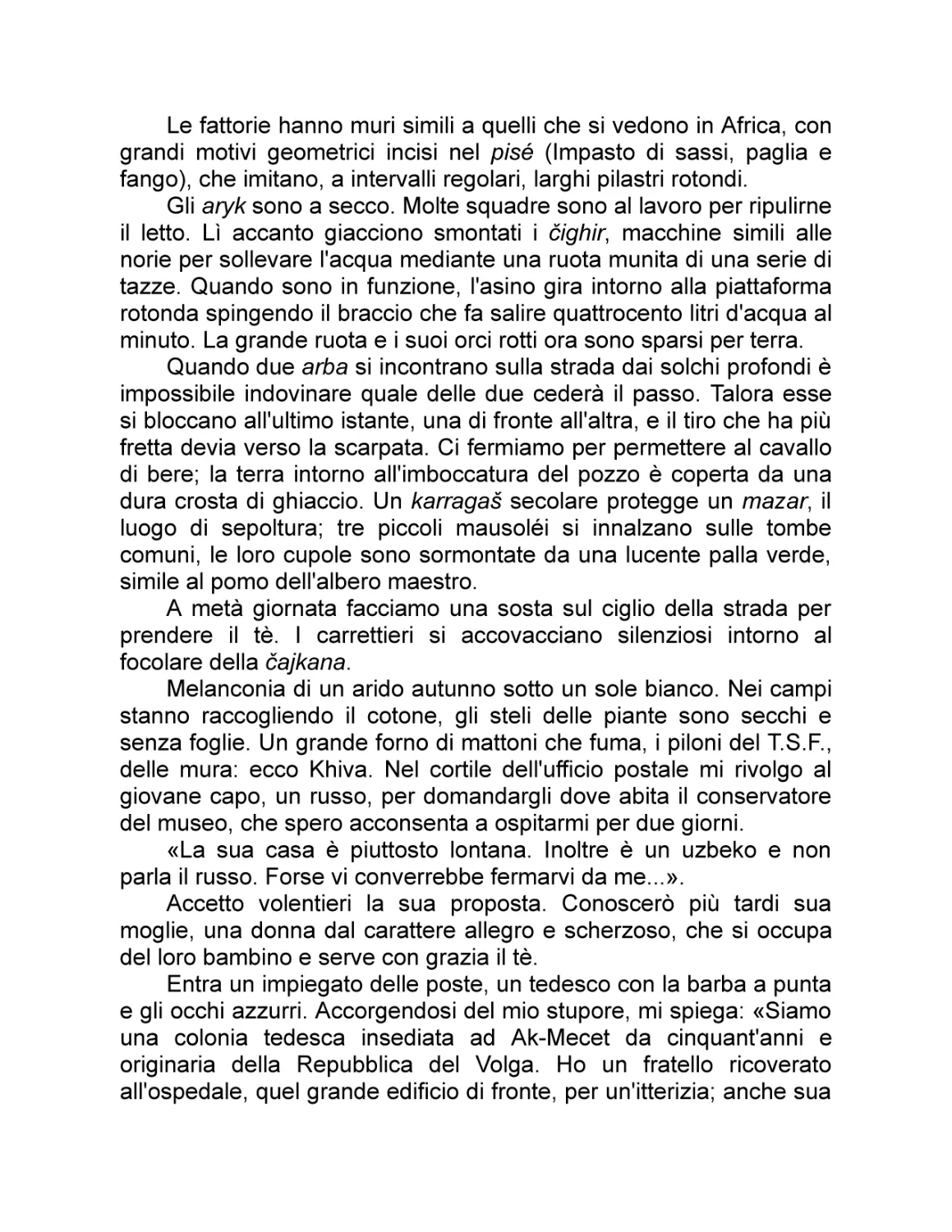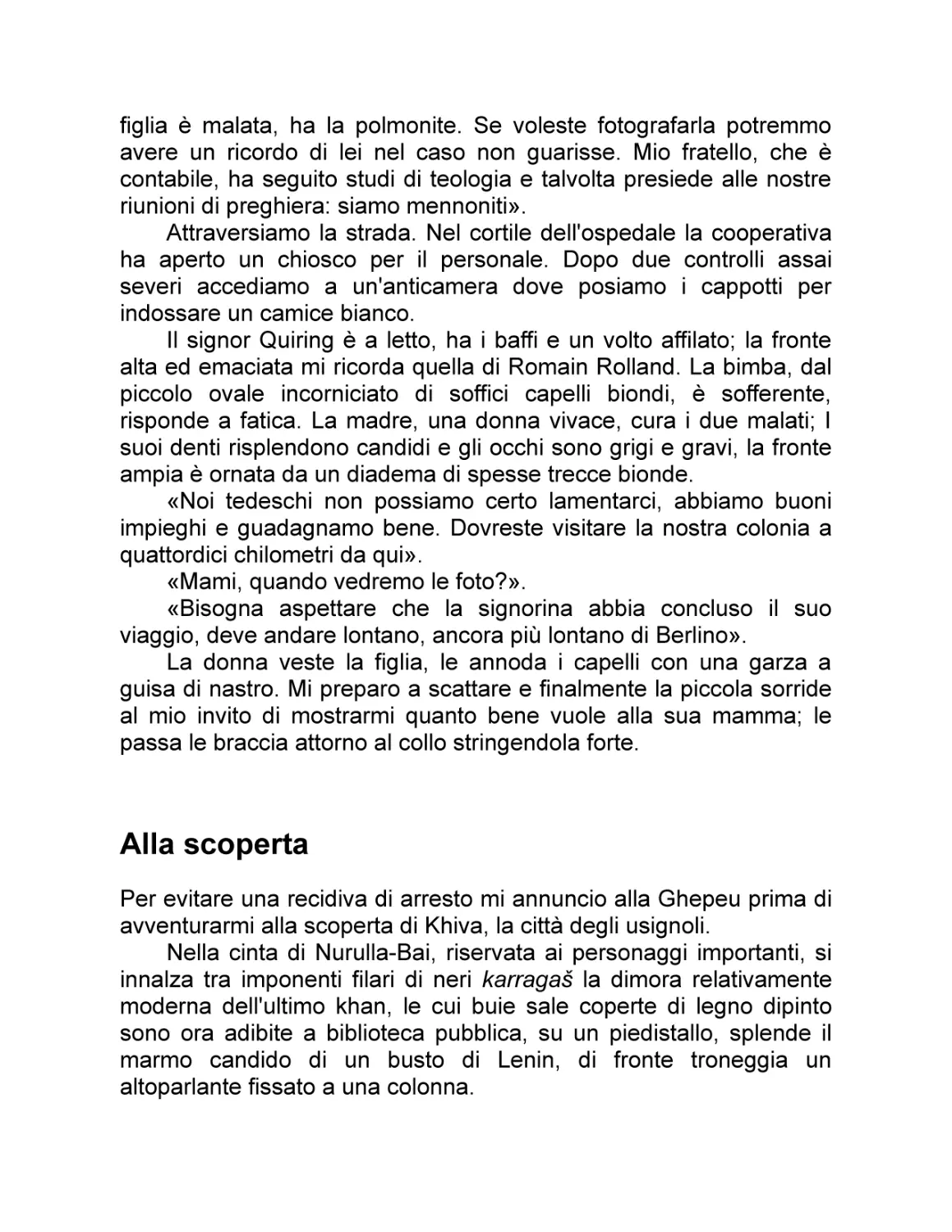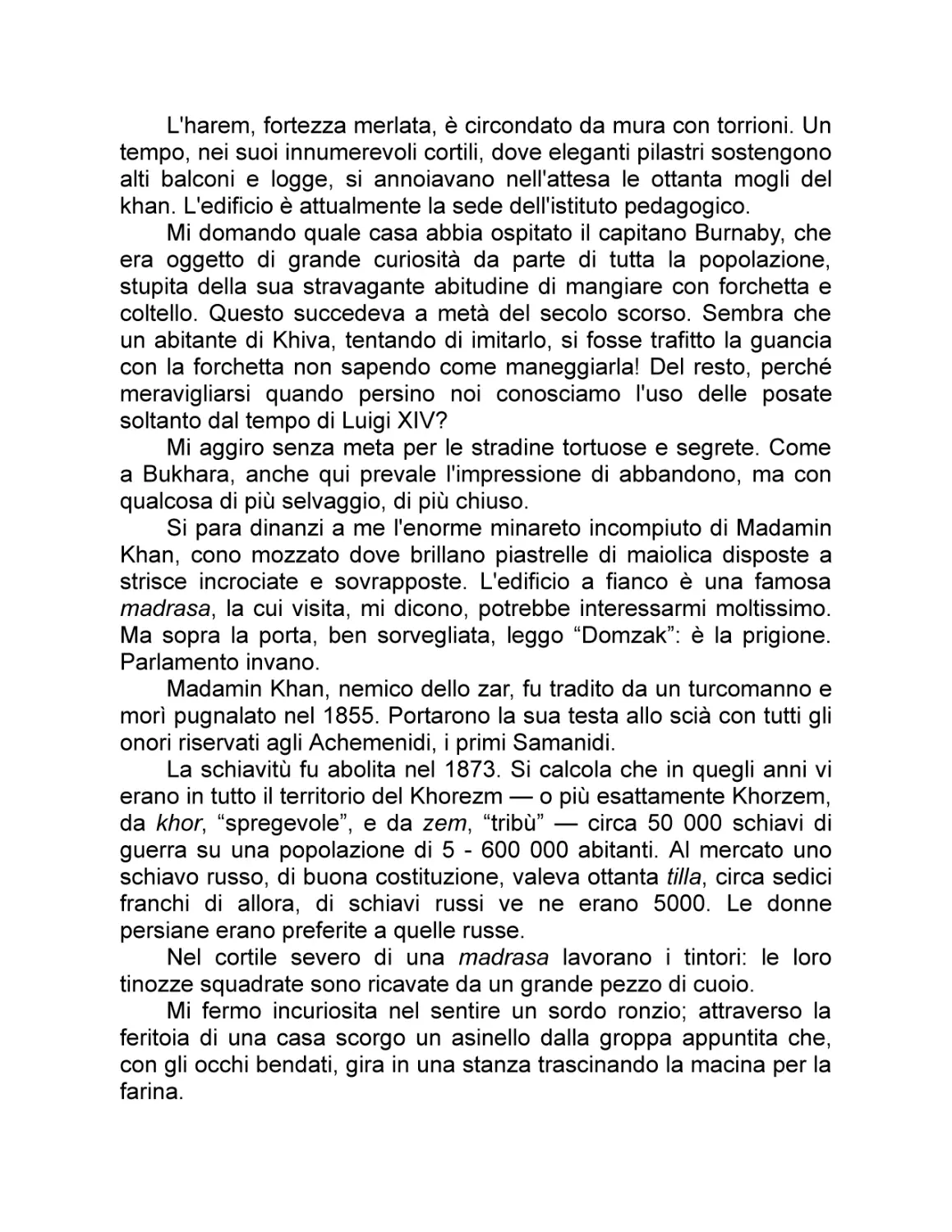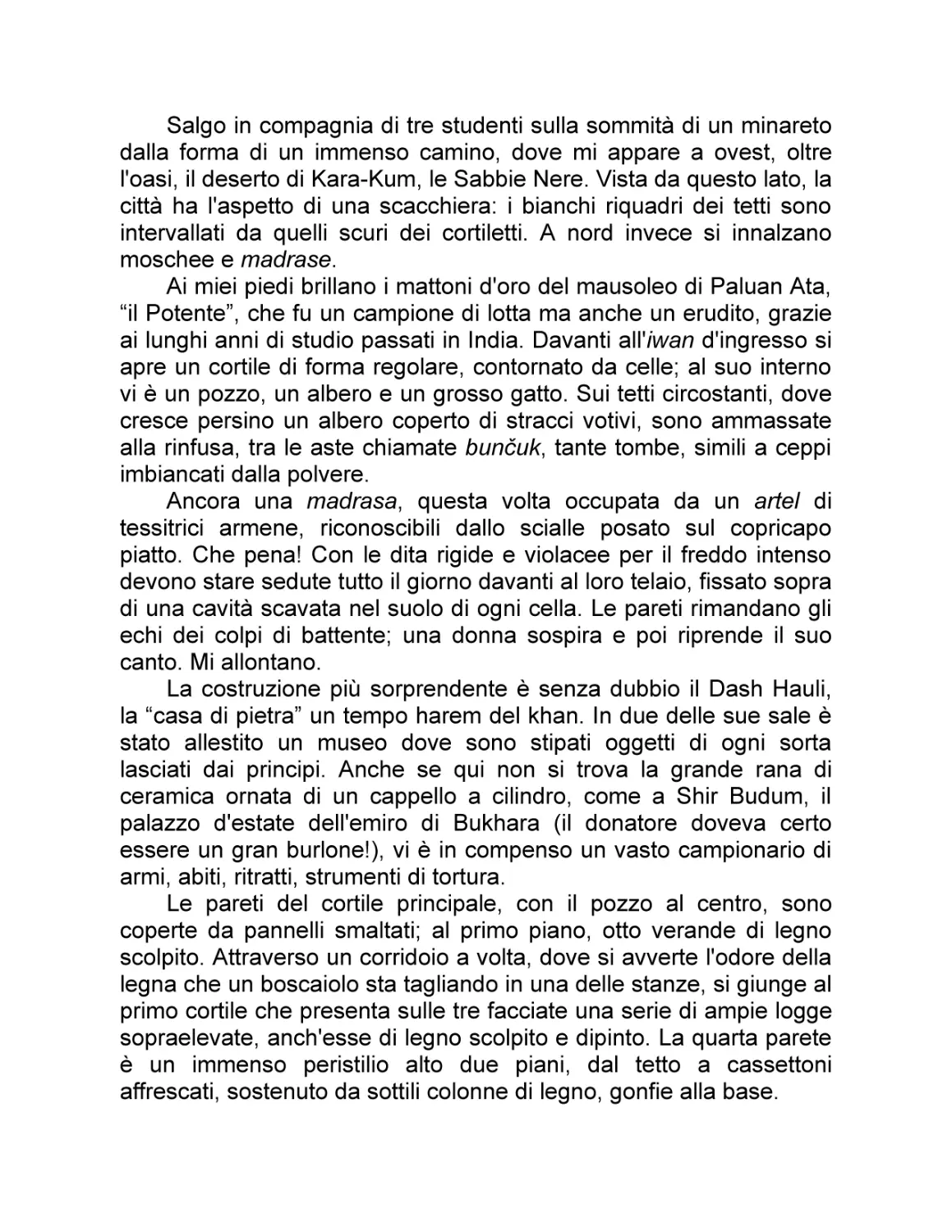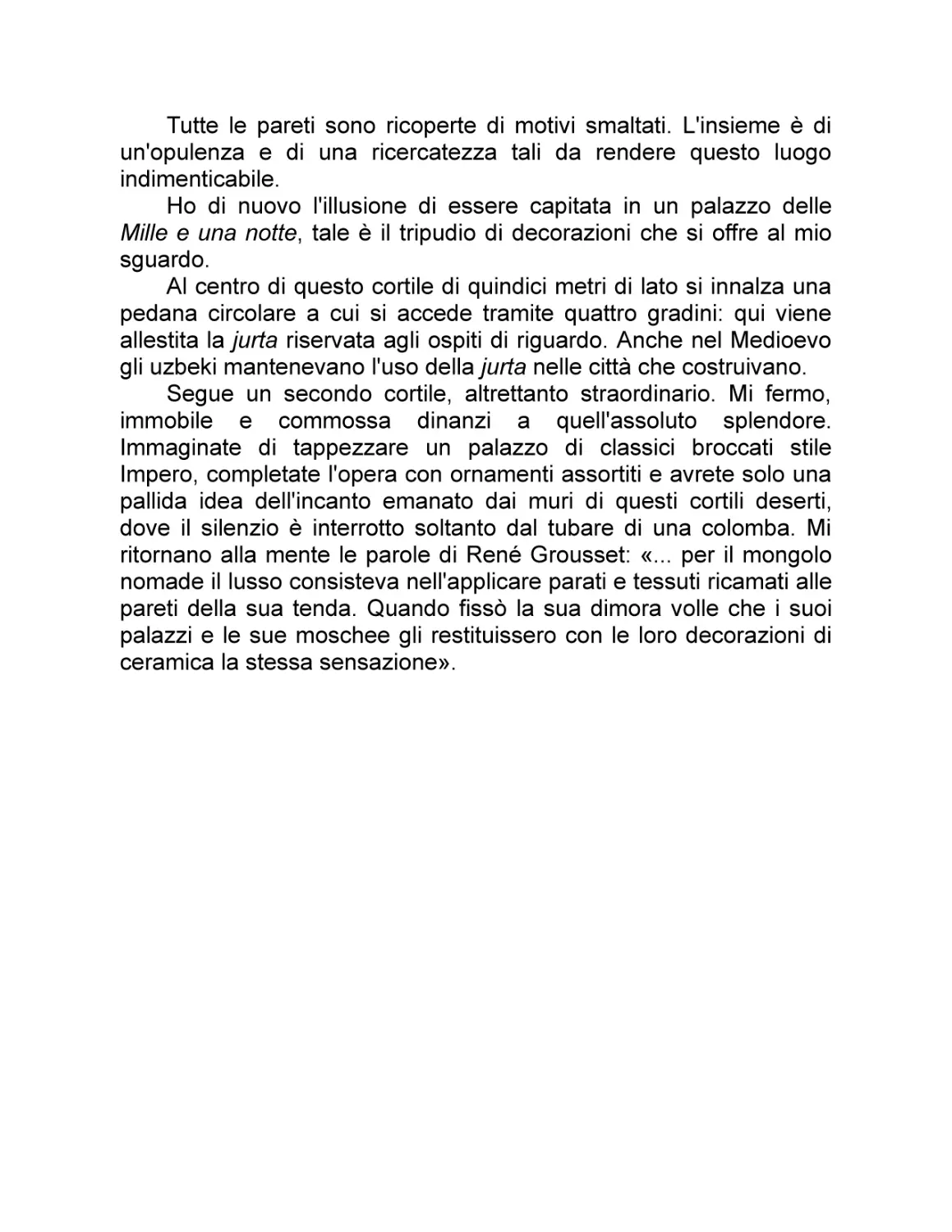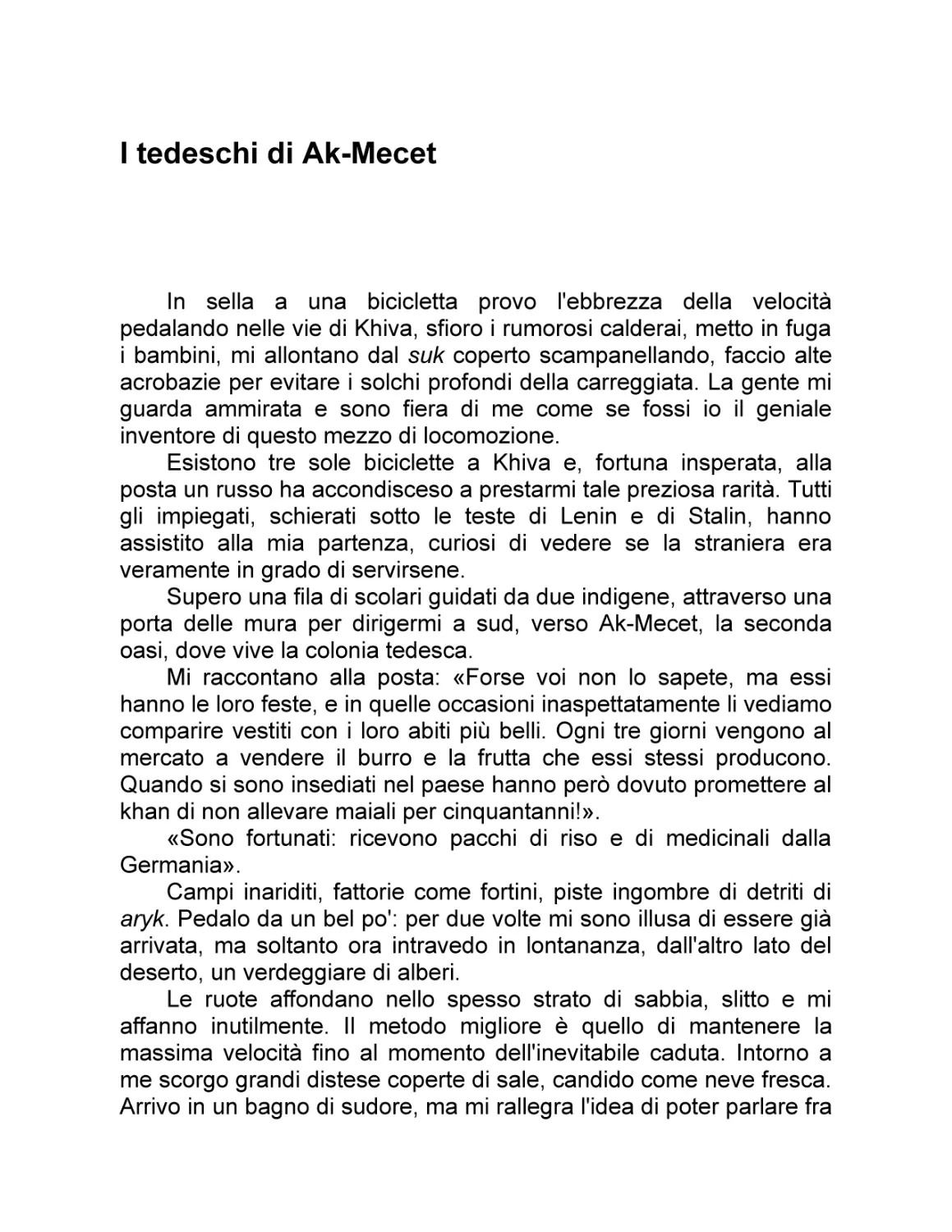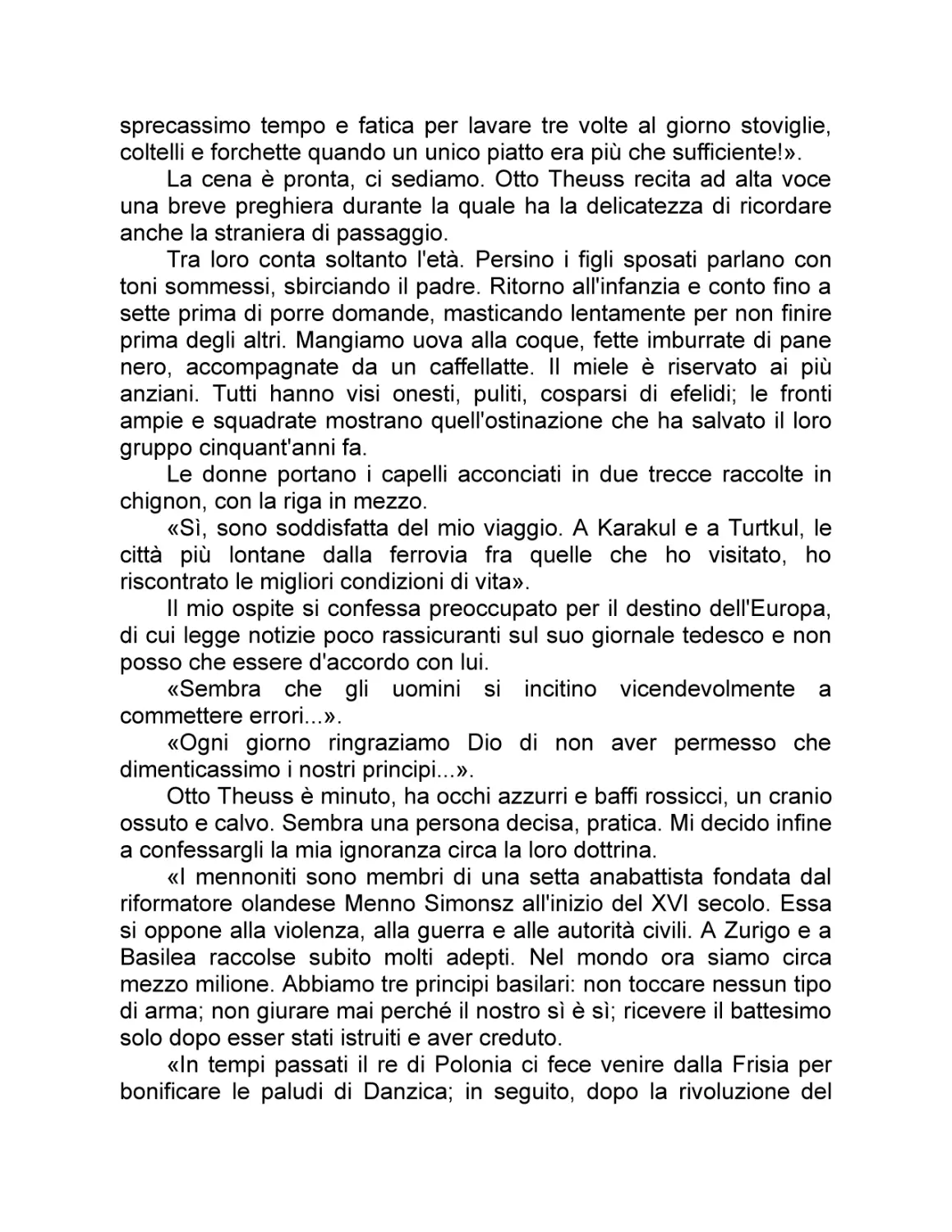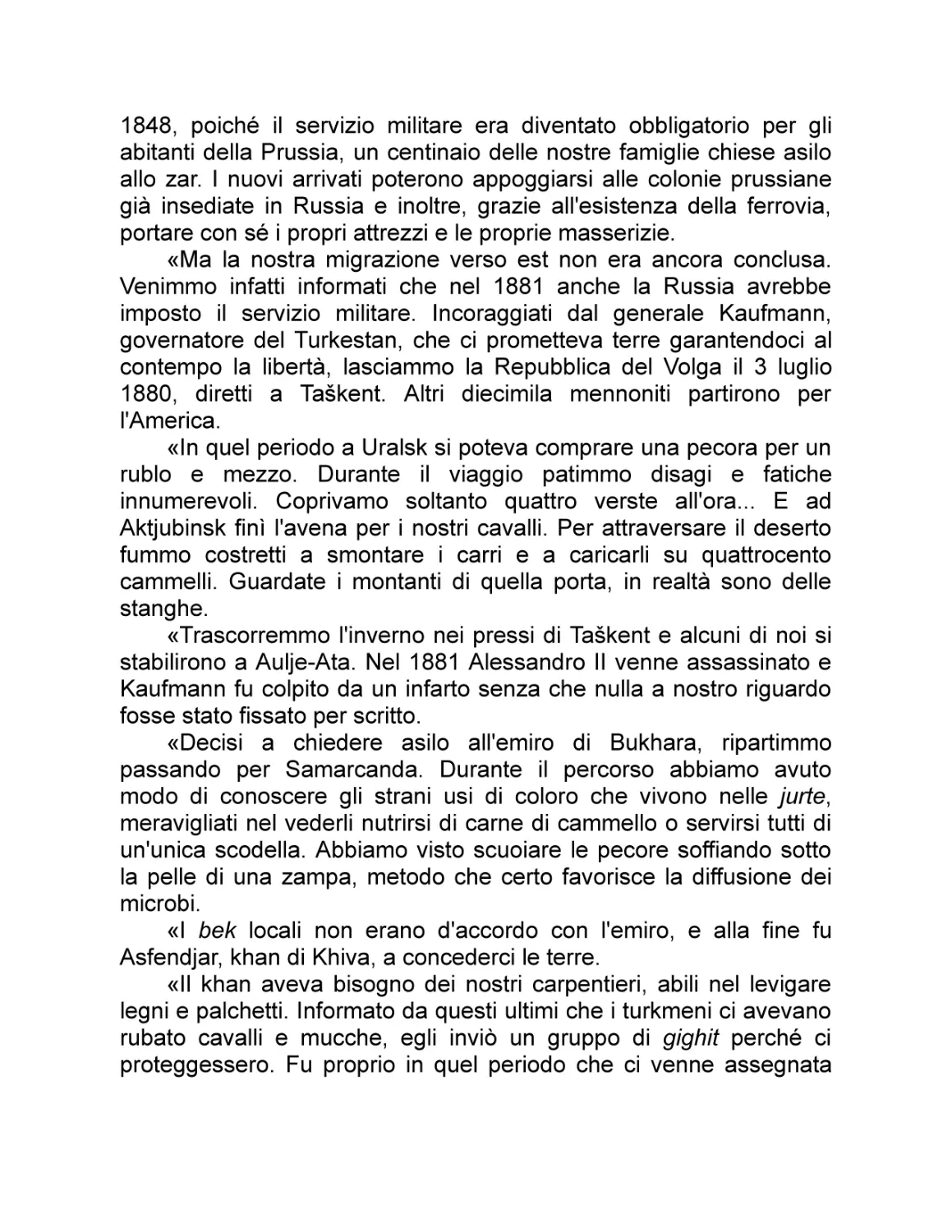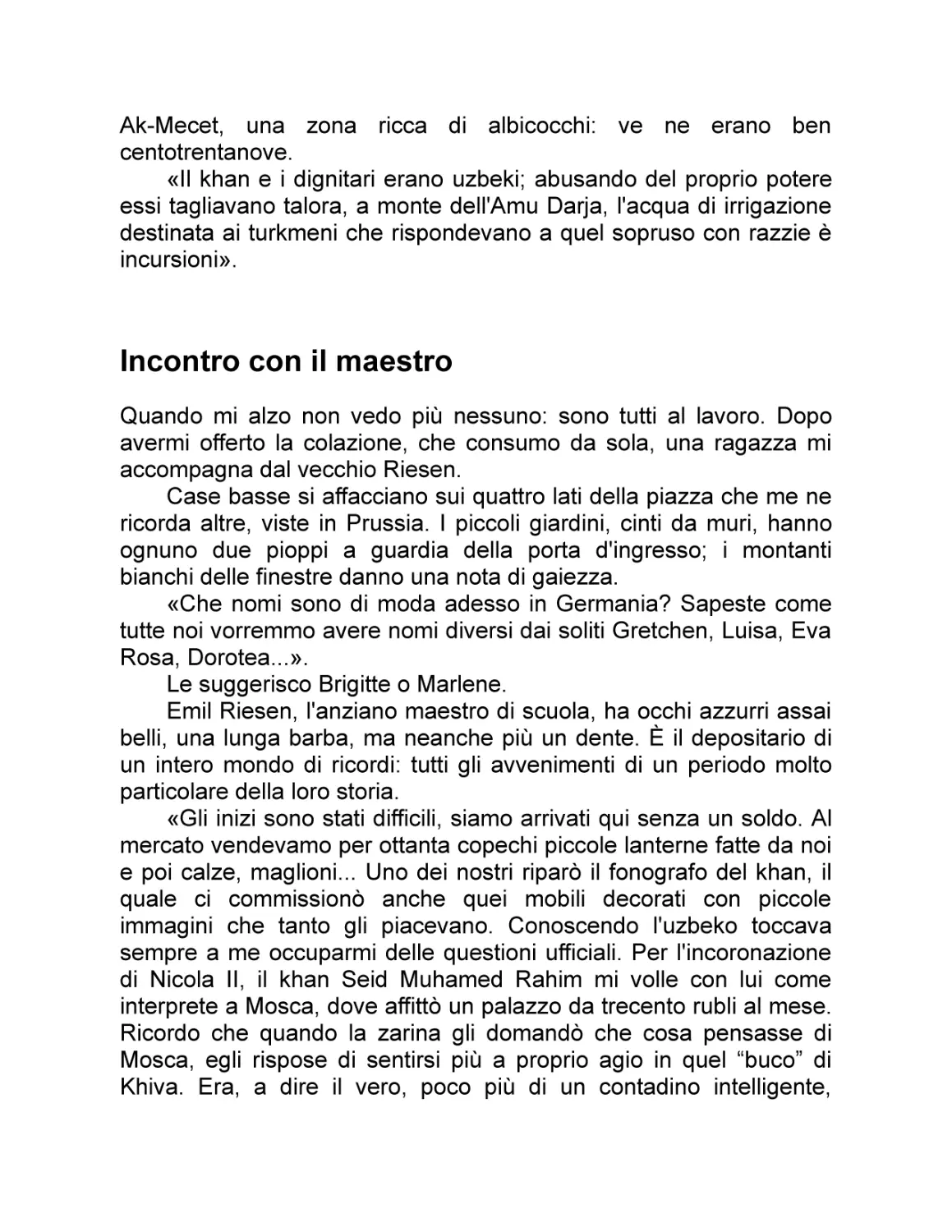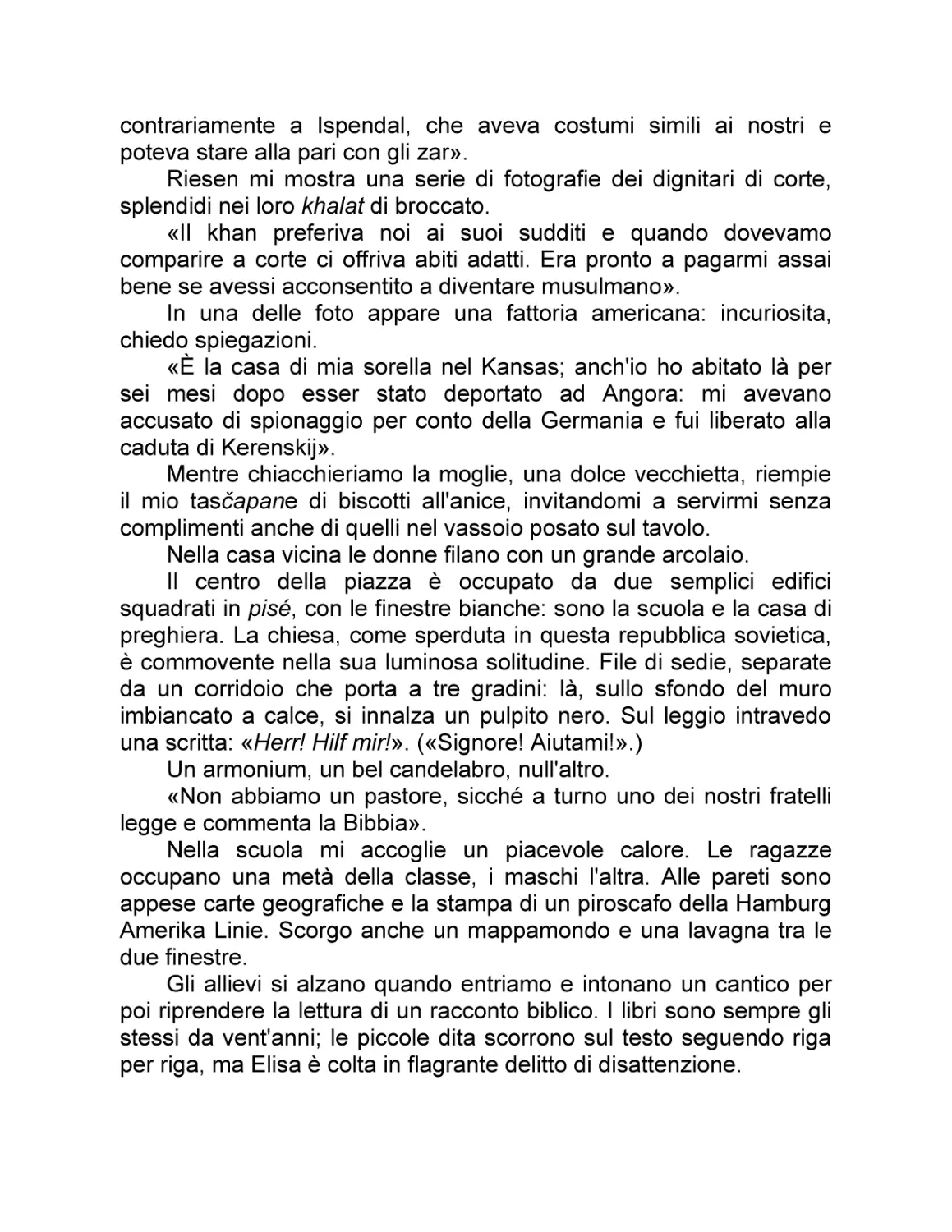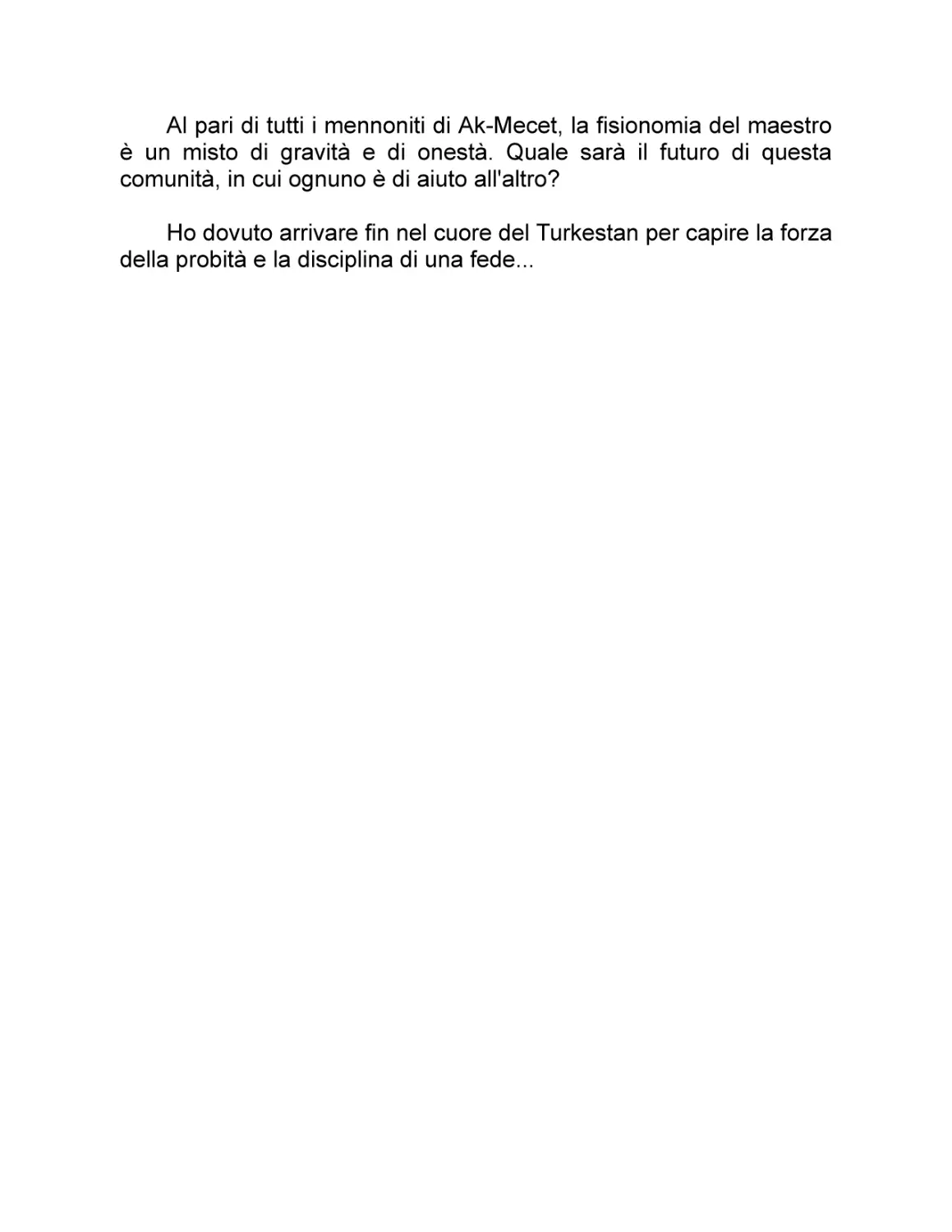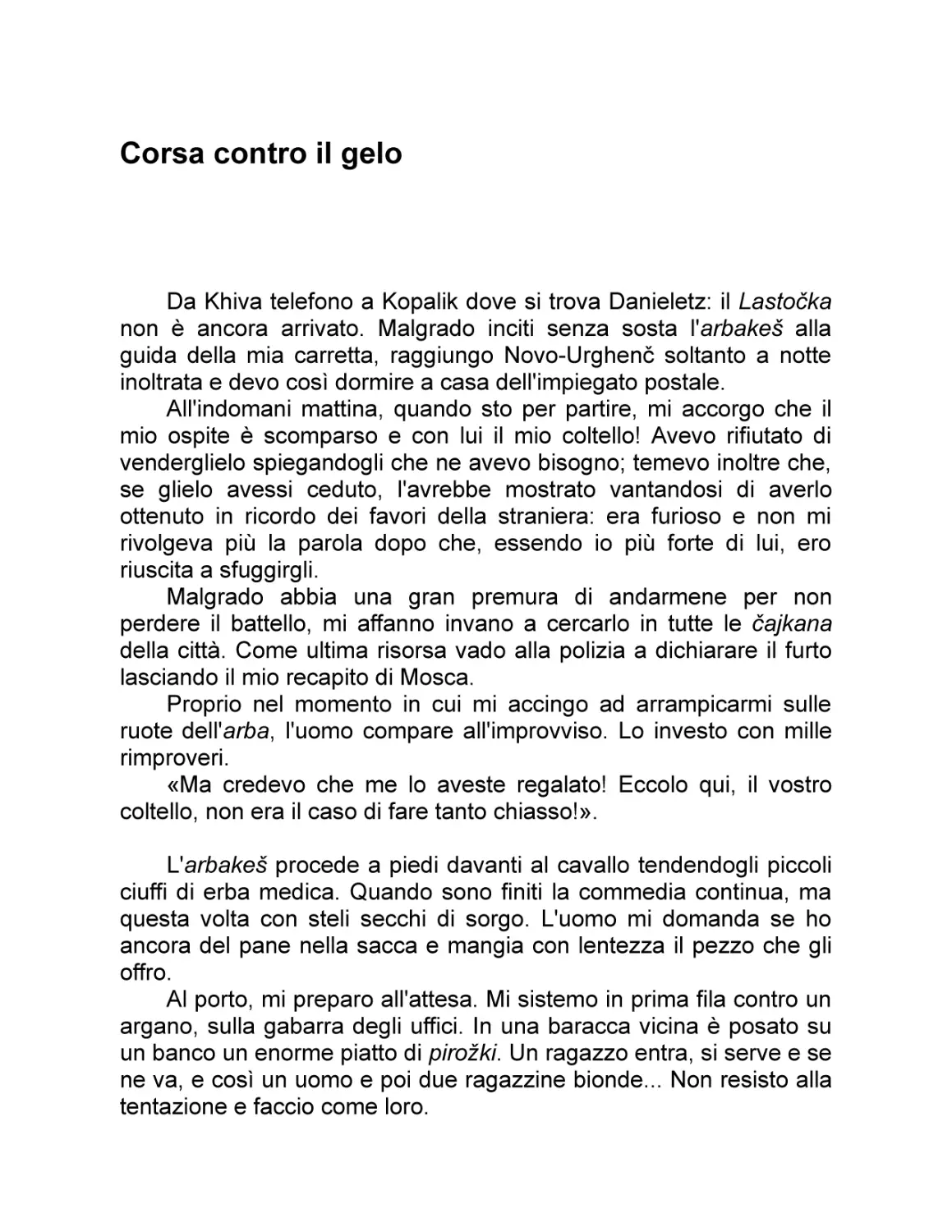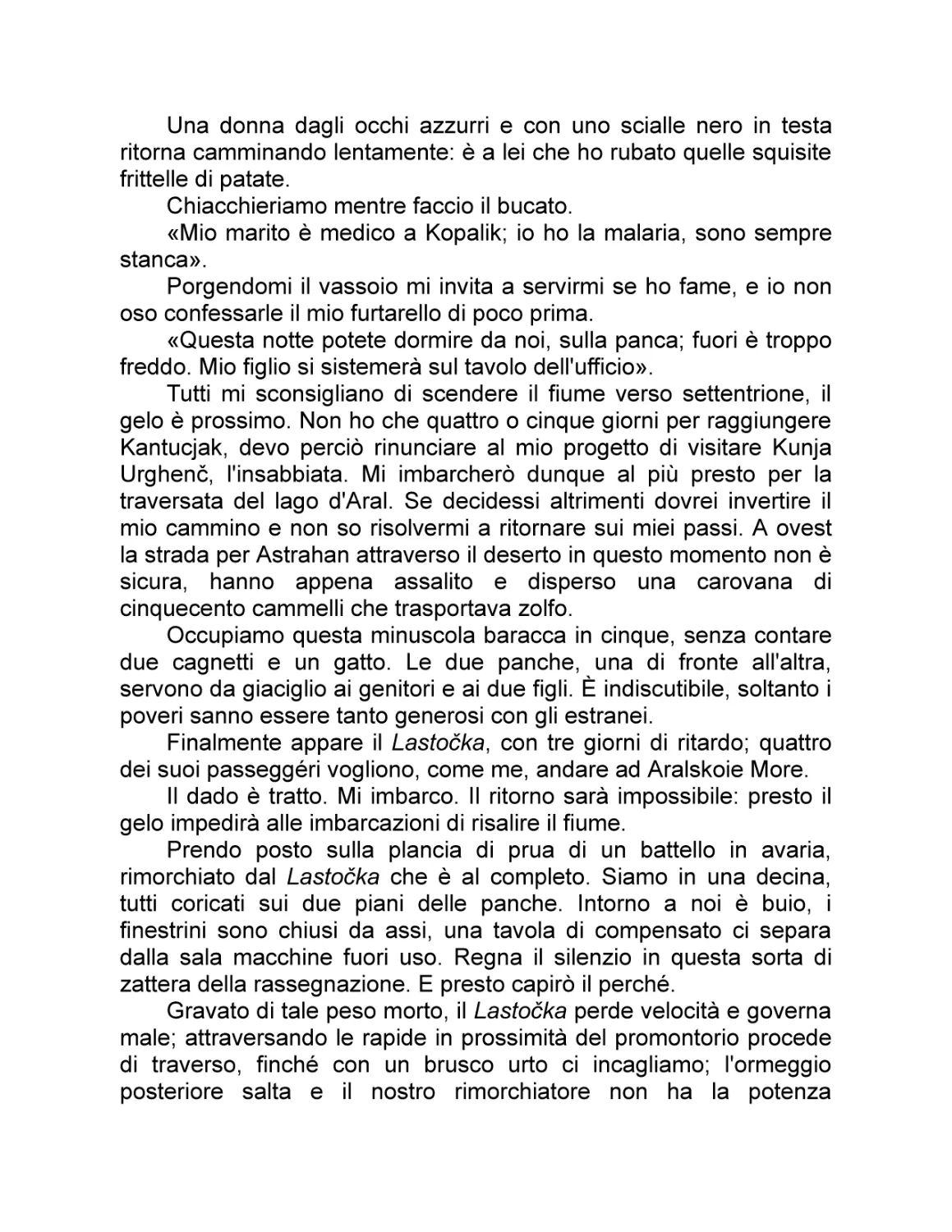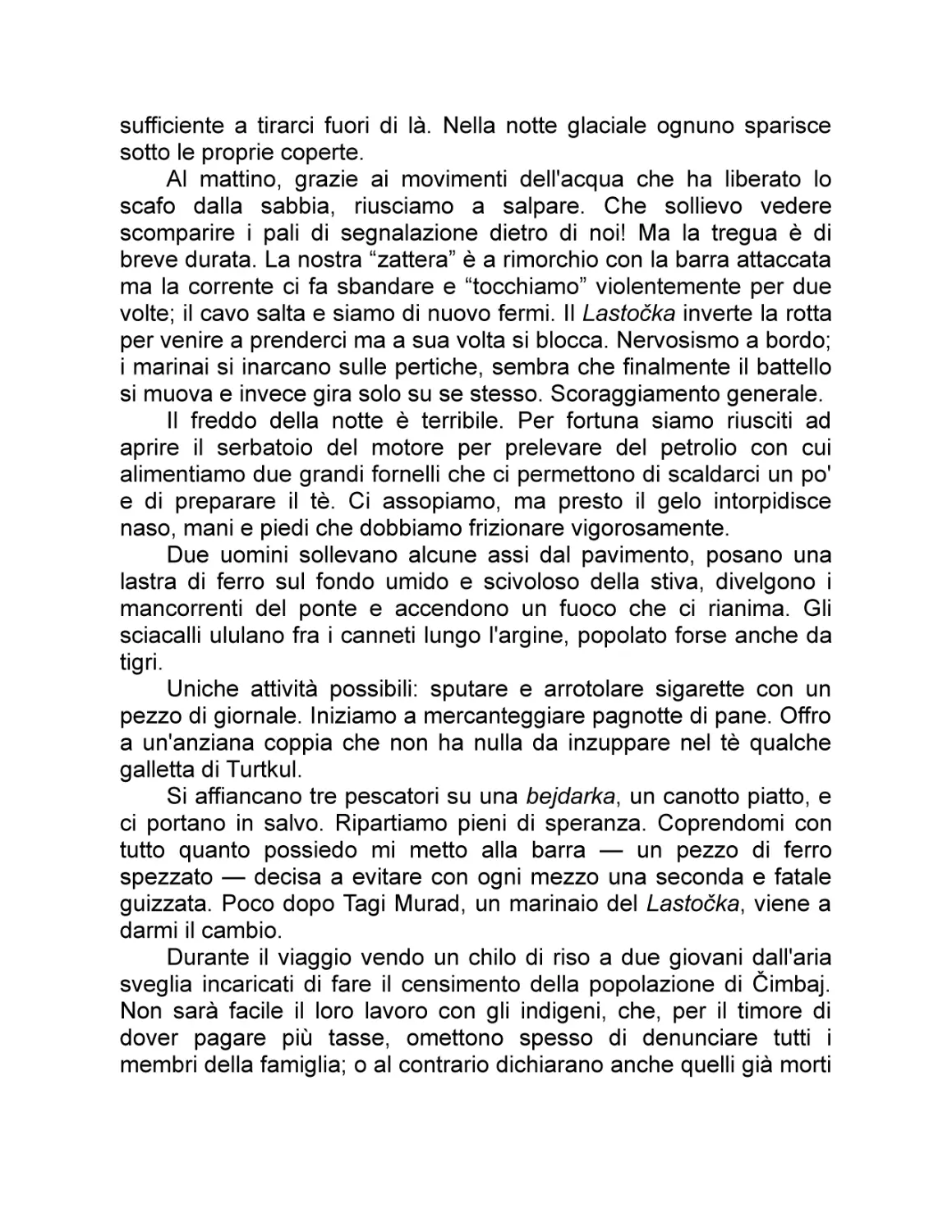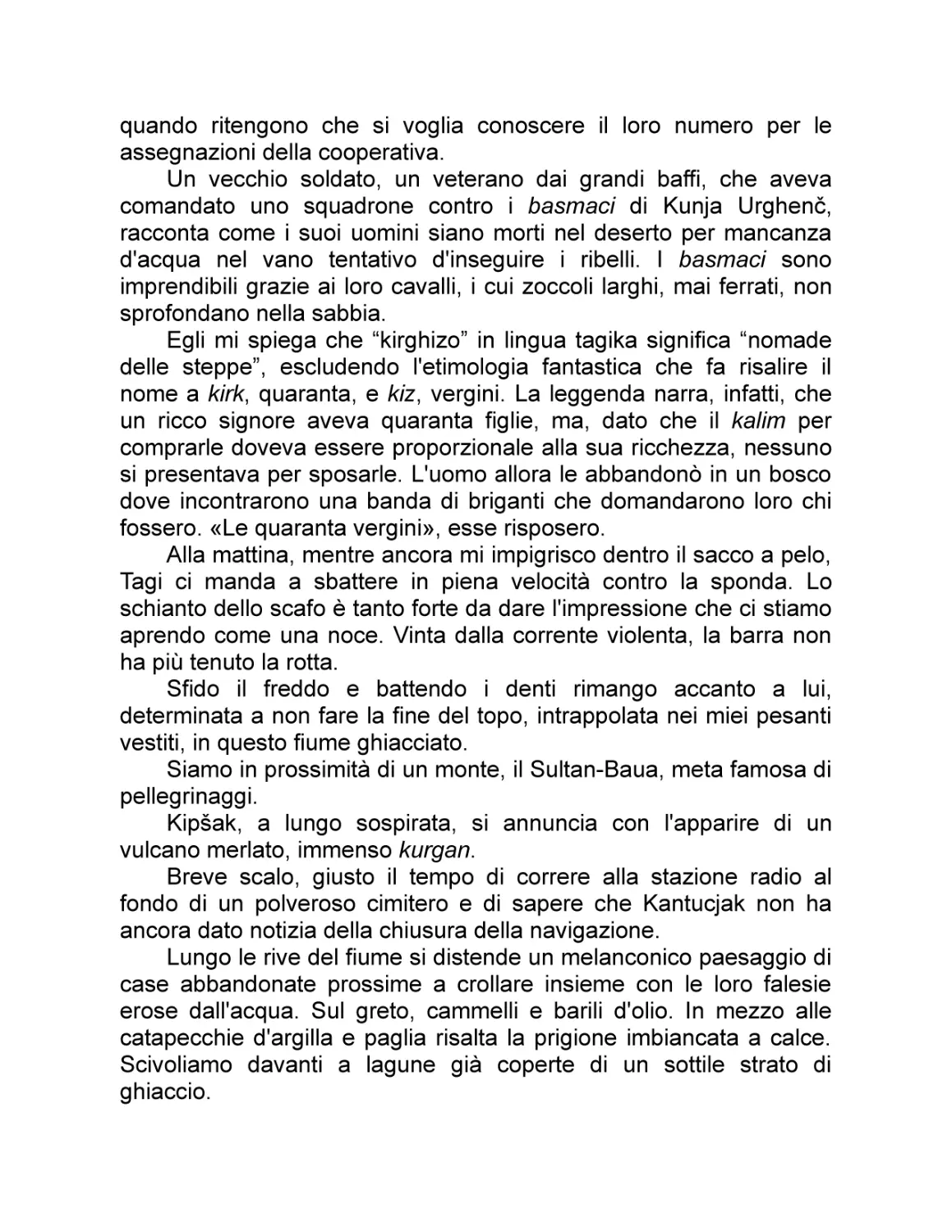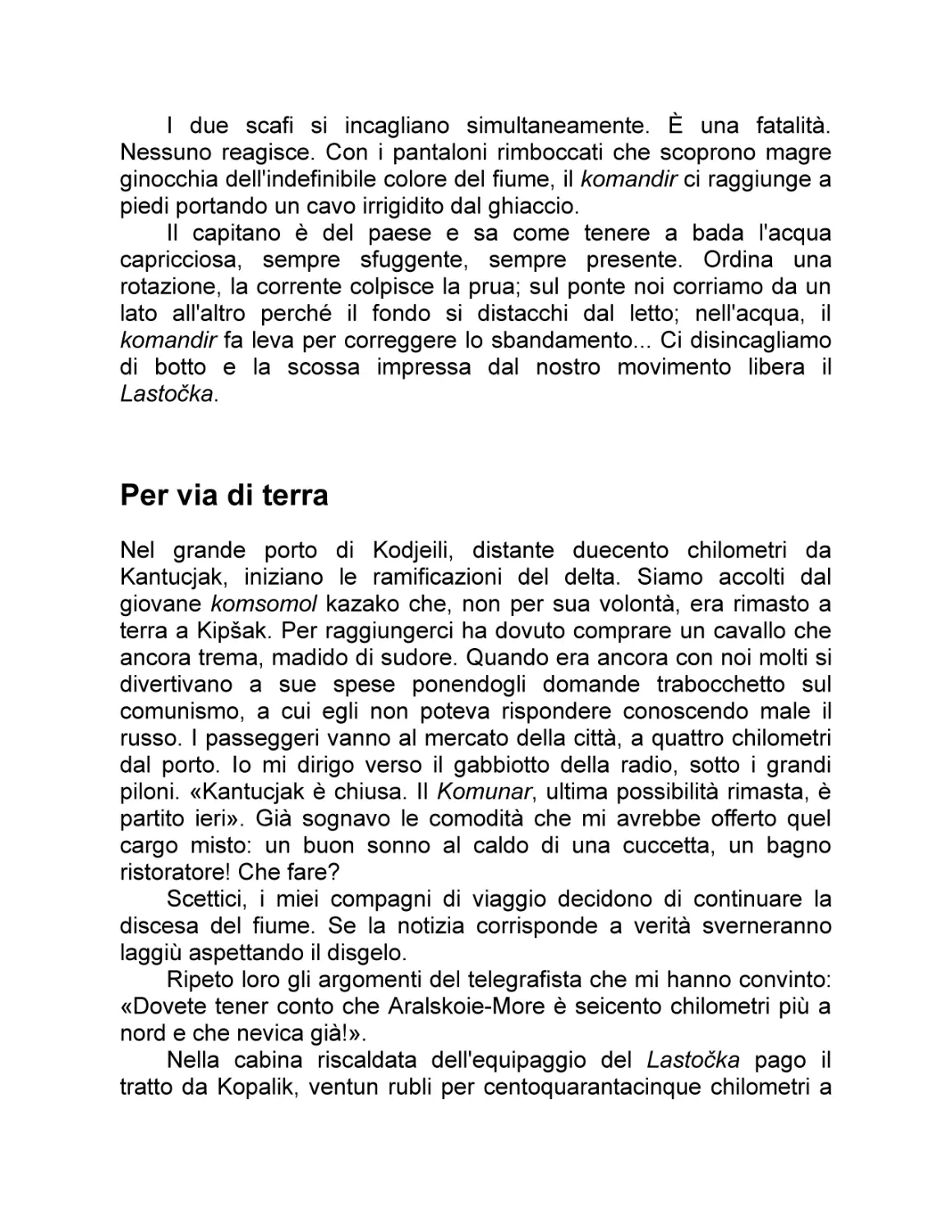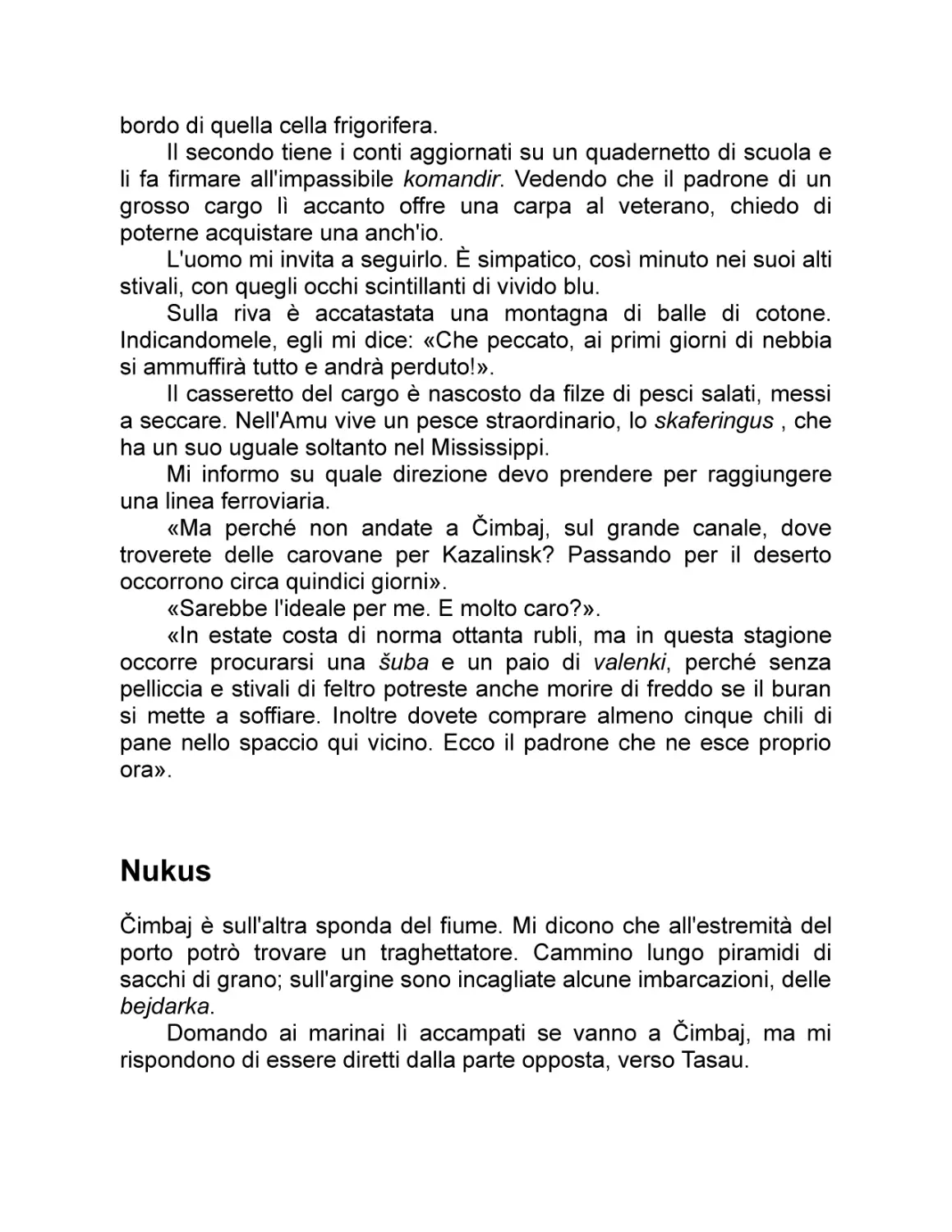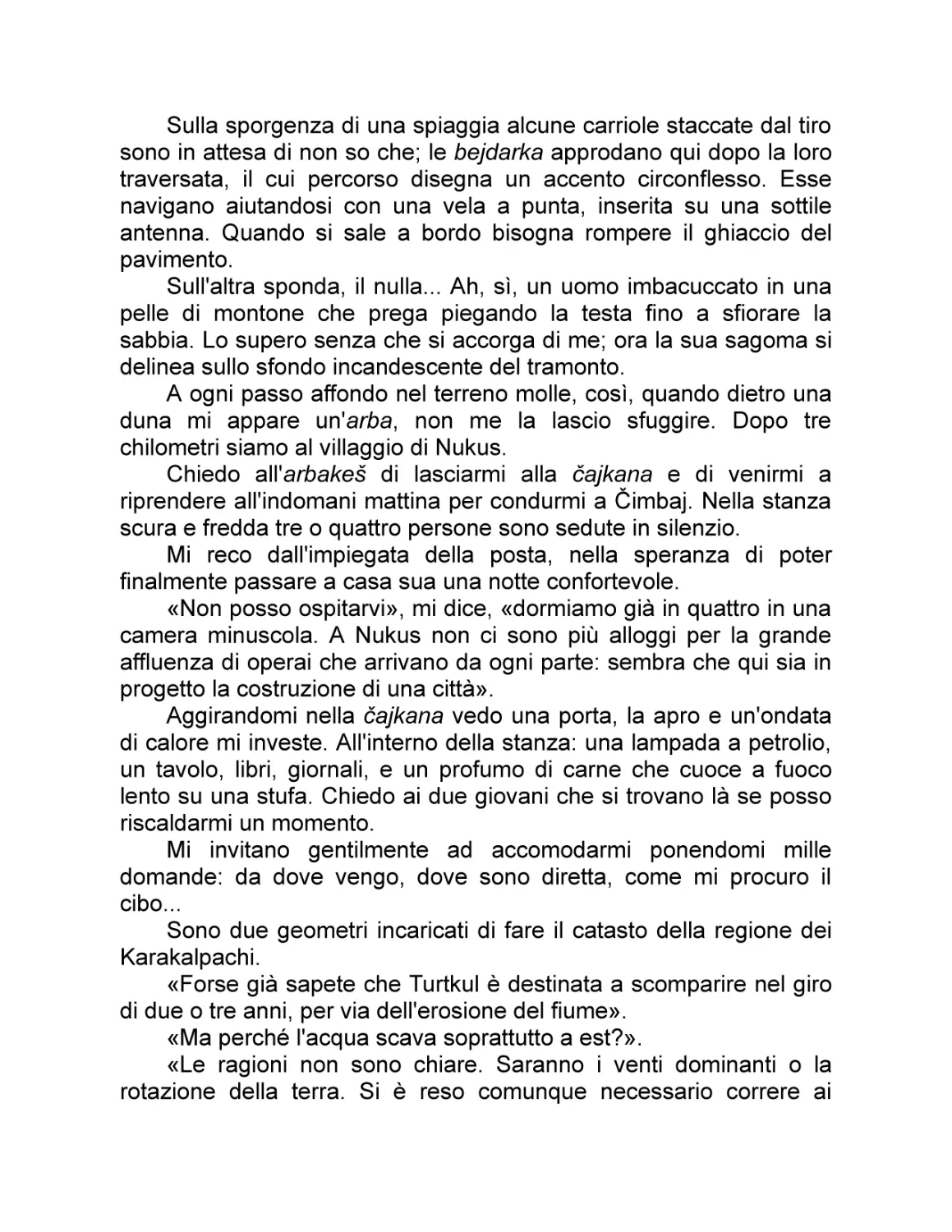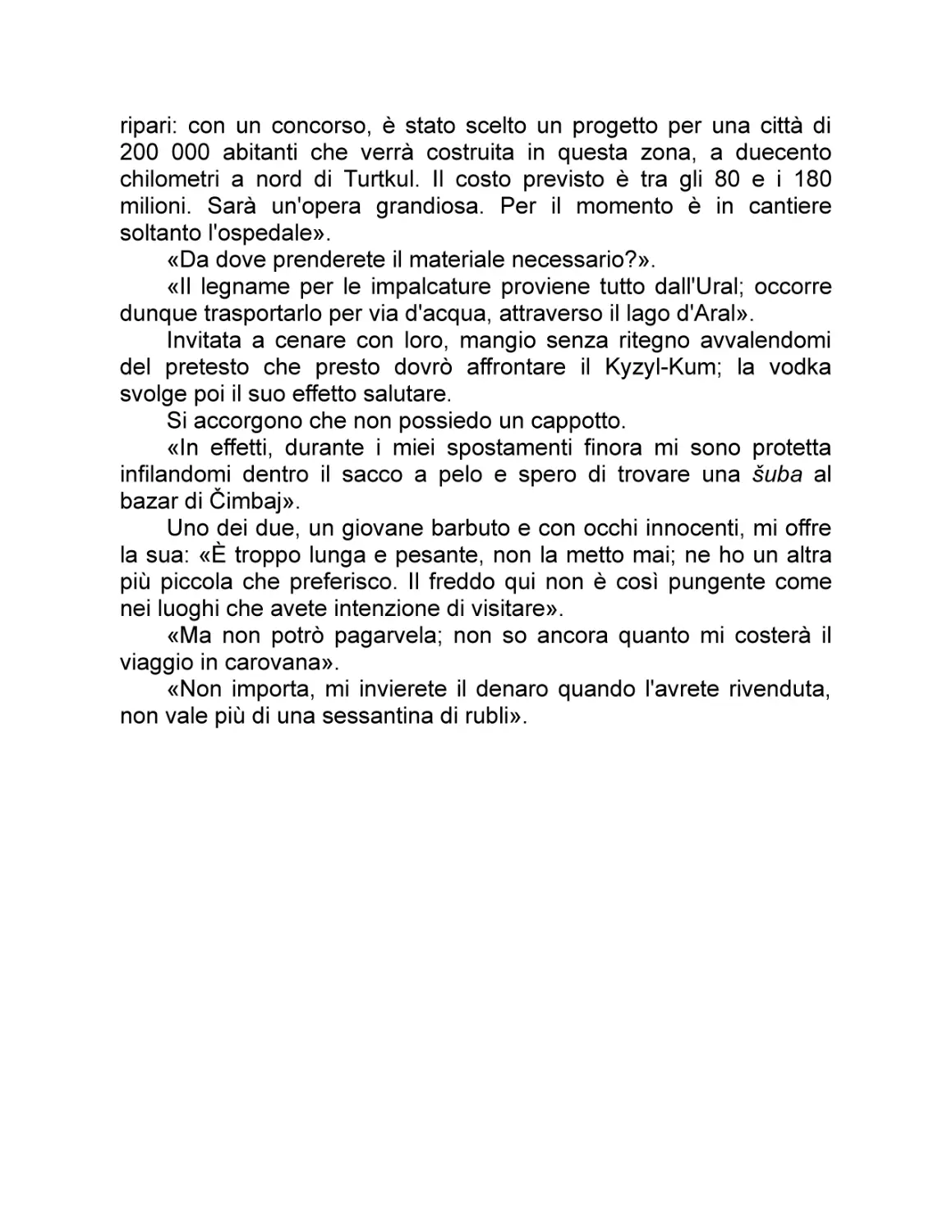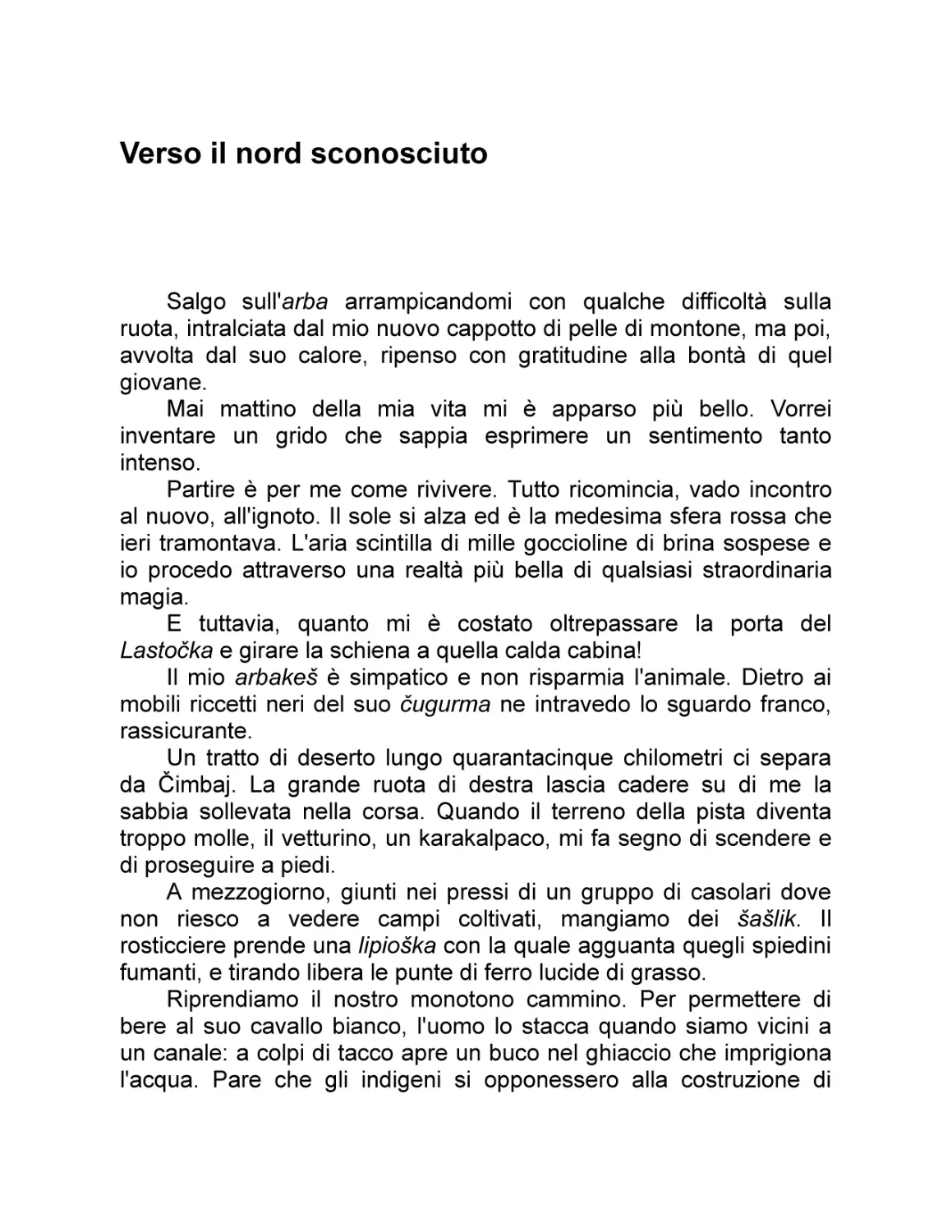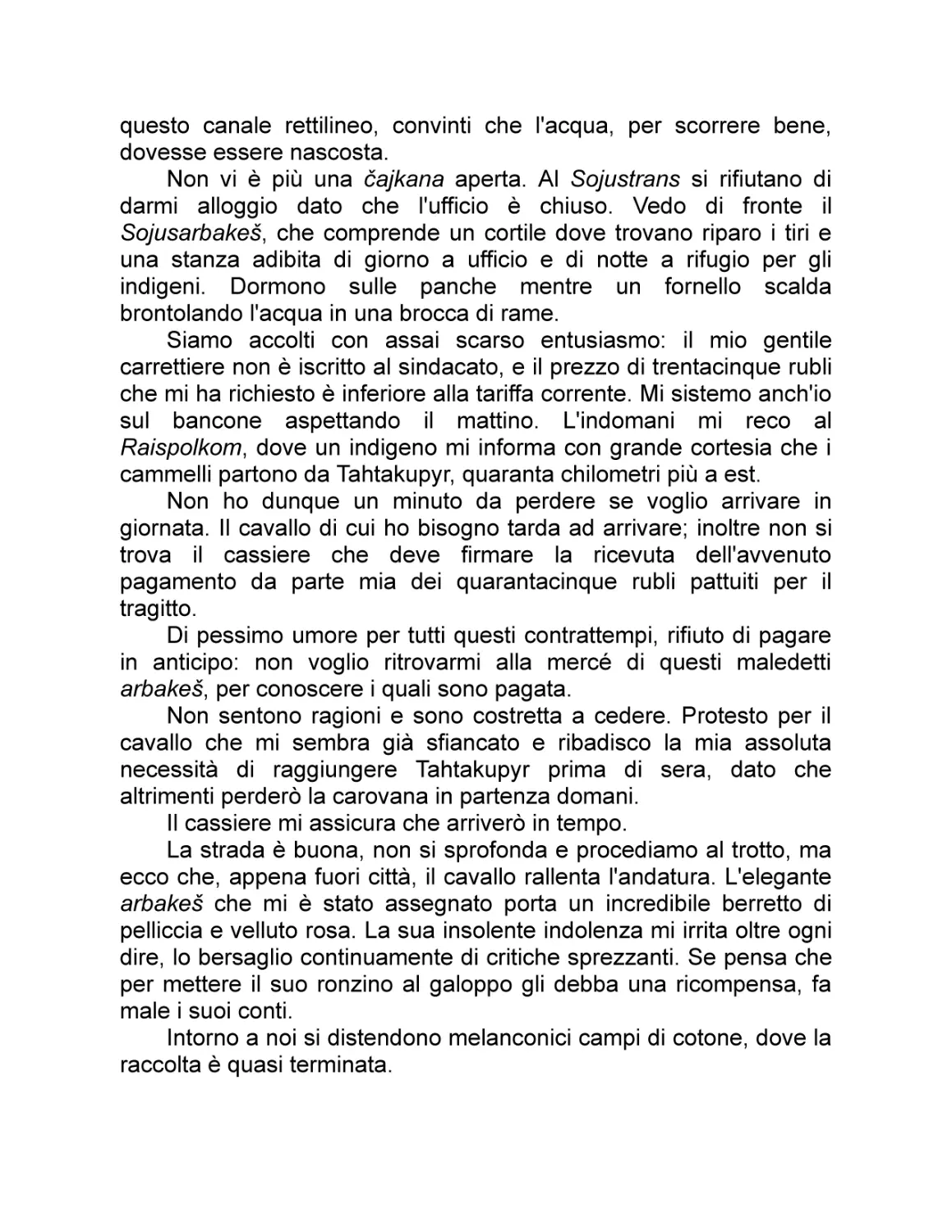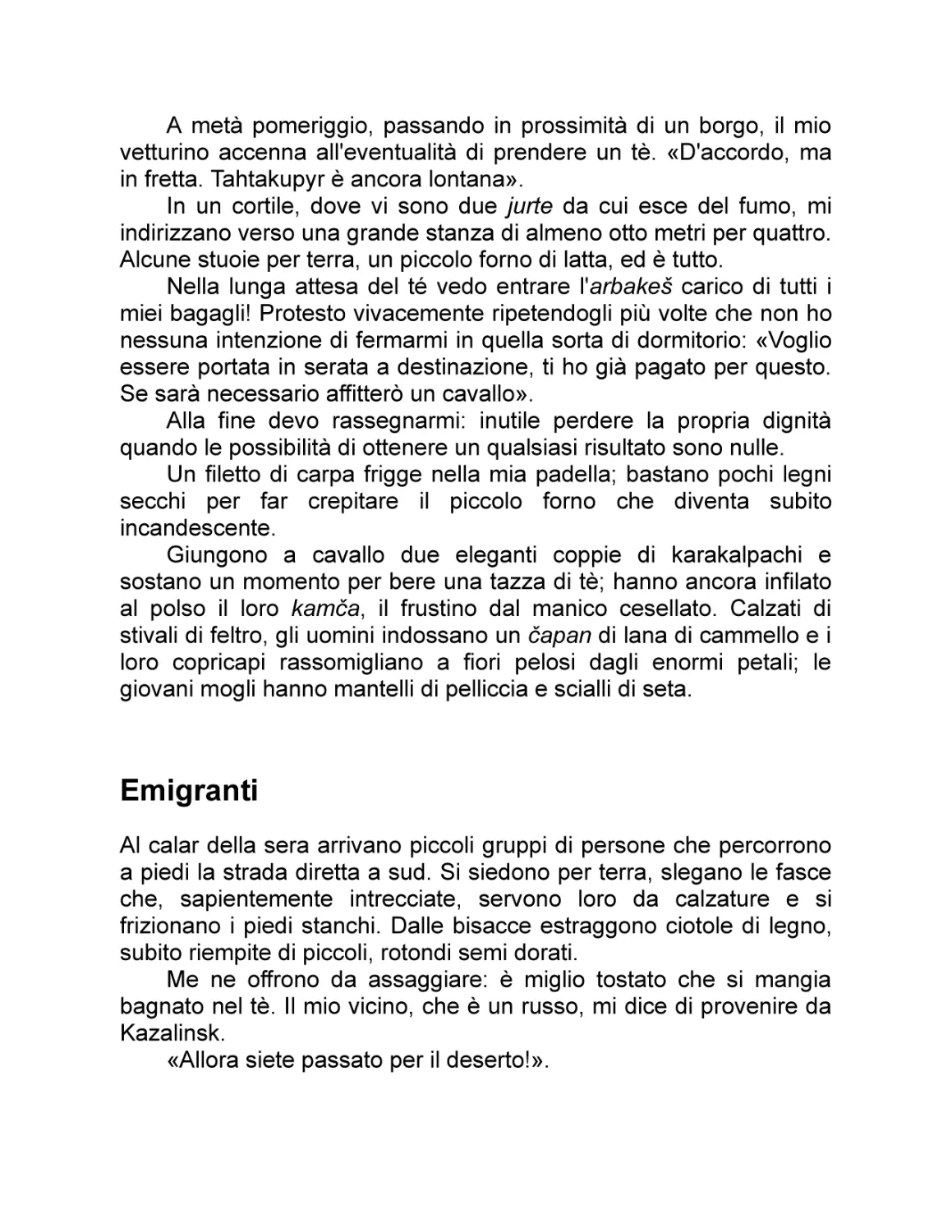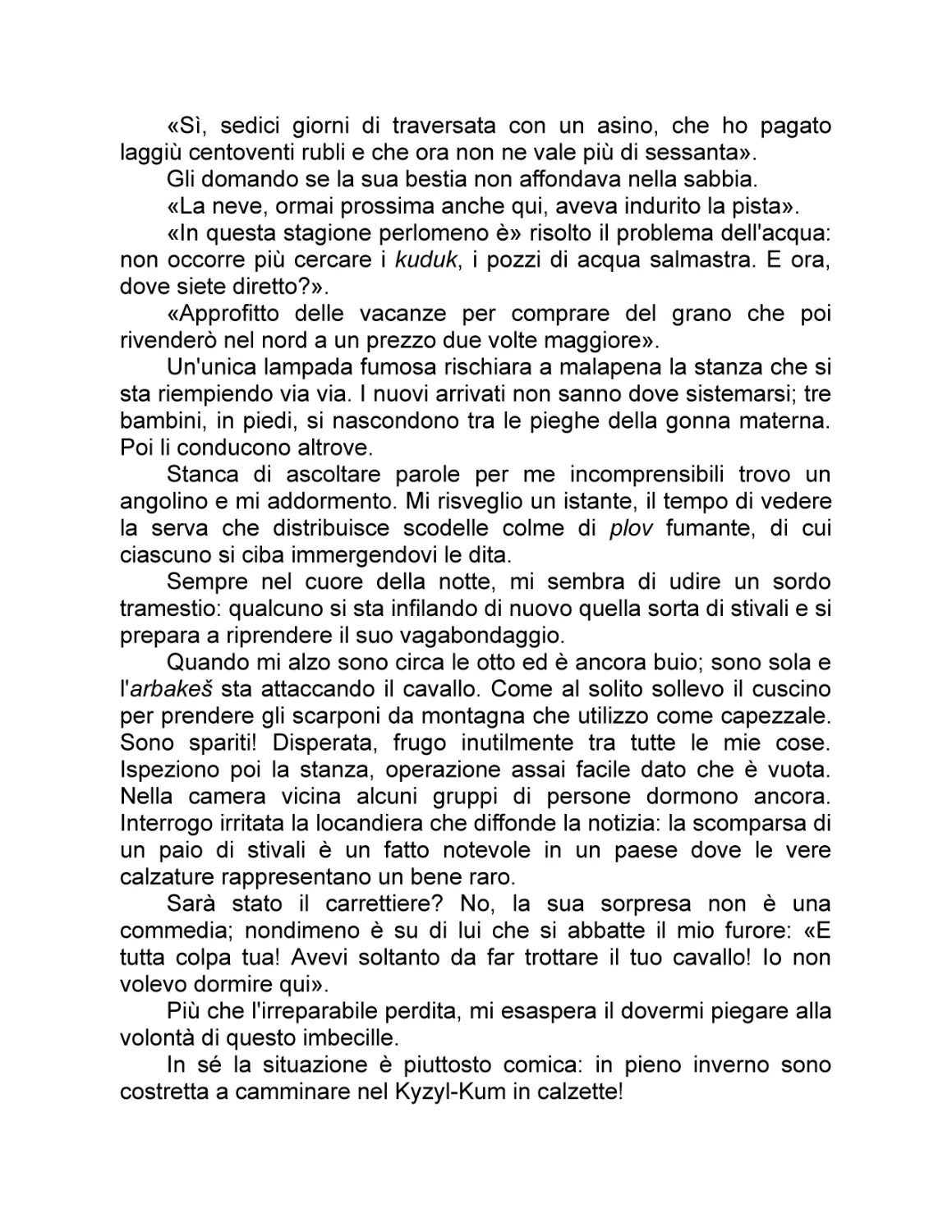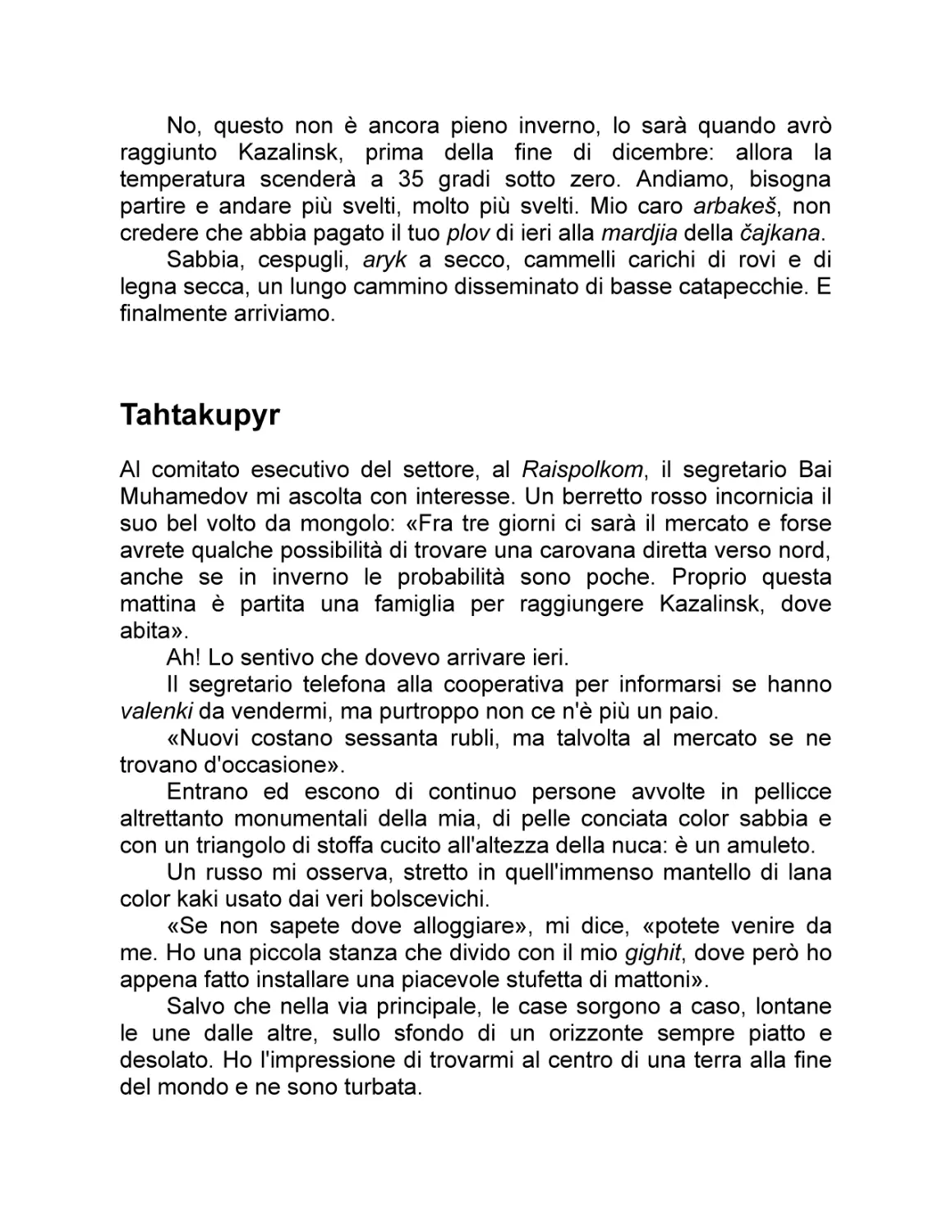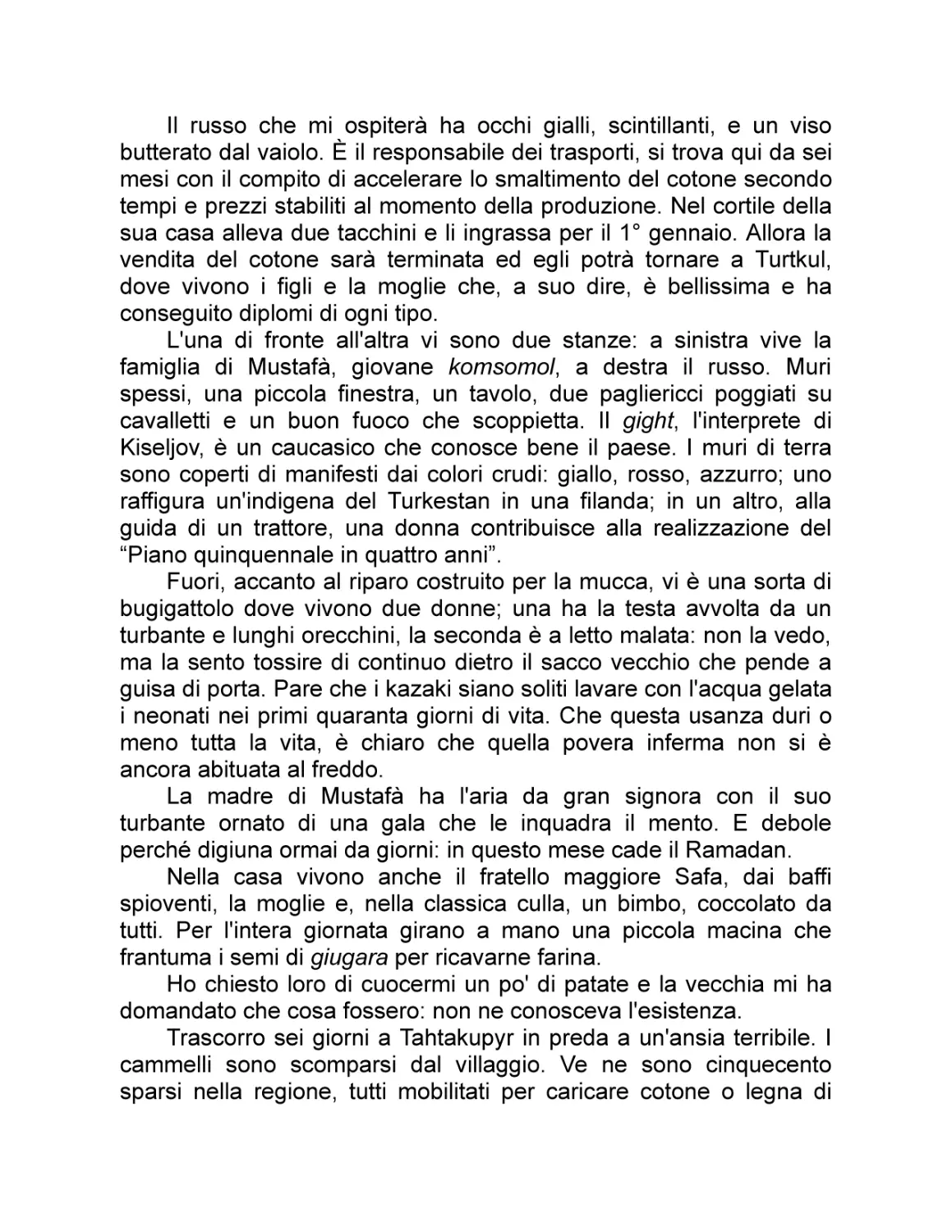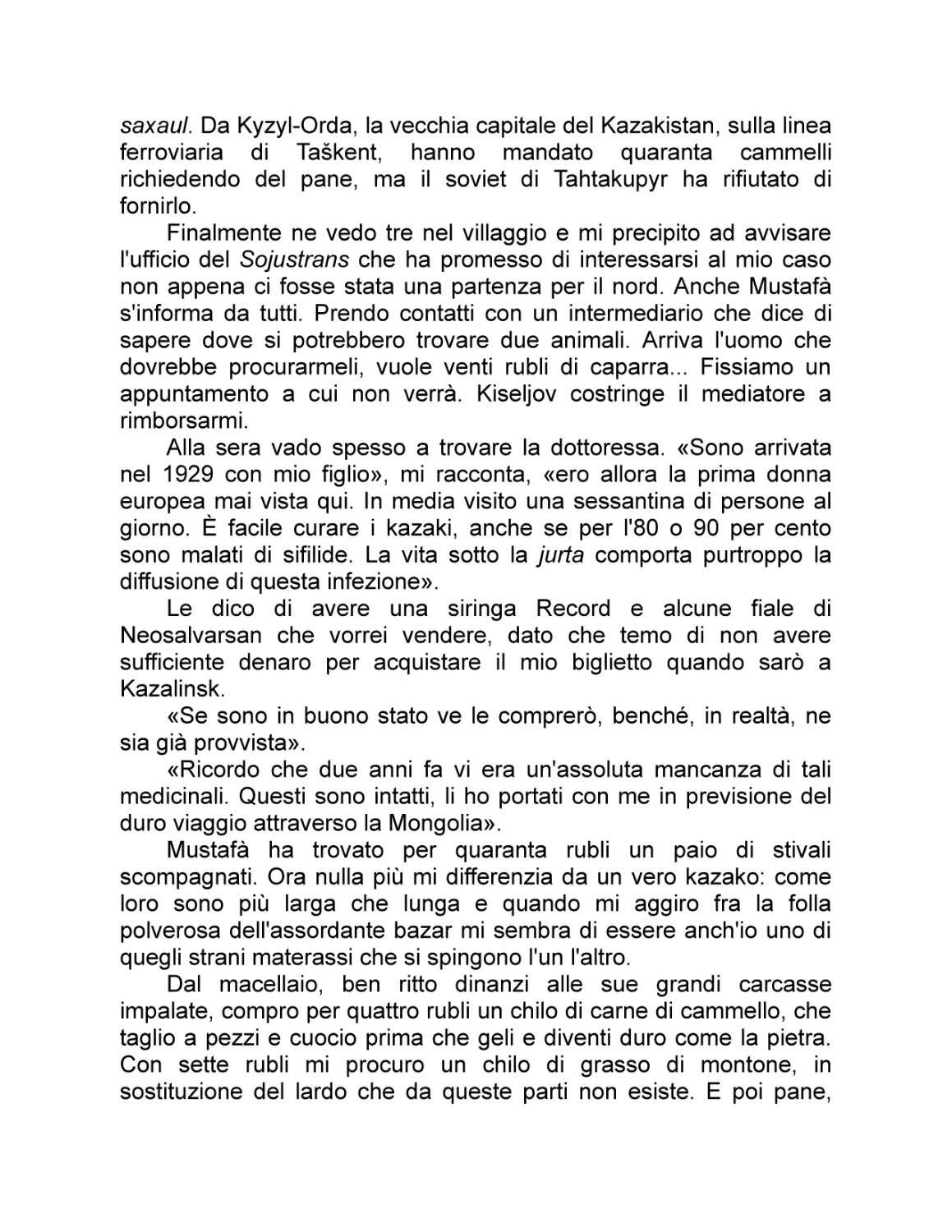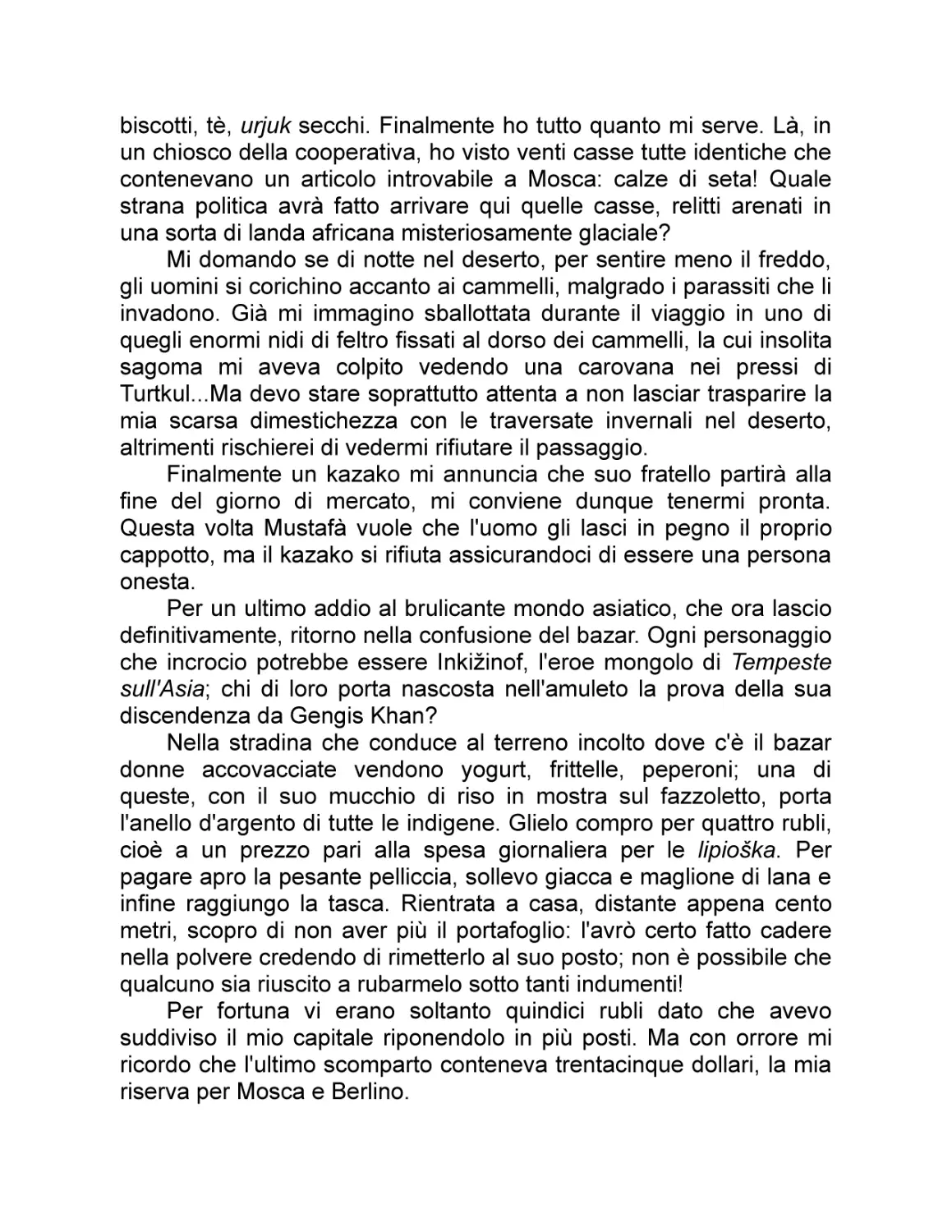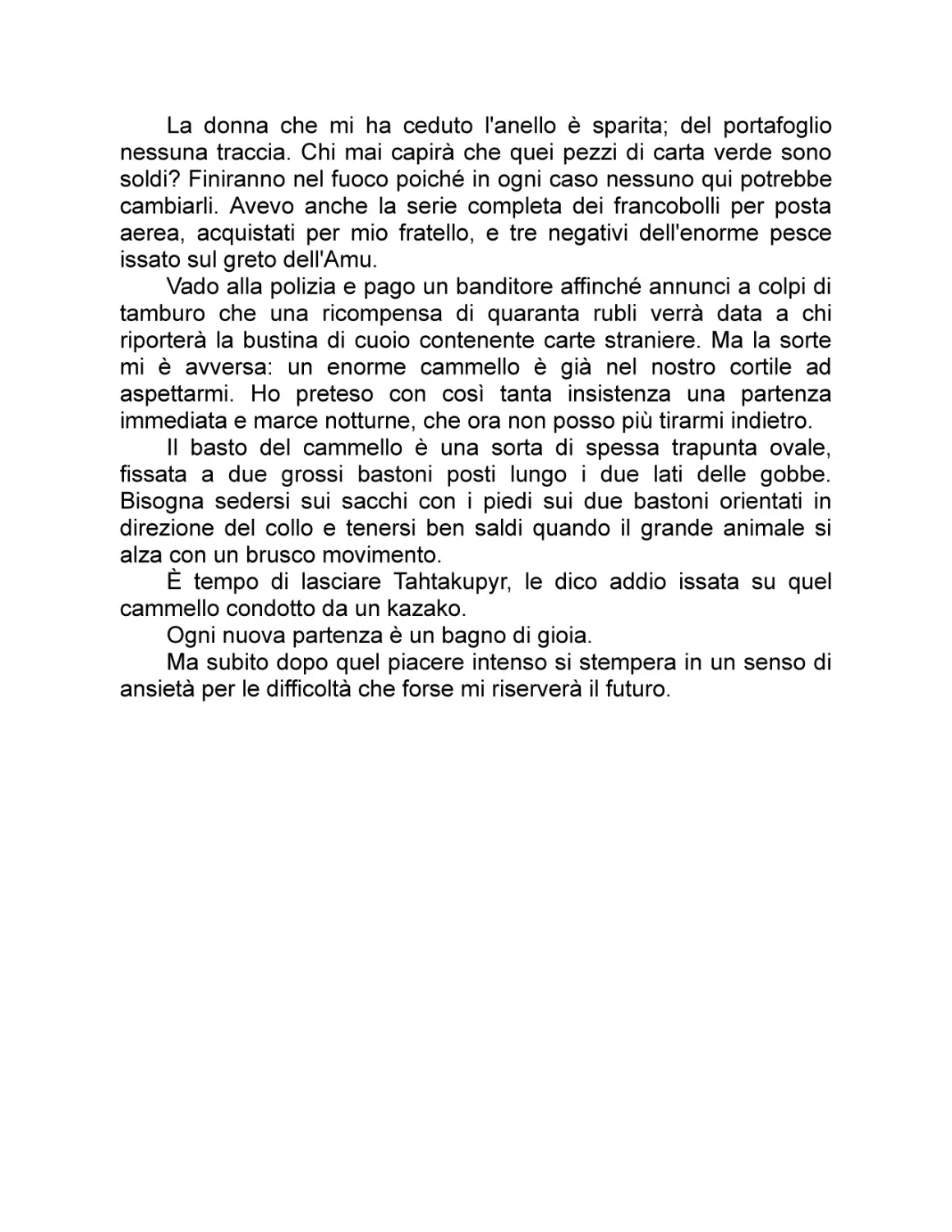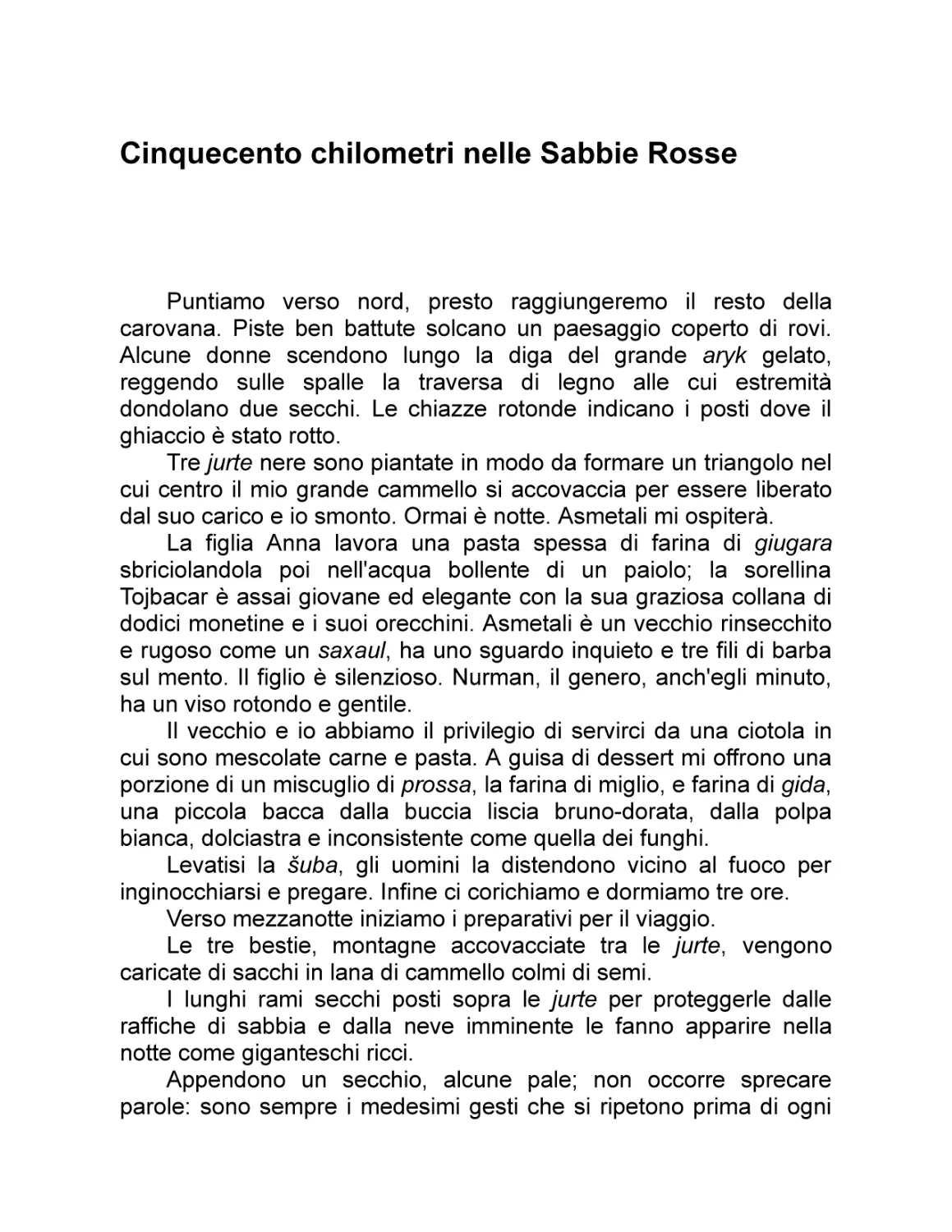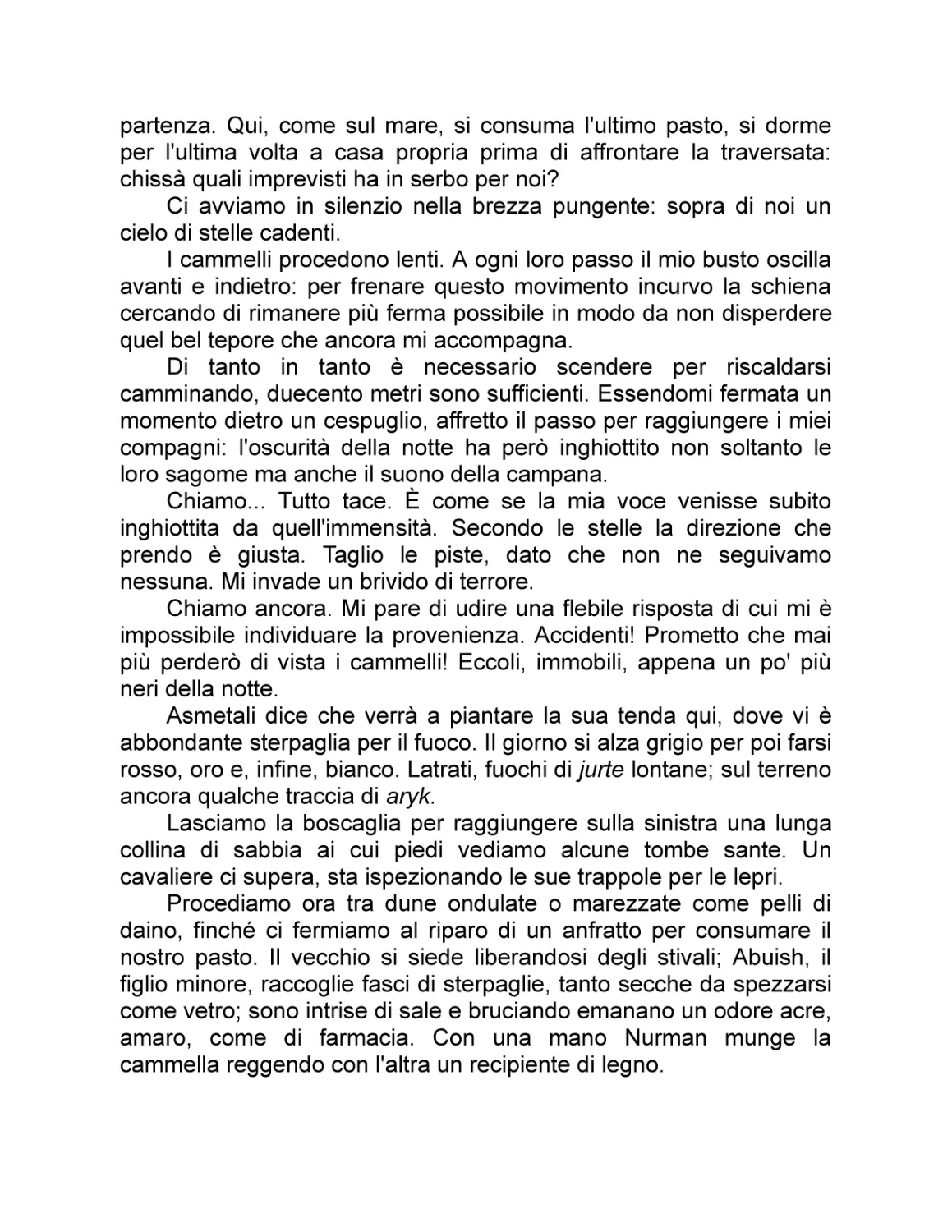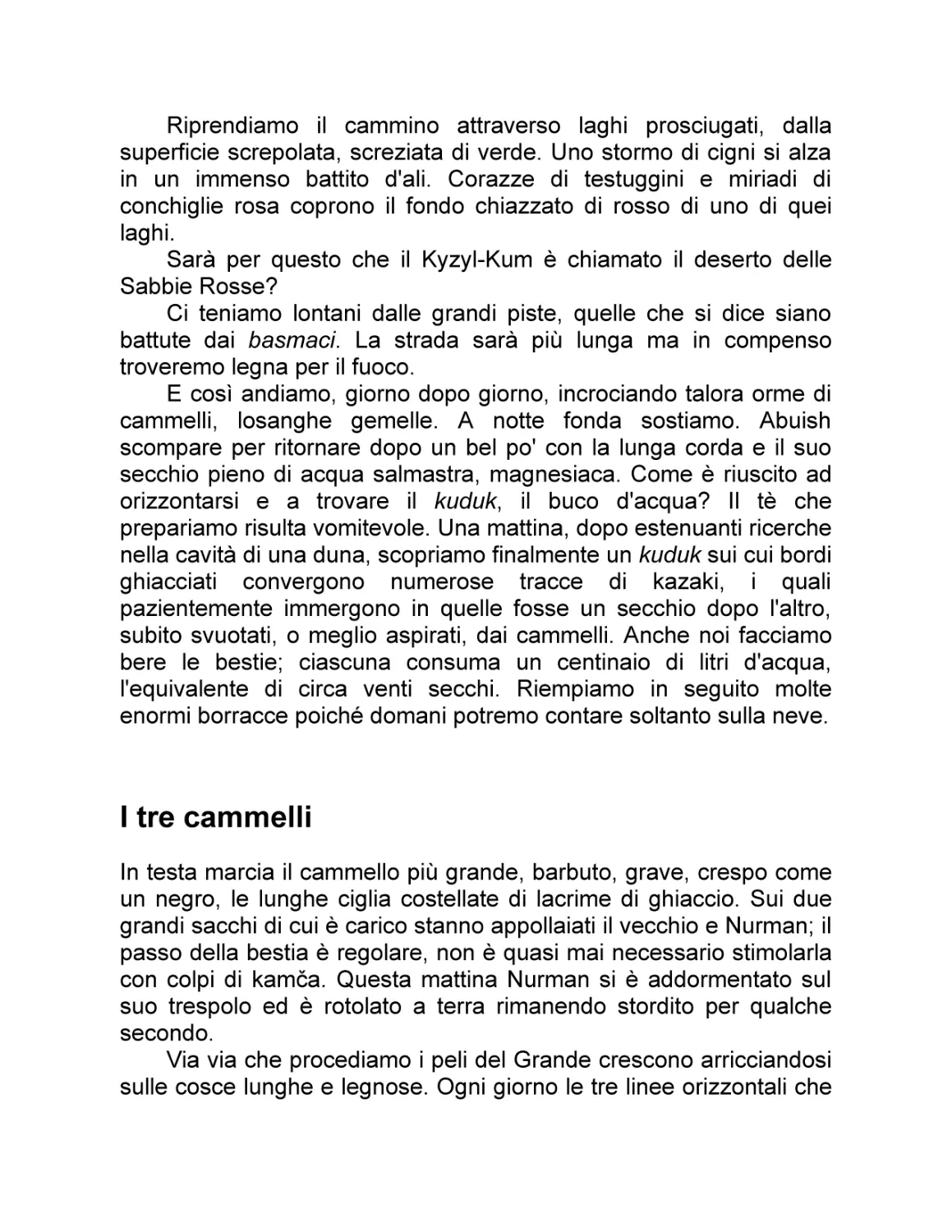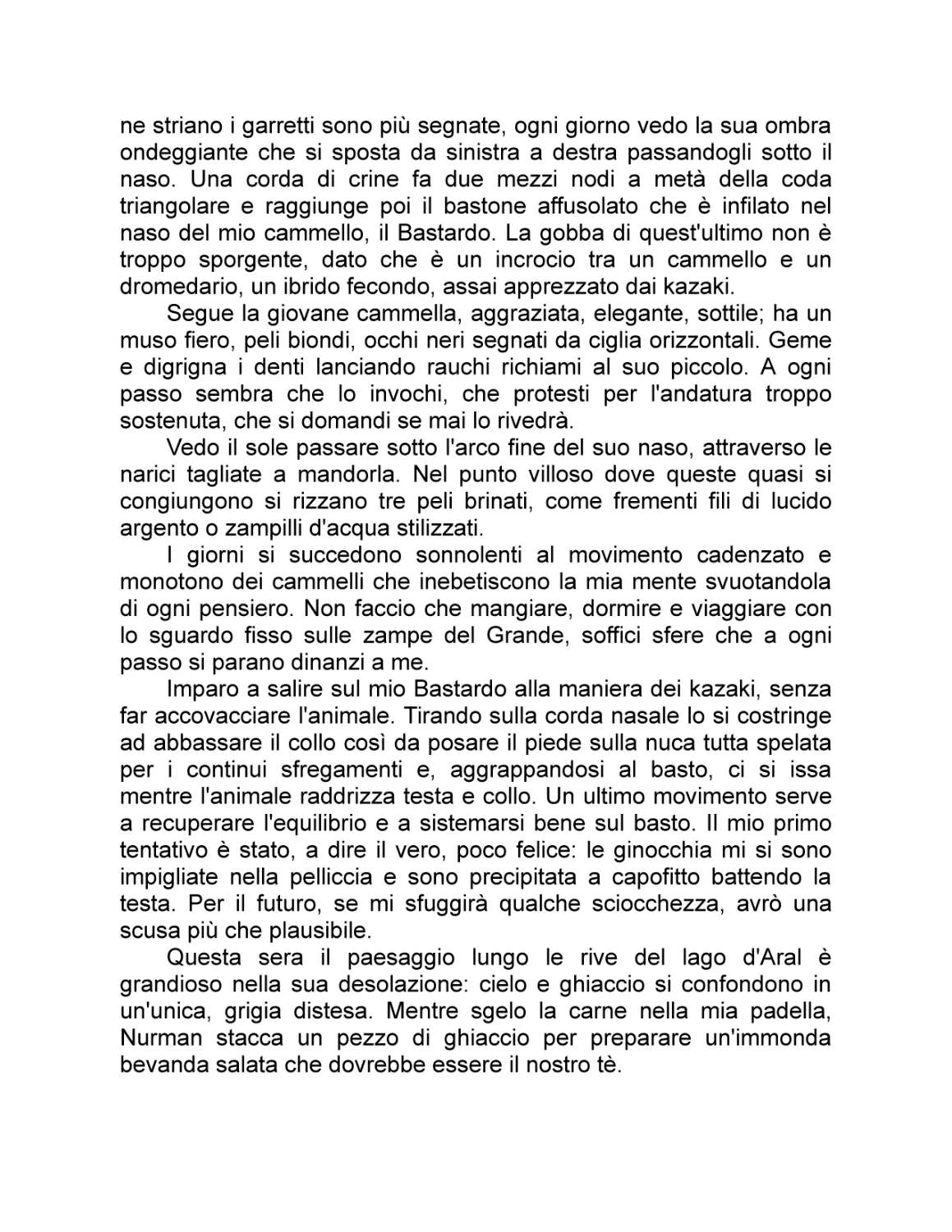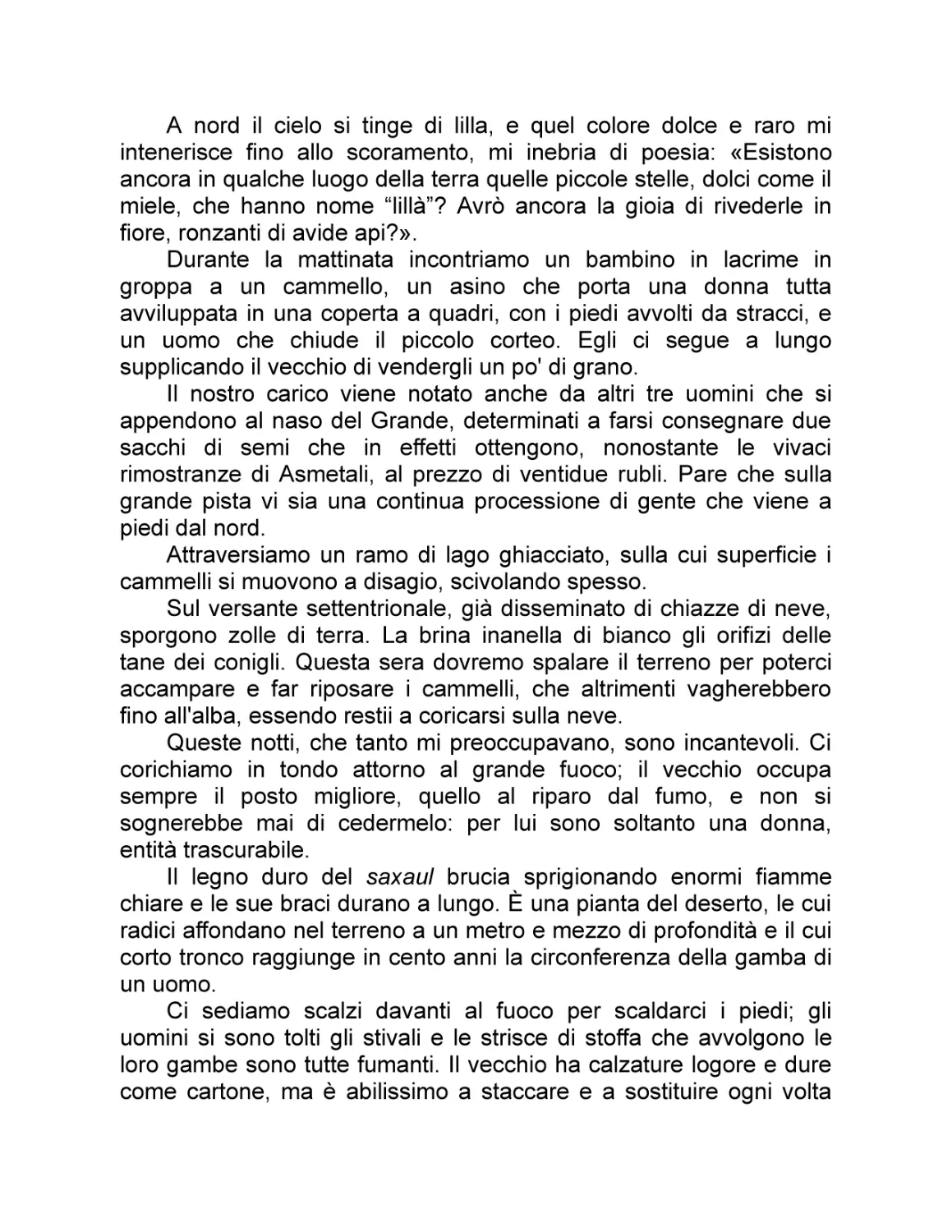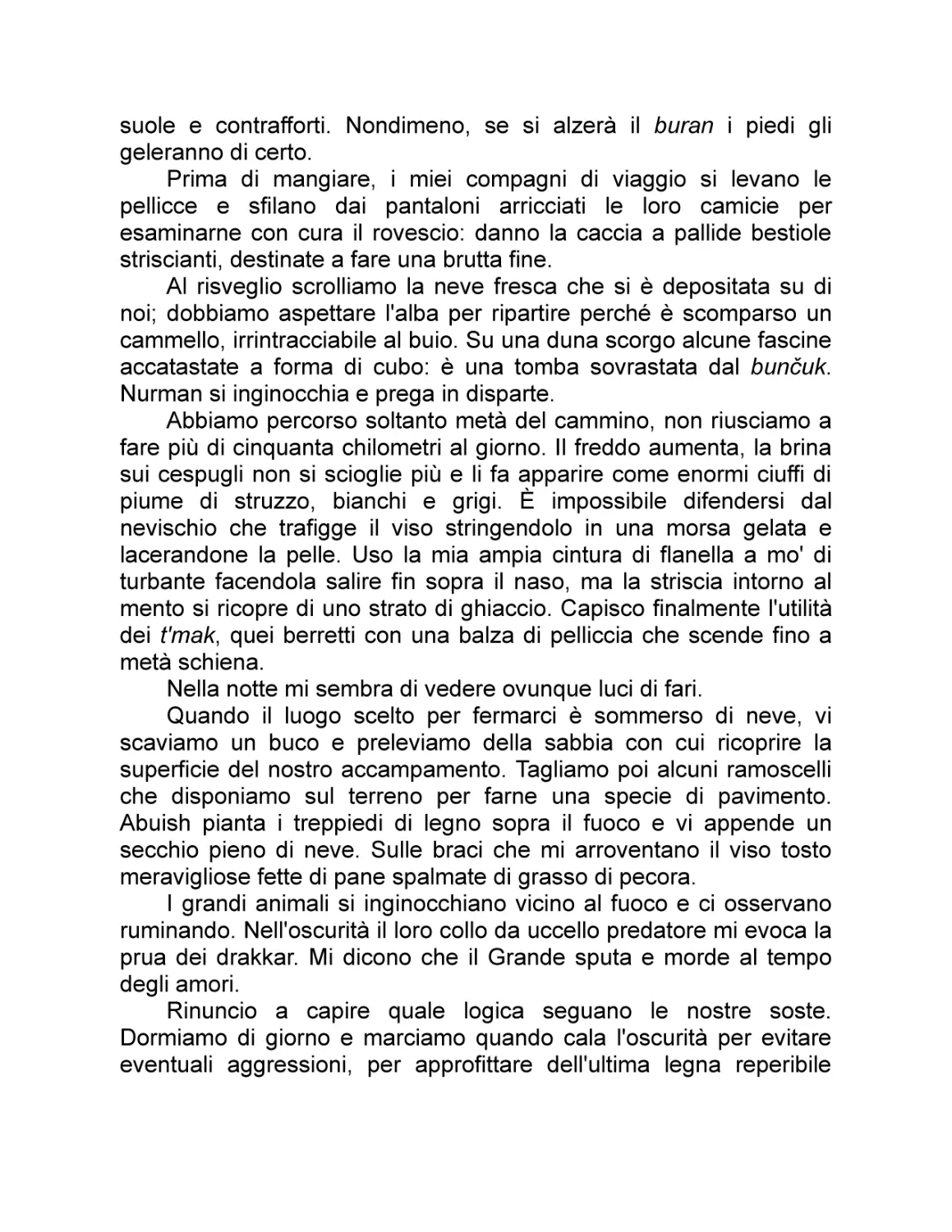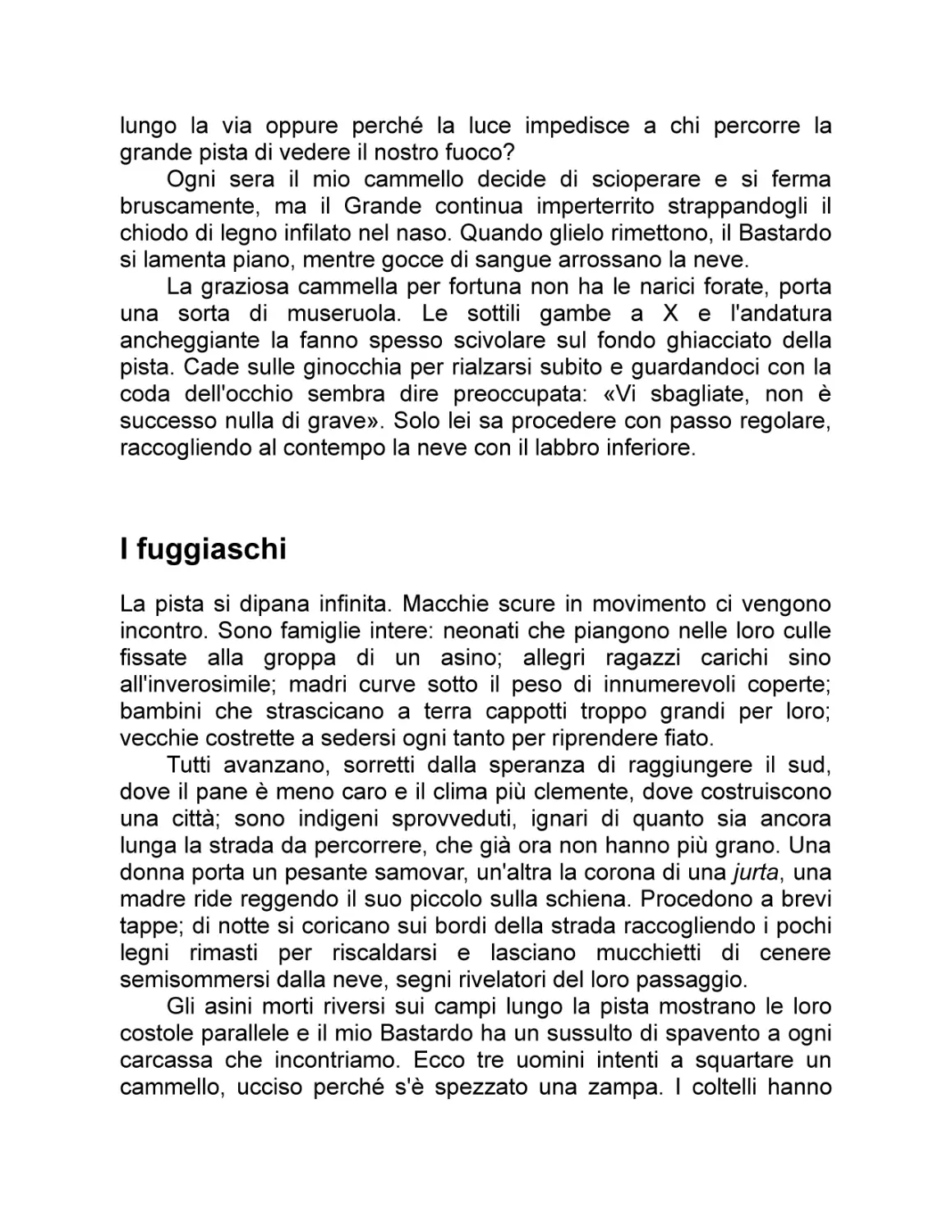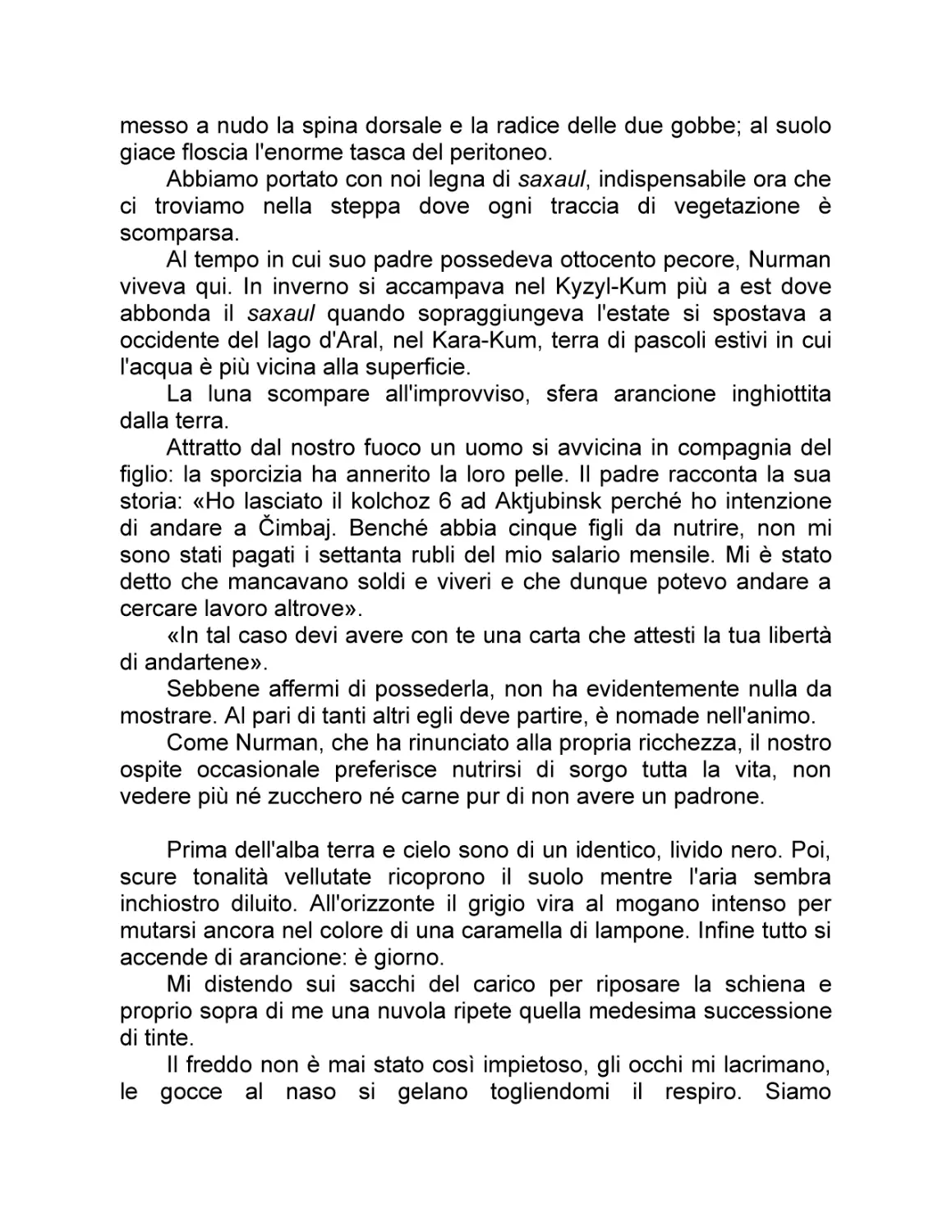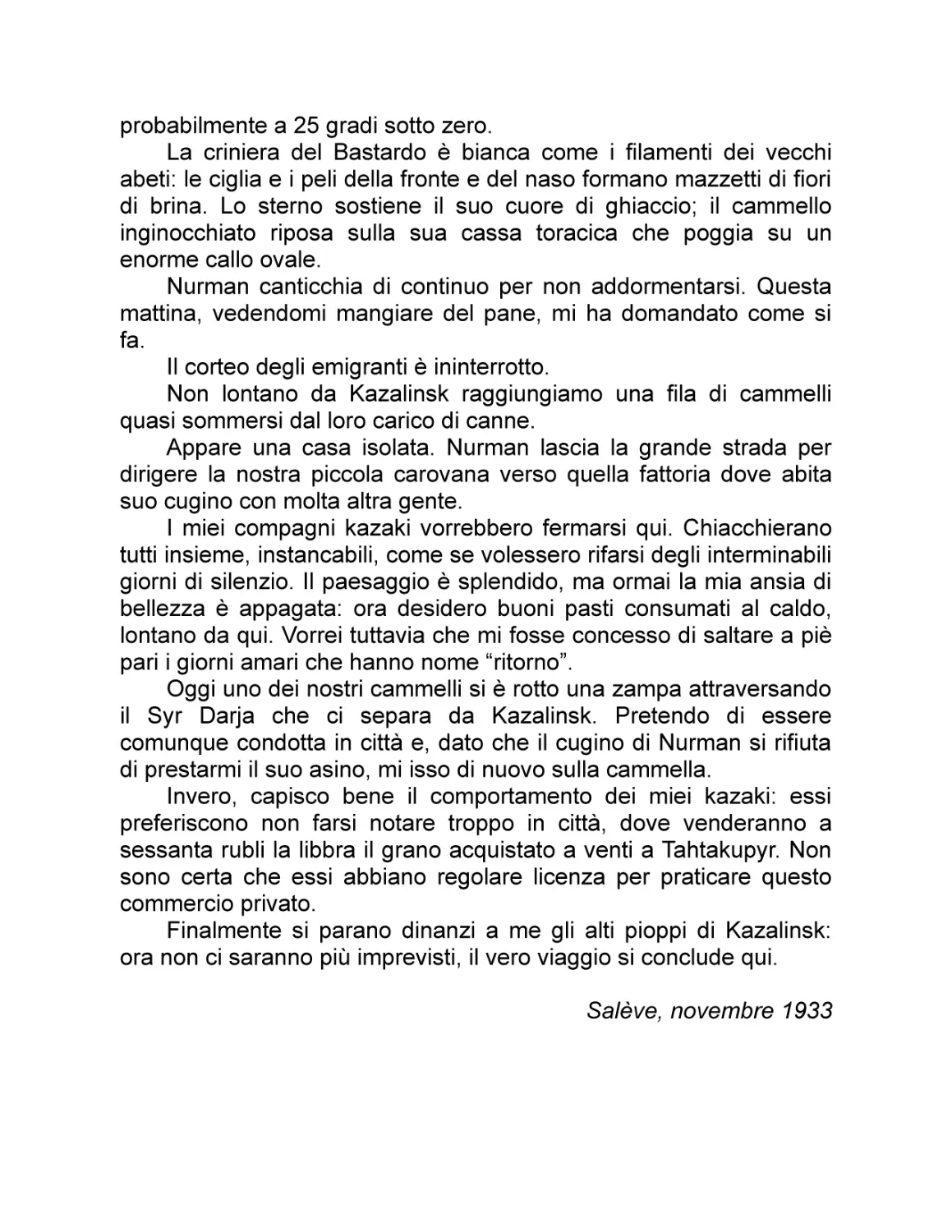Автор: Maillart Ella
Теги: turkestan studi culturali storia culturale asia centrale
ISBN: 88-7063-612-7
Год: 2002
Текст
Ella Maillart
Vagabonda nel Turkestan
Collana: Aquiloni
Vagabonda nel Turkestan è tratto da
Des monts célestes aux sables rouges
© 1990 Editions Payot & Rivages, Paris
Traduzione: Silvia Vacca
Redazione e impaginazione: Giuliana Martinat
Grafica di copertina: Anna Dellacà
In copertina foto di Gaudenzio Vineis
© 2002 per l'edizione italiana
EDT srl
19, via Alfieri -10121 Torino
www.edt.it
e-mail: edt@edt.it
ISBN 88-7063-612-7
Epub by ArM
Indice
Premessa
La partenza
Taškent
«Pravda Vostoka»
Un confinato anarchico
Le risposte del presidente orientale
Dall'alto dei cieli
Samarcanda, l'incomparabile
Di casa in casa
Jan racconta
Il processo ai “basmaci”
Bukhara, città declassata
Verso l'Amu Darja
La cambusa del “Pellicano”
Turtkul
Khiva
I tedeschi di Ak-Mecet
Corsa contro il gelo
Verso il nord sconosciuto
Cinquecento chilometri nelle Sabbie Rosse
Premessa
Grande viaggiatrice. Ella Maillart agli inizi degli anni Trenta si
trova ancora una volta a Mosca, nella Mosca ormai cupa dei grandi
processi staliniani. Sta cercando di ottenere visti e mezzi per partire
verso l'Oriente sovietico, verso quelle popolazioni nomadi, la cui
continua ansia di movimento tanto l'attrae, nella speranza di ritrovare
presso quelle genti erratiche un modo di vita ancora intatto, capace
di rispondere alle inquietudini dell'uomo occidentale. Il momento,
invero, e difficile, poco adatto per chi si proponga di attraversare,
con il passo lento delle carovane, quelle regioni frontaliere prossime
all'Afghanistan e alla Cina, bruscamente proiettate nel XX secolo
dalla collettivizzazione socialista. E la situazione politica incerta — a
causa del persistere, specie nella Bukharia orientale, di rivolte a
carattere nazionalista sospettate di essere appoggiate da governi
stranieri antisovietici — consigliano ai competenti uffici moscoviti la
più grande cautela nel rilasciare qualsiasi autorizzazione. Né sono
sufficienti le numerose e importanti referenze moscovite della
Maillart: Pudovkin, il grande regista di Tempeste sull'Asia, il suo non
meno famoso collega Ejzenštejn, il poeta Šklovskij o Boris Pil'njak,
nella cui dacia in legno si raduna il piccolo mondo cosmopolita di
Mosca.
Dopo tre settimane di vani tentativi, l'Asia centrale e gli altipiani
kirghizi sono ancora un sogno che sembra destinato a non
realizzarsi. Un incontro casuale apre uno spiraglio insperato: una
piccola spedizione a cui partecipano due coppie moscovite —
Augusto Letavet con la compagna Capa, laureati rispettivamente in
igiene e fisiologia, e Volodia, biologo eminente, con la moglie Milla
— stanno organizzando le proprie vacanze in quelle regioni lontane,
al confine con la Cina, e hanno già ottenuto il permesso dell'Ufficio
del Turismo proletario. E un'occasione insperata: Ella si aggrega al
gruppo che garantirà per lei presso le autorità sovietiche. Il più è
fatto.
Dunque via, lontano da Mosca, lungo l'orizzonte luminoso del
Volga, verso quelle contrade desolate, verso il lago d'Arai, lungo la
sabbiosa, grigia e monotona pista del Turkestan. Ecco Frunze, città
giardino, capitale del Kirghizistan, dove la Maillart incontra Vasili
Ivanovič, il deportato trotzkista, assetato di notizie dal resto del
mondo. E poi Čolpan-Ata e il porto di Karakul, foresta di verde in
mezzo a campi dorati di cereali, ai piedi di montagne altissime.
L'Ufficio del Turismo è in centro. Corse affannose per ottenere i
buoni con cui acquistare generi alimentari di prima necessità al
bazar della città; una visita all'affascinante e pittoresco mercato,
frequentato da nobili kirghizi, da donne indigene con enormi e
splendidi turbanti, da russi, da uzbeki... Qui tutti vendono di tutto,
accovacciati di fronte alla propria mercanzia. Solo l'ansia per il
viaggio ancora da compiere impedisce a Ella di abbandonarsi alla
gioia di quel luogo. La piccola carovana riprende il cammino verso la
Sirte, alla scoperta di quell'Asia che fu un tempo impero dei nomadi
turco-mongoli, liberi di pascolare le greggi nelle sue grandi pianure.
L'ospitalità, qui, è straordinaria. Si cucina e si consuma un agnello
secondo riti antichi: per ora la sovietizzazione è ancora lontana, il
montone è l'unica moneta conosciuta, misura primordiale di ogni
transazione economica.
A 4200 metri di altezza, al limite delle nevi perpetue, il colle di
Djugušak. Più in basso, in una vallata a 3600 metri, s'innalza
l'osservatorio glaciale del Tian Shan dove la compagnia può
finalmente riposare. Otto persone vivono qui per studiare le
condizioni climatiche di una piana desolata come l'artico,
interamente coperta di neve, centro di un mondo immacolato e
abbacinante di sole, dominato da alte catene montuose. Lassù, per
chi ne ha il coraggio, è possibile avventurarsi solo a piedi o, come
esperimenta la stessa Maillart, con gli sci. Il premio per la fatica è
una discesa superba: quasi un 'ora di sci su nevi eterne, non toccate
dall'uomo.
Lasciati i ghiacciai, si scende lungo la grande pista del colle di
Bedel, dove una terra nerastra si sostituisce alle nevi. Sul colle di
Ak-Bel i venti dominano incontrastati, e sempre il vento sarà
compagno di valle in valle per molti giorni, in un paesaggio desolato
e monotono, ravvivato soltanto dall'incontro con tre cavalieri kirghizi.
Superbi sui loro destrieri, essi cacciano, come falconieri medievali,
con l'aquila reale, pazientemente addestrata con sapienza antica.
Ecco la Sirte, un tempo regno incontrastato delle tribù nomadi,
libere ma rispettose delle proprie leggi, regolate dalle norme antiche
della transumanza. Ora quei territori sono di proprietà dello stato che
sta cercando, non senza errori, di incrementare l'allevamento del
bestiame. A Karakul è ancora vivo, però, il ricordo della repressione
cosacca del 1916 e delle violenza dell'esercito rosso.
Ancora passi elevati, ancora neve e poi valloni di polvere
giallastra: il deserto di Gobi, oceano di sabbia senza confini, e quindi
il Sinkiang, e poi ancora Kuldja, Bazaklik con le grotte dei centomila
Buddha, gli affreschi tokhariani in cui rivive un 'intera aristocrazia
indoeuropea che nel VII secolo fu di splendida civiltà: quanto grande
il desiderio di dirigersi verso quelle zone, e quanto doloroso il dovervi
rinunciare perché la situazione politica non lo consente.
Meglio dunque dimenticare la Cina e restare nel Kirghizistan
utilizzando i giorni ancora a disposizione per visitare un kolchoz, per
capire sentimenti e speranze dei giovani che vi lavorano. La discesa
verso la piana del Kazakistan, a 700 metri d'altezza, è veloce e
termina ad Alma-Ata, la capitale, città in grande espansione
demografica. E qui la compagnia si scioglie: gli amici di Mosca
torneranno verso la capitale sovietica, mentre Ella, in solitudine,
riprenderà il suo vagabondare verso le leggendarie mete del
Turkestan: Samarcanda, Bukhara, Khiva, il Deserto delle Sabbie
Rosse.
La partenza
Prima di partire da Alma-Ata voglio incontrare un esiliato
politico. Andando da lui passo a visitare il Museo Etnografico: è in
via di ristrutturazione, sistemato provvisoriamente nella chiesa
principale, ora sconsacrata, ma sulle cui cupole brillano ancora croci
splendenti.
Confinato un anno fa in questa capitale in formazione, colui che
cerco ha subito trovato lavoro presso l'università, dove ha ottenuto
una cattedra di storia. Al calar della sera erro tra le aule ormai vuote
nella speranza di incontrarlo; un'ala dell'edificio è in ristrutturazione,
in “riparazione”, come dicono in russo. Non vedo nessun custode,
ma infine tre allievi dagli occhi a mandorla mi indicano l'alloggio del
professore, situato poco lontano.
In una stanza stracolma di pericolanti pile di libri, in presenza
della moglie e di un giovane studente, il professore mi racconta la
sua storia: «Sono stato accusato ingiustamente di far parte di una
nuova setta religiosa ed esiliato qui, dove mi sono stati offerti un
posto all'università e la direzione degli archivi cittadini. Credo
peraltro che stiano rivedendo il mio caso e che presto verrò
richiamato a Leningrado. In un certo senso ne sono dispiaciuto, il
mio attuale lavoro mi piace molto».
Lo interrompo per chiedergli un'opinione sui suoi allievi indigeni.
«Non sono meno intelligenti dei russi, e talora persino più
perseveranti. Il kazako non ha prontezza intellettuale, ma tiene a
mente tutto quanto impara; il kirghizo, invece, è più vivace, più
intuitivo, forse anche più scaltro, ma di grande onestà».
«Sono religiosi?»
«I loro genitori erano maomettani poco osservanti e quindi non
si stupiscono dell'agnosticismo oggi imperante».
«Ritenete che la loro formazione sarà presto tale da permettere
che si governino da soli?».
«Senza dubbio, nulla vieta che ciò debba un giorno accadere.
Penso anzi che in un futuro non lontano potranno fare a meno anche
dei russi».
Alla mia domanda se essi ricalcheranno i medesimi percorsi
politici dei dirigenti sovietici, il professore mi risponde di esserne
certo. Sul tavolo sono sparsi molti giornali francesi, le ultime
pubblicazioni della sinistra. Sulle pagine di un numero di «Temps»,
vecchio soltanto di tre settimane, leggo della morte improvvisa di
Virginie Hériot. Poi, aprendo a caso un testo di Durtain, D'homme à
homme, mi cade lo sguardo su una frase che compendia tutti i miei
pensieri: «Innanzitutto il mondo, poi nel mondo l'uomo, nell'uomo gli
altri uomini. Triplice richiesta rivolta dallo scrittore alla pagina bianca,
dal lettore alla carta stampata».
Giunta come sono dai confini del mondo, questo brusco ritorno
nel contemporaneo mi coglie alla sprovvista, mi lascia sconcertata.
Prendo infine commiato da quell'uomo, calvo, glabro,
sorprendente, che in una lingua ricercata pronuncia a ogni piè
sospinto frasi del tipo: «Il 28 aprile del 1912, durante una cena al
Petit-Vatel, Jean Moltimportante mi diceva testualmente...».
Attraverso a passo rapido i giardini della città sospirando al
pensiero di un buon pasto, malgrado preferisca di gran lunga
trovarmi qui piuttosto che al Petit-Vatel!
Superate le tre arterie principali le strade cadono nell'inquietante
oscurità dei vicoli... Non è facile ritrovare il cammino senza smarrirsi.
Colpi sordi battuti su un legno risuonano nell'aria: è la guardia
notturna che passa annunciando il coprifuoco.
Preparativi per il viaggio
Ormai non mi resta che partire. Operazione difficile, anche se posso
trarre insegnamento dalle esperienze dei miei compagni. Per il
tragitto dipendo dalla Società del Turismo proletario. Il capo della
“base” compila per me un modulo per la data fissata che certifica la
mia richiesta di un biglietto ferroviario, confermando altresì il mio
diritto a un bronnjrovannyj bilet, a un biglietto riservato.
Con questo foglio, la vigilia della partenza mi reco in stazione
due o tre ore prima dell'apertura dello sportello. Molte persone sono
già in coda. Il primo arrivato ha segnato via via su un taccuino tutti
coloro che sono giunti dopo di lui e ognuno viene informato del
proprio numero d'ordine: i viaggiatori sono suddivisi in categorie a
seconda del documento di cui sono in possesso. Alcuni, pallidi e
affranti, sostano dinanzi allo sportello: saranno i primi a partire
poiché sono kurortnij in congedo per convalescenza. Ve ne sono già
tre. Seguono i comunisti, cui è sufficiente far intravedere il rosso
della tessera di membro del Partito. Nessuno chiederà loro altri
documenti: il motivo dei loro spostamenti è certamente di primaria
importanza.
I bronnj, di cui faccio parte, sono assegnati alla terza classe che
gode del diritto di viaggiare senza perdere eccessivo tempo. Dopo vi
sono i kommandirovka, impiegati inviati in missione dagli uffici dove
lavorano; in coda a tutti aspetta chi viaggia per conto proprio, senza
dipendere da nessuna organizzazione.
Calcolo che, data la mia posizione nella lista, ho almeno due ore
a disposizione per andarmene a zonzo. Allo spaccio vanno a ruba
panini e fiammiferi e per un rublo è possibile comprare una bottiglia
di gazzosa. Al ritorno, il proprio posto è assicurato grazie al numero.
Vi è naturalmente qualcuno che cerca di barare entrando nell'ufficio
dal retro, subito cacciato a gran voce con piena soddisfazione degli
onesti. Arriva un ritardatario che dice: «Krasnij» e si mette in coda
proprio dietro l'ultimo comunista; quando gli viene richiesta la sua
tessera mostra di sfuggita una carta di un vago colore rosso,
palesemente falsa.
«Ma vengo per mio fratello che è membro del Partito!».
«In coda, imbroglione! Non stiamo qui da tre ore a guardarci le
punte dei piedi perché uno come te ci passi davanti!».
Per converso, quando sopraggiunge una donna dall'aria smunta
e con un bimbo in braccio, la persona a cui spetta passare acquista
subito il biglietto anche per lei.
Ad Alma-Ata, stazione di partenza di numerosi convogli, è facile
trovare posto; per Taškent pago trentaquattro rubli, ma la
prenotazione è valida soltanto fino ad Arys, dove passa la linea
ferroviaria principale, e là dovrò cambiare treno.
Così l'indomani salgo su un vagone e mi sistemo sul duro sedile
corrispondente al mio numero, mentre una nuova coda sta
formandosi davanti allo sportello; sotto la pensilina aspettano,
appoggiandosi ai loro fagotti, i viaggiatori ancora in attesa. Il
paesaggio è stupendo. Maestose montagne si innalzano a 5000
metri sopra la verdeggiante città: il blu nerastro delle loro pendici si
sbianca di neve fresca da metà altezza fino alla vetta.
Con questa linea del Turk-Sib ogni anno dovrebbero essere
trasportate dalla Siberia 960 000 tonnellate di cereali, indispensabili
per nutrire il Turkestan, paese in cui il cotone ha quasi del tutto
sostituito ogni altra coltura.
Alla “base”, dove il capo mi ha ceduto un po' di viveri, ho
venduto a prezzo di costo piccozza, corda e ramponi. Nella mia
sacca hanno preso posto abiti, scarponcini da alta montagna,
quattro chili di pane, due di zucchero e due di riso, biancheria, un
vocabolario e il doppio sacco a pelo.
Nello zaino, il cui peso supera di molto i consueti quindici chili,
ho sistemato tutto il resto: fornello, una tanichetta di alcool, pellicole,
macchina fotografica, impermeabile, medicine, calze, altra
biancheria, burro, tè, miele, un chilo di porridge, due di mele,
l'inseparabile padella per friggere e... la pipa per le veglie solitarie.
Arys o la perpetua migrazione
Ad Arys sorgono le prime vere difficoltà: occorre ottenere un posto
per Taškent. Poso i miei bagagli contro il muro della stazione. Là
vicino aspetta un uomo, forse un contadino, con lunghi baffi biondi e
l'aria sveglia; facciamo conoscenza e vengo così a sapere che parla
dall'infanzia il kazako-kirghizo e che è diretto a Taškent.
«Arrangiatevi in qualche modo per ottenere una prenotazione»,
mi consiglia, «nel frattempo sorveglierò i vostri bagagli. Portate con
voi il mio biglietto».
Nell'atrio della stazione non riesco quasi ad avanzare: gruppi
compatti sono accampati da ore, forse da giorni, in attesa di partire
verso un nuovo lavoro, migliori condizioni di vita oppure per
diffondere ovunque il verbo socialista.
Alle due del pomeriggio lo sportello per Taškent è chiuso: il
treno per quella destinazione, che passerà fra un'ora, è ormai
completo. Bisogna ritornare questa sera, alle dieci, prima del treno
della notte; alcuni coraggiosi sono già in fila e compilano la lista dei
presenti secondo l'ordine d'arrivo.
Decido di giocare d'astuzia e cerco di arrivare allo sportello
passando dal retro, ma la porta è chiusa a chiave. Approfitto del
momento in cui esce un impiegato per sgusciare dentro con l'aria
indaffarata, ma mi trovo in un'anticamera davanti a un altro sportello.
«Signorina, come devo fare per arrivare a Taškent? Sono
giornalista e ho molta fretta».
«Ah sì? Anch'io ne ho; ritornate questa sera e rivolgetevi allo
sportello principale».
Mi pare evidente che non è questo il modo di procedere.
Mi rifiuto nondimeno di ricorrere all'ufficio della Ghepeu dove,
per favorire una straniera, forse mi darebbero un posto, a scapito
però di qualcun altro.
Al buffet la zuppa di cavoli è buona, ma la carne macinata è
veramente immangiabile.
Faccio il giro della stazione per sistemarmi all'ombra. Di fronte a
me c'è un giardino cinto da una siepe: il terreno è pieno di semi di
anguria, di scorze di semi di girasole, di lische di aringa, di mozziconi
e... di gente accampata.
Alla mia destra un gruppo di famiglie tzigane, sporche e
rumorose, attira la mia attenzione. Gli uomini anziani hanno capelli
lunghi, barbe folte e occhi profondi da fachiro; i giovani, magri e dalla
pelle color caffè, saettano sguardi sotto le sopracciglia irsute, simili
ad animali da preda in cattività, pronti ad attaccare; tra le donne, la
più vecchia, vera decana della tribù, gesticola senza sosta con le
mani inanellate, si adira contro le nuore, gli occhi scintillanti. Ma
all'improvviso vedo che cerca di ingraziarsi un brigante dai grandi
baffi, che tiene la borsa: una gonna rossa dalle mille pieghe, offerta
da una contadina, la tenta follemente.
Una giovane donna mi colpisce: è pallida, con i capelli biondoramati, indossa abiti dalle tinte smorzate, color mattone la gonna,
viola il corsetto, rosa il fazzoletto legato sotto il mento. L'ovale del
viso appare perfetto, il naso è largo, aquilino, ma gli occhi verdi
quasi spariscono sotto le palpebre arrossate e gonfie: posa la testa
sulle ginocchia della sua vicina perché le metta le gocce. Ne
piangerà per un'ora intera, asciugandosi le lacrime con un batuffolo
d'ovatta. La sua bambina, con gli occhi nel medesimo stato, avrebbe
anche lei bisogno di cure. Il brigante intanto ha dato con gravità
qualche rublo a un ragazzino seminudo perché compri un'anguria, le
cui fette, tagliate con la lama di un pugnale, saranno poi spartite fra
tutti.
Coda al rubinetto dell'acqua fredda per lavarsi; coda al rubinetto
dell'acqua calda per i bollitori del tè.
Ho perduto il treno della notte; nulla è valso, neppure andare dal
capostazione a tentare un colpo di fortuna. Riprendo dunque posto
nella fila in attesa davanti allo sportello.
Una donna indigena, sdraiata sulla strada, tossisce: la sento
nella notte ogni volta che mi risveglio. Alla mia destra, addossata al
muro, riposa protetta dalla sua coperta una giovane russa; graziosa,
il colorito giallastro, le labbra violacee, fuma senza interruzione
sigarette del colore della sua pelle, che si arrotola da sé.
«Avete del chinino?», mi domanda.
Sporgendoglielo mi informo da dove viene.
«Dal Tagikistan. Un inferno... Cotone..., malaria... Laggiù
capitano cose folli, tanto assurde da uscirne pazzi. E voi, siete
straniera?».
«Sì... Ma ditemi... Non potevate procurarvi il chinino là dove
eravate?».
«Il poco che c'è viene usato, mescolato con lo iodio, dalle
ragazze per abortire... E per quegli immani lavori gli operai non
vengono pagati e così sono costretti a rimanere. Perché mai tanta
gente deve rischiare la vita per costruire una centrale elettrica tra
montagne disabitate? Forse per stupire l'India?».
Il suo bel bambino, seduto a gambe incrociate, è impassibile: un
piccolo Buddha reincarnato. Sui suoi occhi semichiusi si è posato un
grappolo di mosche, quasi a formare una stella.
Sotto un albero, davanti a me, sono sedute su un tappeto due
coppie kazake. Le donne portano una giacchetta di velluto verde, il
capo avvolto da uno splendido scialle di lana finissima, un lembo del
quale passa sotto il mento inquadrandone perfettamente il volto. Si
sciacquano le mani con il tè prima di mangiare l'anguria; hanno gesti
nobili, persino quando si tratta di reggere il bimbo che ha la
dissenteria; la tzigana bionda però manifesta apertamente il proprio
disgusto e all'improvviso mi sembra volgare.
Quanto al treno del pomeriggio, ho deciso che non ripartirà
senza di me. Eccolo, finalmente. Ma i controllori sbarrano ogni
accesso. E il vagone ristorante? È vuoto. Forse è una possibilità, mi
informo.
«Posso salire qui? Sì? Devo andare soltanto fino a Taškent».
Una corsa a prendere i bagagli e ritorno immediatamente: il
treno è già in moto e non mi resta che guardarlo allontanarsi.
Un desolante spettacolo mi distrae dalla cocente delusione. Due
ragazzine, pulite ma sgraziate — bocca grande, orecchie a sventola,
occhi infossati —, sembrano decise ad accalappiare due kazaki, ben
vestiti, intenti ad assaporare un pollo dall'aspetto appetitoso. Uno
scheletro vagante passa dinanzi a loro: è un giovane biondo con il
viso deturpato da croste nere, un mendicante. Riceve quel che resta
di un'anguria, la raschia con le unghie, ne beve il succo tremando
d'impazienza, morde la polpa senza quasi prendere respiro. Come
ringraziamento intona con voce tremula una canzone e sorridendo
pietosamente si mette a mo' di copricapo il mezzo cocomero ormai
svuotato...
Davanti allo sportello qualcuno dice: «Pazienza, prenderò il
Maksim».
«Un Maksim parte per Taškent?», domanda un altro.
«Sì, è fermo in stazione».
Sarà forse un treno di mitragliatrici Maxim, sul quale si ha il
diritto di appollaiarsi? No, si tratta di uno dei treni di quarta classe, i
Maksim-Gor'kij, tavar-passadjirov, che vengono talora inseriti su una
linea per decongestionare la stazione.
Il Maksim-Gor'kij
Trovo a fatica il treno in questione: un'umanità rassegnata è stipata
in ogni dove, i passeggeri sono quasi uno sopra l'altro. Nessun posto
disponibile, neppure un angolino.
Tre donne kazake salgono e si accovacciano sulla passerella
metallica che collega i carri bestiame; io mi sistemo più al riparo,
sulla piccola piattaforma in cima al predellino, già parzialmente
occupata da due vecchi. Una di quelle donne è forse la più bella
creatura che abbia mai visto. Mi colpisce soprattutto l'immenso
turbante di cachemire: dall'intreccio sfugge una frangia, criniera
lanosa che le scende a cascata sulle spalle. La fronte è incorniciata
da tre fasce ricamate color rosso cupo, mille pieghe parallele
imprigionano la testa. Il sottogola, bordato anch'esso di rosso,
prolungandosi in un immenso velo nasconde quasi l'intero corpo e
completa magnificamente questa sontuosa acconciatura da monaca.
Il delicato ovale, così incorniciato, esprime nobiltà e malizia al
contempo.
Si tratta forse di una discendente dell'illustre tribù degli Adai
dell'Orda d'Oro, a cui apparteneva il giovane Abdul Khair, arciere
invincibile che uccise il “golia” kalmucco? Con le loro duecento
famiglie, o kibitka, gli Adai costituiscono l'aristocrazia kazakokirghiza. I turco-mongoli si gloriano di discendere da Lupo Grigio e
da Cerva di Luce.
Vi sono immagini impossibili da descrivere: le proporzioni delle
linee, l'armonia dei volumi sono come un canto dell'anima. Quella
donna ne è un esempio: i sottili occhi a mandorla brillano
d'intelligenza, le sopracciglia fini e sinuose accentuano il profilo
diritto del naso, la bocca carnosa ma serrata sembra dire in una
smorfia indulgente: «Posso anche trovarmi sulla passerella di un
carro bestiame, ma ciò non mi sminuisce affatto». La giovane porta
al dito a guisa d'anello una larga fascia incisa e al polso molti cerchi
d'argento cesellato. In una coperta impunturata regge un bimbo con
il tipico copricapo, una tiubetejka ornata di monetine, che tende poi
alla madre, una donna dallo sguardo vivo, ma dalla pelle ormai
rugosa e scura che contrasta con il pallore del piccolo. La terza
viaggiatrice, meno fine, ha il viso più rotondo; sulle sue tempie
luccicano perle di sudore che asciuga con un gesto brusco della
mano.
Crepuscolo. Ogni quindici chilometri il treno devia su un binario
morto per lasciar passare i convogli regolari.
Ho mal di schiena per lo sforzo di star seduta in equilibrio
precario: potessi allungare le gambe! Mi infilo nella fodera di gomma
del sacco a pelo per proteggermi dalla sporcizia del pavimento, mi
appoggio ai miei fagotti, sistemo i piedi dietro le ceste di due russi...
e mi addormento.
A più riprese vengo svegliata da crudeli calci nelle costole e
sento qualcuno che passando borbotta: «C'è gente che si permette
addirittura di distendersi sul passaggio, mentre altri non sanno dove
sedersi».
Quanto i kazaki — che un tempo giudicavo primitivi — superano
tutti questi russi in dignità innata, testimonianza certa di una cultura
di cui ancora rimangono le tracce!
Lento arrivo a Taškent; brilla una falce di luna, il cielo si rischiara
sui campi e sui giardini cinti da muri costruiti con fango essiccato.
Taškent
Folla variopinta alla stazione. Riesco a portare ambedue le
sacche sistemandone una sulla schiena e l'altra sulla spalla, ma
devo reggere quest'ultima con l'altro braccio perché non scivoli giù.
Tram fino a piazza Voskročenskij e poi alla Ikanskaja: l'ufficio della
“base” è ancora chiuso. Entro dal cortile e mi preparo il tè. Arriva
un'impiegata, che fa colazione con una mela e un po' di pane. Poi
arriva anche il segretario e finalmente posso mostrare i miei
documenti; vengo così mandata alla vera “base”.
In via Lenin risalgo sul tram e lascio la città russa passando per
un corso fiancheggiato da filari di pioppi, da aryk e da case basse.
Appena giunta nel quartiere indigeno, scendo alla fermata di Shai
Khan Taur.
Pochi gradini, una porta ad arco, e poi un passaggio lastricato,
costeggiato di botteghe di barbieri, ancora una strada alberata sotto i
cui pioppi file di uzbeki vendono le loro mercanzie: mele, uva,
angurie, carote spezzettate, dolciumi. Moschee abbandonate. Dalle
finestre di un basso caseggiato vedo scolari chini sui banchi. Affissi
ai montanti della grande pedana di una čajkana all'aperto, i ritratti dei
capi dell'Urss. Ancora un vicolo... Devo fermarmi, ho assoluto
bisogno di riposo.
Giungo infine alla seconda grande arteria e al numero 58 entro
nel cortile ombreggiato di un lungo fabbricato composto da due
dormitori, di cui uno, riservato alle donne, conta una decina di letti.
Una ragazza mi accoglie e mi assegna l'ultimo posto disponibile.
Questa “base” era un tempo l'iškari, vale a dire l'alloggio dei
componenti femminili della casa di un ricco bek.
Per mangiare bisogna andare fino in città, ma ogni sera ritroverò
qui le mie compagne di camera, giornaliste, economiste,
studentesse; qualcuna ha un marito che vive nel dormitorio attiguo.
Abbiamo così occasione di scambiarci impressioni, di condividere le
nostre scoperte.
A spasso per la città
Pil'njak qualifica Taškent come luogo di assoluta noia, ma senza
dubbio egli si riferisce alla parte russa di questa immensa capitale di
500 000 anime; se è lecito, come dice Kiš, contare fra le anime i
comunisti che la negano e le donne musulmane, cui il Corano ne
rifiuta il possesso.
Per la prima volta mi trovo in una grande città orientale e voglio
scoprire questo mondo prima che le ultime vestigia dell'antica vita
scompaiano definitivamente.
Tutto mi stupisce: l'intrico delle strette vie lastricate, quasi un
labirinto; le tante donne velate, vaganti sagome funebri, chiuse nel
duro blocco del parandja. Spesso reggono in equilibrio sulla testa un
pacco o un cesto. Parlare di velo non è tuttavia esatto. Bisognerebbe
piuttosto dire traliccio, tanto è rigida quella tela di crine di cavallo che
scortica loro il naso e che esse trattengono con le labbra quando si
chinano per valutare la qualità del riso da acquistare, guardando
attraverso lo spiraglio del čador perpendicolare ai loro occhi. Quando
si rialzano, in corrispondenza della bocca resta un piccolo segno
umido e tondo, subito cancellato dalla polvere svolazzante nell'aria.
Se troppo usati, i čador diventano rossicci e sfilacciati, come rosi
dalle tarme... Gran parte delle donne porta abiti corti, calze e scarpe
confezionate a mano.
Eccone tre, figure informi viola e grige, ammassate al fondo di
una carriola, senza dubbio un harem che trasloca; alla guida, ben
saldo in groppa al cavallo, i piedi appoggiati sulle stanghe, vi è un
uomo con giacca e copricapo ricamato, probabilmente il marito.
L'arba, il veicolo indigeno, mi pare assai bello con gli immensi
raggi delle sue due uniche ruote, alte più di due metri, pratiche per
procedere nello spesso strato di fango o di sabbia; i cerchioni non
sono di ferro ma rinforzati da enormi chiodi a testa rotonda che
luccicano al sole lasciando sull'argilla umida curiose impronte a
cremagliera. Le stanghe sono piazzate tanto in alto da farmi temere
a ogni istante che sbilanciandosi sollevino il cavallo.
Si sentono scorrere i piccoli canali sotterranei che,
incontrandosi, vanno ad alimentare uno stagno, immoto. Tutt'intorno
l'armonia dei colori è incantevole: verde cupo dell'acqua all'ombra,
verde chiaro al sole, verde argento di un salice dalla sagoma
arrotondata, giallo della sponda e dei muri di terra, giallo quasi
bianco delle quattro arba là abbandonate, con le stanghe a terra.
La strada è ostruita da un immenso carico di fieno, più largo che
alto, trasportato da un cammello dal grande gozzo. In cima a quella
sorta di rettangolo è appollaiato un uomo.
Cerco di raggiungere per vie traverse Urda, la città indigena,
perdendomi di continuo.
Lungo un muro una porta sormontata da un piccolo
torrioneminareto mi lancia il suo richiamo ed entro. A destra, in un
giardino, un pioppo tremulo, alberi di fichi, cactus e uno stagno; a
sinistra due file di colonne scanalate di legno sostengono un'ampia
veranda chiusa fino a metà da una leggera parete di legno traforato;
per terra, dinanzi al mihrab, la nicchia orientata verso la Mecca, sono
stese alcune stuoie per la preghiera dei fedeli. È una moschea. I
muri sono intonacati a gesso. Quiete, sole, solitudine... Fantasie mi
attraversano la mente mentre lascio errare lo sguardo sui cassettoni
del soffitto, scolpiti e miniati con disegni arabescati. Immagino che
anche nei templi cinesi esistano decorazioni simili.
Scoperte al mercato locale
Ecco l'incessante movimento della folla. I barbieri eseguono le loro
“operazioni” agli angoli delle case: il paziente del momento china la
testa in avanti a guisa di condannato e protende l'asciugamano che
ha avvolto intorno al collo per farvi cadere i capelli.
Davanti alla panetteria è in attesa dell'apertura un'imponente
fila; rasente il marciapiede, su un'arba dal tetto arcuato, sono
accatastati pani neri. Gli uomini indossano il khalat, ampio mantello
imbottito a righe verticali, verdi, viola, nere e bianche, che fanno
apparire le maniche simili a enormi bruchi. Il grande fazzoletto usato
come cintura disegna il suo triangolo sulla schiena.
Un ponte si incurva sull'acqua verde; dall'affine parte una
stradina ripida fiancheggiata dal porticato di una moschea. L'altra
riva rivela la sabbia gialla della falesia tra le travi e le palafitte che
sostengono miserabili catapecchie, destinate a essere distrutte. La
scarsità di alloggi è in parte causata dalle molte demolizioni
effettuate nella città vecchia, dove invero si costruisce più
lentamente del previsto.
Sette barbieri lavorano fianco a fianco, protetti dal grande
grembiule da cameriere di caffè; uno di loro, un vecchio, ha una
barbetta bianca, a pizzo, occhialini di ferro sul naso, e un inesistente
ciuffetto di capelli che esce dal suo copricapo ben calzato. Il cliente
corruga la fronte: il suo povero cranio, per metà ancora coperto da
una folta capigliatura nera, risplende, perfettamente candido,
sull'altra metà.
Un salice piangente si china sulle acque rapide di un aryk
centrale, alla cui sponda un portatore d'acqua viene a riempire due
secchi appesi a un robusto bastone; poi il canale si inabissa sotto la
pedana di una fresca čajkana dove crepitano su un braciere spiedini
di montone.
La via risale verso l'immensa cupola di una moschea
attraversando un portico decorato di rosse banderuole. La ressa è
tale da impedire il cammino. Ora, poggiati per terra su fogli di
giornale, si succedono grandi mucchi di foglie gialle: appartengono
ai venditori di tabacco che non si separano mai dalla loro pipa, una
sorta di zucca sormontata da un fornello e munita lateralmente di un
lungo cannello di bambù.
Tafferuglio, due uomini si azzuffano; una venditrice impaurita si
alza portando via i suoi piatti di burro. La seguo e per quindici rubli
ricevo una piccola quantità di quella pasta molle e paglierina: «E
puro burro di vacca», mi assicura.
Alcuni uomini, accovacciati a cerchio, non hanno permesso che
il trascurabile incidente disturbasse il loro pasto. Un uzbeko —
fazzoletto bianco, gilet nero sull'ampio camicione candido — vende il
plov, il riso condìto misto a carote spezzettate, contenuto in un
catino di smalto che ha sistemato sopra un secchio riempito per
metà di brace. Con un rublo se ne ottiene una porzione appena
sufficiente per coprire il fondo di una ciotola che viene sporta
insieme con un cucchiaio di legno, posata di cui si servono sia i
giovani sia i russi, ma non il mio barbuto vicino che preferisce usare
ancora le dita, opportunamente incurvate. Un altro mangia senza
peraltro essere incomodato dal grande sacco pieno di semi che
regge sulla testa.
Davanti a me, con un cesto al braccio e in compagnia di una
bella signora bionda, scorgo la figura incredibilmente smilza e gli
stivali di tela grigia di uno dei nostri vicini di Colpan-Ata. Cerco di
raggiungerlo, ma a causa di una rissa selvaggia scoppiata dinanzi a
una rivendita di sapone, lo perdo di vista. Infine ritrovo il mio uomo e
ambedue siamo assai stupiti di rincontrarci qui.
«Sì, il nostro viaggio nella Sirte è stato splendido; spero che
anche voi abbiate concluso bene le vostre vacanze».
«Ma figuratevi, esco ora dall'ospedale dopo una violenta
dissenteria, di cui non capisco ancora oggi la causa. Per fortuna non
posso lamentarmi delle cure ricevute».
Mi informo su dove è diretto e mi risponde che sta cercando un
po' di carne per il brodo.
Andiamo insieme verso il capannone dei macellai; per
raggiungere i vari banchi occorre farsi strada tra la folla degli
acquirenti.
«Si trova solo carne di cammello», mi dice.
In effetti riconosco quelle immense costole poco arcuate, simili a
quelle disseminate lungo le piste del Tian Shan.
«Non ha un gusto cattivo, ma questa volta voglio proprio del
bue, anche se costerà certamente più caro, forse quattordici o
quindici rubli al chilo».
Lo lascio alla sua faticosa ricerca e mi allontano in direzione dei
sellai; sul marciapiede alcuni ciabattini vendono quegli stivaletti
morbidissimi che le donne calzano sotto le calosce. A Parigi, Vera mi
aveva chiesto di portargliene un paio.
Offro quindici rubli.
«No, venti, è cuoio... Molto bello!». Insisto sui quindici rubli
rifiutandomi di pagarli di più dato che alla cooperativa costano
soltanto dodici.
«Cooperativa, pelle cattiva».
Tutt'intorno un forte odore di polvere, di paglia trinciata, di
escrementi di animali, di cammello o di cavallo, ma anche umani;
questi ultimi riconoscibili dal tanfo dolciastro.
Lascio quei venditori irremovibili per andare a riposare in una
čajkana dove potrò godere di un minimo di refrigerio. Un russo e un
uzbeko discutono fra loro. Quando il primo si allontana offro una
zolletta di zucchero al suo interlocutore, la cui aria simpatica mi
invoglia a chiacchierare.
«Sì», dico, «la vita qui è veramente interessante; io vengo da
lontano, sono curiosa di vedere come funzionano le cose in questo
paese che vorrei tanto visitare. Ma il plov è davvero caro!».
«Ah! Siete straniera. Da voi, nella terra di Francia, il riso cresce?
Forse non sapete che cosa hanno combinato qui. Poiché avevano
impartito l'ordine di piantare ovunque il cotone, è passato l'aratro
distruggendo tutti i canaletti delle nostre risaie, mantenute con tanta
cura. In seguito però, rendendosi conto della scarsa produzione
delle nuove colture, hanno voluto che ripiantassimo riso su un terzo
del territorio. Ma ora non è più possibile, i canaletti sono
prosciugati... E c'è dell'altro: le chiavi, per esempio. Un tempo non se
ne conosceva l'esistenza, tutto rimaneva aperto, case e negozi.
Adesso ci roviniamo per comprare catenacci, ma il furto è sempre
all'ordine del giorno».
Desiderando visitare l'istituto femminile torno indietro per una
via parallela. A ogni passo mi fermo, attratta dai vari tipi umani che
passano: pallidi iraniani dai baffi neri, bronzei tzigani dall'ampia
fronte ossuta, tagiki dai volti simili a quelli incontrati sul
Mediterraneo. Dieci donne sedute sul marciapiede, al riparo dietro la
cortina del loro velo nero, tengono sulle ginocchia una pila di
camiciole da vendere. Quarti di cavallo sono appesi all'angolo di una
casa.
Un uzbeko è indaffarato con due splendidi dromedari
accovacciati, il cui fiero profilo aquilino non è avvilito da alcun foro;
portano soltanto una museruola formata da una catena.
Lezione di lettura
All'angolo della piazza una grande tipografia e nel mezzo un giardino
dove, davanti a un'antica madrasa — l'università musulmana — la
statua di Lenin tende per sempre il braccio alzato; ancora qualche
passo ed ecco l'istituto, edificio del tutto simile a una scuola.
A un custode che non capisce il russo chiedo del compagno
Ahmetof. In un'aula al primo piano si svolge una lezione di lettura
con l'ausilio di un opuscolo che racconta la storia del proletariato.
Una quindicina di giovani donne e di ragazzine segue con grande
attenzione; hanno appoggiato i parandja e i rigidi čador sul
davanzale della finestra. Con un tratto di ombretto nero hanno unito
le sopracciglia che, se congiunte, sono segno di temperamento
passionale; i caratteri del viso, pallido e rotondo con grandi occhi,
sono quelli tipici dei turchi ottomani.
Per non disturbarle mi sistemo su una panca sperando di
passare inosservata. La mia vicina sta allattando il figlioletto disteso
su una coperta: il piccolo è praticamente nudo, a parte una camiciola
troppo corta con il colletto alla marinara. La giovane donna segue il
testo con la mano destra, ma talora è costretta ad alzarla per
immobilizzare i piedini del suo marinaretto!
Aspetto la fine della lezione: tutte rimettono il loro parandja sul
capo. Vedendo che mi avvicino per esaminare meglio un čador, me
ne porgono uno facendomi segno di provarlo, cosa che le diverte
moltissimo. Il maestro, che porta la giacca, spiega loro che vengo da
lontano e poi mi accompagna a visitare l'asilo, l'infermeria, la
biblioteca e infine, al pianterreno, il salone per le riunioni.
«Questa sera terremo una conferenza, dovreste venire».
Trovo la scusa di essere già impegnata perché non oso
confessargli quanto mi annoino simili riunioni, eternamente uguali
ovunque si tengano, a Nalčik, a Karakul o a Mosca. Mi fanno
pensare alle ruote da preghiera tibetane: necessità di sviluppare la
cultura fra gli indigeni, di educare le masse, di edificare il socialismo
grazie al livellamento delle classi. Il socialismo, soltanto il suo
avvento salverà il mondo dal crollo capitalista.
Ebbene, anche se esso è la nostra comune salvezza,
bisognerebbe orchestrarlo con un po' più di fantasia.
Dopo innumerevoli peregrinazioni nella città vecchia, arriviamo
alla casa del maestro che ha acconsentito a farmi conoscere sua
moglie. Al fondo di un vicolo buio chiuso da un muro si apre una
porta: superatala, mi trovo dinanzi a un cortile minuscolo, delimitato
a sinistra da una parete di vimini e sul lato opposto da un peristilio; di
fronte intravedo una stanza assai pulita, il cui solo mobile è un letto,
sicuramente fatto con un'asse, tanto mi sembra duro. Per terra pile
di libri scolastici; nei muri, divisi in pannelli simmetrici e intonacati a
gesso, sono scavate piccole nicchie per riporre ciotole, teiere, piatti;
sul pavimento, un tappeto, un baule e alcune coperte. Una tovaglia è
poggiata sul tappeto; i pasti si preparano fuori. La moglie lascia le
babbucce sulla soglia di casa e a piedi nudi porta su un vassoio di
rame una zuppiera contenente il lapša, che mangiamo con un
cucchiaio di legno.
La giovane donna mi piace: il corpo sottile sotto il vestito
informe, gli occhi grandi e vivaci, le efelidi sul viso, i ricci capelli
castano chiaro legati in lunghe trecce, lo sguardo espressivo che ne
lascia trasparire l'intelligenza.
Purtroppo però non conosce una sola parola di russo. Il maestro
si stupisce che la trovi graziosa, non è del mio stesso parere.
«Studia all'istituto pedagogico. Certo, non porta più il velo».
Mi accorgo che sta aspettando che il marito finisca il suo pasto,
per mangiare e bere a sua volta; il bambino intanto gioca sul
pavimento con una scarpa.
Usciamo insieme senza che l'uomo le abbia fatto un cenno di
saluto.
La distribuzione dell'acqua si effettua ovunque grazie agli aryk;
solamente nei quartieri più moderni hanno iniziato i lavori di
sistemazione idraulica tramite canalizzazioni. Si tratta di un'impresa
enorme dato che la città, con le sue case costruite a un solo piano
per timore dei terremoti, copre una superficie vastissima.
Finisco la serata al teatro uzbeko, dove una compagnia
indigena offre un adattamento assai interessante della Fuente
Ovejuna di Lope de Vega, commedia che già avevo visto, recitata in
maniera eccellente da attori del teatro ebreo dei russi bianchi, a
Mosca due anni fa, in occasione delle prime Olimpiadi teatrali.
«Pravda Vostoka»
Finora nessuno mi ha chiesto il visto: assumerò dunque
l'atteggiamento disinvolto di chi ne è in possesso. Mi reco a visitare
la sede del giornale «Pravda Vostoka», la «Verità dell'Oriente,
organo russo del partito comunista: molti uffici, attività febbrile.
Alto, simpatico e con gli occhi azzurri, giovane malgrado la
calvizie, il direttore Tselinski, seduto sul tavolo, mi ascolta con
interesse. Gli offro il mio libro — vuole che gli scriva una dedica —
raccontandogli da dove vengo e dicendogli che vorrei vedere una
piantagione di cotone. Approfitto dell'occasione per confessargli che
il ristorante al quale ho diritto è troppo costoso per i miei modesti
mezzi.
«Accomoderemo ogni cosa», mi tranquillizza. «Ecco qualche
buono con cui potrete mangiare gratis alla nostra mensa sindacale,
laggiù, al piano interrato di quell'edificio sull'altro lato di
Voskročenski. Riguardo al vostro secondo desiderio, vi manderò
qualcuno della nostra sezione cotoniera per farvi accompagnare in
un kolchoz».
Convocato però il giovane Naskov, ricevo la cattiva notizia che
l'auto è in riparazione.
«Sono spiacente, desideravo farvi incontrare Pakhta Aral, un
decorato dell'Ordine di Lenin. Possiamo rimediare affittando una
linejki, così Naskov vi condurrà a Baumann. Poi, perché non venite
con noi a Boz Su dopodomani, che è il giorno della nostra gita
collettiva?».
Siamo continuamente interrotti da telefonate e da visite e ogni
volta l'argomento è il cotone. Anzi, qui tutto parla di cotone: la foto di
un camion munito di apparecchiatura per raccoglierne i bioccoli; in
ogni dove tabelloni con diagrammi che stabiliscono la percentuale
fornita dalle varie regioni ogni sei giorni. Sembra di essere, più che
nella redazione di un giornale, in un quartier generale pronto a
sferrare l'offensiva Cotone. Occorre, a qualsiasi costo, raggiungere
le cifre fissate dal Piano per fine dicembre; l'intero Turkestan ne
dipende. I contadini ricevono grano solo in proporzione al cotone
consegnato.
«Ho pubblicato nella rubrica di oggi», mi informa il direttore, «la
traduzione di un articolo del “Frankfurter Zeitung”, dove si asserisce
che il mondo ha gli occhi puntati su questa parte dell'Asia centrale.
Danneggiamo il commercio americano ed egiziano producendo noi
stessi il cotone che ci occorre. L'esempio delle nostre repubbliche,
ormai libere dal giogo imperialista, indurrà le colonie asiatiche
sottomesse alla Francia e all'Inghilterra a ribellarsi...».
Cotone nel villaggio
Alcuni giorni dopo, insieme con Naskov, scendo al capolinea di
Lunačarski: l'esperienza vissuta durante il percorso mi costringe ad
ammettere che la folla dei tram moscoviti, a paragone di quella di
Taškent, è assai meno brutale. Il mio accompagnatore noleggia una
delle carrette là in sosta e ci dirigiamo verso un villaggio situato a
circa dodici chilometri di distanza.
Mi sono già trovata in questi luoghi, ospite di una famiglia ebrea
che festeggiava un compleanno: per l'occasione erano stati disposti
sul tavolo, imbandito per il tè, dolci deliziosi. Il figlio, ingegnere
idraulico, mentre improvvisava su un piano a coda, mi parlava del
Tagikistan, da cui era appena ritornato per curarsi la malaria.
«Ecco un paese che dovreste visitare. Là, tutto si sviluppa, di
mese in mese, in modo straordinario. I giovani volenterosi hanno
grandi possibilità di lavoro; il futuro è nelle mani di chi sa coglierlo».
«E i basmaci?, avevo obiettato.
«Dopo la cattura di Ibrahim Bek, nel 1931, nessuno ne parla
più».
Le ruote della nostra linejki sprofondano in uno strato di polvere
alto dai trenta ai quaranta centimetri, quasi una soffice distesa
d'acqua che tutto ricopre e livella; i passi dei cavalli risuonano con
un rumore sordo.
Muri, giardini, campi. In un piccolo villaggio melanconico ci
fermiamo dinanzi a una casa confinante con una čajkana. In una
stanza sordida vi è l'ufficio del kolchoz Durmen-Baumann.
I 195 ettari che fanno capo a questa direzione hanno prodotto
l'anno passato 291 tonnellate di cotone (la prima scelta, raccolta
prima delle piogge, è valutata 32 copechi al chilo), il che equivale a
un'assegnazione proporzionale di 25 tonnellate di pane.
Attraversiamo campi irregolari, divisi da canali di irrigazione, gli
aryk, senza i quali nulla crescerebbe. Ve ne sono che risalgono ad
epoca precristiana: allora il loro flusso veniva variato a periodi fissi
secondo le necessità; gli aryk-aksakal ne erano responsabili, ai loro
ordini lavoravano i mirab, vale a dire i capi (mir) dell'acqua (ab). Le
imposte dovute all'emiro di Bukhara erano calcolate in proporzione
alla quantità d'acqua che il contribuente aveva diritto di chiedere; gli
aksakal, o “barbe bianche”, erano retribuiti in natura a raccolta
ultimata. Ma i ricchi bek, proprietari dell'acqua che distribuivano a
loro piacimento, costringevano i contadini a pagare tributi arbitrari.
Ora tutto è regolato scientificamente e le cooperative provvedono ai
bisogni degli operai.
In un libro pubblicato nel 1913 e scritto dal principe Masalski,
funzionario del Ministero dell'Agricoltura, ho letto che l'autore
stimava in 40 000 chilometri di lunghezza la rete dei canali che
solcava il paese: una realtà che lo colmava di ammirazione per
questo popolo dalle conoscenze primitive. Ricordo che, per
associazione di idee, avevo subito pensato ai foggara, quei canali
che si diramano per centinaia di chilometri a quattro metri di
profondità distribuendo acqua in pieno Sahara e sulla cui origine
nulla si sa.
I fiori giallo rosato che vedo, e che durano soltanto un giorno,
appartengono alla specie Navrotski, un cotone degli Stati Uniti
settentrionali; secondo l'istituto superiore di ricerche di Taškent,
questa è la pianta che meglio si addice alla regione. Il cotone, anche
se di qualità assai inferiore, era già conosciuto in era preistorica.
Si tratta di un arbusto dalle foglie dure, lobate, simili a quelle
dell'edera. La semina si effettua a metà aprile; la raccolta inizia a
luglio, al primo aprirsi delle capsule, per continuare fino agli ultimi
giorni di novembre, quando il gelo provoca la schiusa finale.
Ecco donne intente alla raccolta; tutte, giovani e vecchie, mi
osservano ridendo perché le fotografo; le falde rialzate delle loro
vesti scolorite, ricolme di innumerevoli palle di neve, scoprono lunghi
e stretti pantaloni di foggia indiana che sfiorano le caviglie. Esse
avanzano, strappando i bioccoli con gesti precisi.
La palla bianca è costituita da quattro o cinque batuffoli di
bambagia appiattita e arrotolata; ognuno contiene un seme rotondo
e duro, difficile da estrarre dalla peluria che lo avvolge. Spremendo
tali semi si ottiene dell'olio e il panello è trasformato in combustibile.
Khalissa, una donna allegra che porta orecchini d'oro, raccoglie
in media 24 chili al giorno. Si tiene conto della quantità raccolta da
ognuna poiché il pagamento è a cottimo. L'introito medio della
stagione passata è stato di 150 rubli a persona. Tra i componenti
delle 217 famiglie che dipendono da questo kolchoz, ci sono 350
donne operaie.
In un angolo del campo ciascuna ha posato il proprio enorme
sacco di tela grezza e lo riempie poco per volta.
Passo per molti altri campi, ora deserti, per raggiungere l'asilo
dove Khalissa tiene il figlio. Sul bordo di un aryk sono costretta a
fermarmi davanti a un'enorme pianta alta tre metri, con lunghe foglie
alternate come quelle del mais, i cui semi pendono in grappoli
membranosi simili all'interno dei meloni non ancora maturi.
Naskov mi spiega che è giugara, usato per il bestiame, e che è
meno buono del mais.
È un sorgo, il “grande miglio”, la durra degli africani; i kazaki,
con i quali presto vivrò, si nutrono quasi esclusivamente di questa
pianta.
Sotto un albero è seduta una donna: ha appeso a un ramo una
sorta di telaio di legno ai cui bordi è solidamente inchiodato un telo,
così da formare una grande culla dove sgambettano tre o quattro
bambini. Vedendo Naskov e la nostra guida, ella abbassa il
fazzoletto bianco sul viso.
All'ombra di grandi fichi vi sono alcuni samovar e un capanno
dove gli operai vengono a bere il tè a metà giornata.
Chiedo di poter visitare qualche casa, ricca e povera, del
villaggio. Superata la strada principale, un vicolo tortuoso conduce in
una corte su cui si affacciano molte abitazioni; alla mia sinistra sento
gemere: c'è una vecchia malata. Che cosa avrà? E stato chiamato il
medico? Interrogativi senza risposta.
Ci dirigiamo verso la casa centrale, entriamo in una stanza
aperta, con sole tre pareti: un tappeto ricopre il pavimento di terra
battuta. Contro il muro di fondo una pila di coperte impunturate: è qui
che si vive d'estate. Pulizia rigorosa, facile, a dire il vero, con così
pochi arredi.
Sopraggiunge la mia ospite, una donna anziana, molto fine;
lasciate le sue calosce sui gradini, cammina a piedi nudi. Dopo aver
steso una tovaglia, taglia una grande anguria che serve su un
vassoio di rame con fette di pane secco. Naskov è rimasto in ufficio
non potendo entrare negli iškari, la guida conosce soltanto il russo:
devo perciò accontentarmi di guardare.
«Dove abiti tu sarà certo più bello», osserva il mio
accompagnatore.
Mi piace la penombra di questo interno, di assoluta ed
essenziale semplicità. E in inverno, come si scalderanno? Sul
pavimento in terra battuta è scavato un rettangolo di un metro e
mezzo di lato, il sandal quando fa freddo vi vengono disposte sul
fondo delle braci, riparate da un tavolo basso su cui poi viene ancora
stesa una trapunta di modo che il calore non si disperda; intorno ad
esso la famiglia si accovaccia. Tappeti, bauli, teiere in gran numero,
mucchi di mele e, in una nicchia del muro costruito con fango
essiccato, una foto di gruppo: il figlio studia a Taškent. Per terra, in
un angolo, una piccola cavità protetta da una lastra traforata è
adibita allo scolo dell'acqua per le abluzioni... quando il condotto non
è ostruito.
Sotto il tetto, un granaio a giorno dove è appeso il granoturco a
seccare.
Ora è la volta di una casa povera: medesima disposizione, ma
meno oggetti e maggiore trascuratezza. Due ragazze lavorano; una,
dai capelli in disordine, sta facendo essiccare semi di anguria, l'altra
raccoglie sterpi di riso. Quest'ultima, scura di pelle, ha tratti assai
schietti, sopracciglia sottili e parallele alla linea orizzontale degli
occhi dalla cornea giallastra, seni turgidi che tengono sollevato il
tessuto consunto della veste.
«Non trovi che sia terribilmente nera?», mi sussurra la mia
guida.
Le ragazze non capiscono il russo.
Insieme con Naskov camminiamo lungo la strada, decisi a
saltare sul primo camion che passerà, ma nessuno si ferma. La
polvere è una maledizione del cielo, certamente il čador è stato
inventato per risparmiare il volto delle donne.
Una carovana di cammelli ci viene incontro; libere dal carico, le
bestie avanzano con aria pretenziosa, come se facessero passi
troppo lunghi per le loro gambe. Per fotografare le loro sagome sullo
sfondo del cielo scendo in fretta verso la pista sottostante
affondando bruscamente in una buca; per il contraccolpo socchiudo
le labbra con cui tenevo un filtro giallo, che cade ai miei piedi.
Scattata la foto, mi metto a cercarlo. Anche se ho evitato
accuratamente di muovermi, nessun segno appare sulla polvere.
Scavo con metodo immergendo ambedue le braccia che affondano
fin sopra il gomito prima di incontrare il suolo ghiaioso.
Naskov mi aspetta. Gli indigeni di passaggio mi aiutano a
cercare. Malgrado la mia natura ostinata - quel filtro è per forza qui!
— dopo una mezz'ora rinuncio. Vicino a noi stanno riparando un
camion, appena pronto ripartirà. Durante l'ora di attesa vedo due
uomini che ancora perlustrano tra la polvere. Mi avevano domandato
che cosa avevo perso.
«Un pezzo di vetro rotondo, giallo».
Immaginando che soltanto una moneta d'oro poteva farmi
inginocchiare, perseverano nella ricerca senza scoraggiarsi. Forse
sono ancora là.
Boz Su, l'acqua bionda
Per la gita a Boz Su sono predisposti due tram speciali per condurre
il personale del giornale fuori città. La nostra meta è un giardino
pubblico che circonda il lago, sul quale andremo in canoa.
Come a Mosca, tutti impiegano con grande entusiasmo il
proprio giorno di libertà ad allenarsi, ligi al motto “Pronti al lavoro e
alla difesa”. Di norma è previsto che si debba correre, saltare,
nuotare con o senza abiti, remare, tirare, lanciare granate a una
distanza superiore ai quaranta metri, sollevare e portare pesi,
percorrere in ventun minuti tre chilometri sugli sci.
Poiché vi sono cabine e un trampolino per i tuffi, eccoci tutti in
costume ridottissimo, come se fossimo a Juan-les-Pins. Nell'aria
echeggiano gridolini di sorpresa al contatto freddo dell'acqua.
Fisarmoniche, chitarre, balalaike: l'orchestra suona musiche
vivaci, mentre le coppie volteggiano sulla strada. Gli spettatori
assaporano uva moscata.
Una donna si occupa dei bambini, facendoli giocare a girotondo,
in modo che i genitori possano stare tranquilli.
Gli uomini si esercitano a lanciare granate.
Dietro una cinta, in un teatro all'aperto si festeggia con pomposi
discorsi il quarantesimo anno di attività dell'eroe Maksim Gor'kij.
Passa una fanciulla con il fucile in spalla e mi invita ad andare a
tirare. Ma gli appassionati sono tanti e occorre aspettare il proprio
turno. Coricati bocconi, si mira ai bersagli sistemati contro il muro:
ognuno ha a disposizione tre colpi di prova e dieci cartucce.
Piuttosto soddisfatta dei miei risultati, premo il grilletto una settima
volta: la vista mi si annebbia, tutto diventa nero, gli occhi mi bruciano
terribilmente. Mi trascinano via porgendomi un fazzoletto perché le
lacrime mi scorrono a fiumi. «Cieca, cieca e sola a Taškent!», ripeto
disperata.
Ma poco dopo le mie palpebre si distendono e finalmente si
aprono: ci vedo! Era solo polvere negli occhi. Mi dirigo alla mensa
sperando di placare quel senso di vuoto e di fame causato
dall'emozione, ma è troppo tardi, la fila è scomparsa: il plov è finito.
Un confinato anarchico
Andavo a trovarlo ogni sera. Se allora avessi saputo che presto
sarebbe morto avrei avuto il coraggio di fargli più domande e tenuto
in maggior conto le sue parole! Come sarebbero diversi i rapporti
con le persone che stimiamo se pensassimo sempre di parlar loro
per l'ultima volta.
Ma il futuro è ignoto. E così lo lascio raccontare a ruota libera,
evocare il passato, la vita a Ginevra dove era rifugiato politico
durante la guerra.
«Conoscete quel piccolo ristorante a Plainpalais? Vi andavo
sempre a mangiare la fonduta».
È un uomo di cinquantadue anni, di corporatura alta e robusta;
ha fronte ampia, baffi biondi, occhi sgranati e sembra essere di
temperamento facile ad alterarsi.
La moglie lo ammonisce di continuo di non agitarsi troppo. È
una donna pallida, troppo pallida, dignitosa, sicura di sé, che talora
scoppia in un'improvvisa risata riacquistando i tratti della bionda
fanciulla di un tempo.
Dei due, lei sola lavora: mantiene la famiglia con il suo salario di
impiegata. Al rientro, la sera, prepara la cena. Per accedere alla loro
stanza si deve passare dall'abitazione del proprietario, 1 unica
divisione tra i due ambienti è un telo di stoffa che serve da porta. La
presenza dello scomodo vicino ci costringe a stare attenti a quanto
diciamo in russo: l'uomo, infatti, è in cerca di un pretesto qualsiasi
per mandar via Nikola, così da poter dare la camera a un suo amico.
Discorriamo dunque in francese e Anna, per soddisfare la
curiosità del padrone di casa, gli spiega che ci siamo conosciuti ai
tempi dell'esilio del marito.
Senza capirne i motivi, Nikola percepisce una grande ostilità
intorno a sé. Ogni sua richiesta di impiego è stata respinta, malgrado
egli abbia dato prova di grande intelligenza e capacità in campi assai
diversi da quello politico, avendo lavorato per anni presso
l'Associazione scientifica caucasica di Tbilisi, peraltro da lui stesso
fondata. Per quell'attività non si era certo risparmiato e aveva
percorso montagne e montagne. Ora è stanco di vedere ogni volta
svanire le sue speranze, mi confida Anna.
Ascolta dunque con grande entusiasmo i miei suggerimenti per
uscire dalla sua incresciosa situazione. Nato in Russia, ha adottato
un nome russo all'inizio della sua militanza anarchica, ma è ceco per
parte di padre. Se facesse intervenire Masaryk - che un tempo ben
conosceva —, potrebbe ottenere il rimpatrio.
«E Anna?», domando.
«Presto o tardi mi raggiungerebbe; non sarebbe la prima volta
che attraversa frontiere senza permesso pur di seguirmi. Già sotto
Kerenskij, prevedendo la rivoluzione, è riuscita a entrare in Russia
per prestare ai feriti la sua opera di infermiera. Quando ha saputo
che stava per essere tradita, è stata capace di uccidere con
freddezza un ufficiale».
«Che parta, se è possibile», interviene Anna. «Ha bisogno di
cure. Lo hanno arrestato a Tbilisi per motivi che ci sono ancora
ignoti, e ha subito una condanna a tre anni di prigione; dopo due
anni però gli hanno concesso di venire a Taškent poiché soffriva dei
postumi di una pleurite».
«Mi ero ammalato nel 1923, quando facevo propaganda a
Kabul. A quel tempo mi ero appena ripreso da un forte attacco di
malaria che mi aveva costretto a lasciare Ankara dove lavoravo per il
nostro dipartimento di informazioni».
Intanto la moglie lo invita a finire almeno la sua uva e a bere il
tè.
«Ah, l'uva! Quanta ne ho rubata nelle vigne del Valois! Ho
percorso a piedi tutte le vostre montagne, che ricordo stupendo! Mio
padre era agronomo e zoologo, da lui ho ereditato la mia sola
religione, la natura. La vita era ben dura a Ginevra. L'Internazionale
socialdemocratica aveva assunto posizioni scioviniste e vi era anche
una frattura nell'Internazionale anarchica: Kropotkin chiedeva aiuto
per difendere la rivoluzione francese contro l'imperialismo
germanico. Io avevo fede nell'idea di Bakunin, espressa nel suo
testo fondamentale, L'Impero germanico del “knut” e la Rivoluzione
sociale. Decidemmo di riunire le forze degli internazionalisti anarchici
ancora fedeli e con gli ultimi soldi pubblicammo il “Nabat”, le
“Campane a martello”, che inviammo in Russia clandestinamente.
Allora lavoravo per pochi soldi in una fattoria e al contempo seguivo
corsi di diritto e di scienze sociali all'università. Soltanto dopo la
rivoluzione d'ottobre ebbi la speranza di poter ritornare in Russia. Mi
unii infatti all'ultimo gruppo di emigrati e insieme arrivammo alla
fortezza di Dunaburg nel gennaio del 1917 per poi attraversare la
frontiera su un treno extraterritoriale guidato dal compagno svizzero
Platten. Sempre a piedi avevo già attraversato i Pirenei, Andorra, la
Francia meridionale e lavorato a lungo con gli operai catalani,
partecipando allo sciopero generale del 1911».
Gli domando ancora come e perché è diventato anarchico.
«Mio padre aveva ricevuto un'educazione democratica. Nel
periodo in cui vivevamo in Ucraina, nel Donbass, regione di minatori
e di contadini, mi interessavo alla letteratura locale, condividevo con
i cosacchi di Zaporožje l'aspirazione a un rinnovamento. Tutti noi, in
famiglia, odiavamo l'imperialismo russo che schiacciava l'Ucraina.
Mia madre era di nazionalità russa. In quel tempo vi fu uno sciopero
nelle miniere di carbone durante il quale il governo aizzò i contadini
contro i minatori. Vi furono esecuzioni di massa e molti uomini furono
condannati ai lavori forzati.
«A scuola sono diventato, mio malgrado, un dirigente tenendo
conferenze sui movimenti rivoluzionari su cui ero stato istruito da un
assistente, Strumilin, che ci faceva leggere continuamente testi di
marxismo elementare. Pur seguendo i corsi serali, partecipai per
parecchi anni alla vita degli operai, impegnandomi nell'attività
socialista rivoluzionaria. Per completare la mia educazione in quel
campo decisi di recarmi all'estero. Ricordo ancora il Re Alessandro I,
il cargo su cui mi imbarcai a Odessa, così come il feroce litigio con il
capitano che aveva consegnato il mio passaporto, naturalmente
falso, a un'agenzia perché si occupasse di rimpatriarmi. Per fortuna
riuscii a fuggire in un porto della Dobrugia».
Ma a questo punto Anna lo interrompe consigliandogli di
raccontarmi di Bukhara, argomento che, a suo parere, mi interesserà
di più.
«Sapete, Ella, dovete assolutamente ottenere un'intervista con
Faisula Khodjajev e cercare di fotografarlo con il suo turbante. È così
seducente che tutte le donne se ne innamorano».
Domando se si tratta del Faisula presidente del Consiglio dei
commissari dell'Uzbekistan.
«Certamente, ed è anche uno dei sette membri del Comitato
centrale esecutivo dell'Urss. Strane voci corrono sul suo conto.
Dicono che sia ricchissimo e che abbia un'abilità straordinaria nel
raggirare Mosca; sembrerebbe il migliore dei comunisti, eppure si
mormora che abbia fatto lega con gli inglesi...».
«Lo conobbi», racconta Nikola, «quando fu rovesciato l'emiro di
Bukhara. Lavoravo come segretario agli ordini di Frunze e di
Kubisev, nell'ufficio militare della rivoluzione ed ero il responsabile
del consolidamento del comitato dei Giovani di Bukhara, alla cui
testa vi era Faisula. Quella organizzazione ricalcava il movimento
dei Giovani Turchi e avrebbe voluto ottenere una costituzione sulla
base della sharia, la legge coranica. I suoi membri si unirono
gradualmente al partito comunista. Dopo l'ultimatum inviato nel '18
da Kolesov all'emiro Seid-Mir-Alim, mentre noi stavamo
retrocedendo incalzati dai contadini, fu messa una taglia sulla testa
di Faisula per volontà dell'emiro che giustiziava tutti coloro di cui non
era sicuro.
«Nel '20 le nostre truppe vinsero e io guidai una delegazione
diretta a Bukhara, diventata repubblica nazionale popolare, il cui
presidente era Faisula. Soltanto quattro anni dopo fu formata la
Repubblica sovietica dell'Uzbekistan, che comprendeva i distretti di
Khiva, Bukhara, Samarcanda, Taškent e il Fergana».
«Che cosa c'è di sospetto in lui?».
«Ho dimenticato di dire che nel '18 il governo sovietico del
Turkestan lo espulse. Egli fuggì a Orenburg dove venne arrestato
dall'ataman Dutov, che era un capo bianco. Dutov però lo liberò in
cambio di importanti informazioni su Taškent. A fine luglio Faisula
partì alla volta di Mosca per difendere il suo patrimonio in pecore
karakul, di un valore di cinquecentomila rubli. Ne ritornò trasformato
in bolscevico».
«Come è riuscito ad assicurarsi la fiducia del partito?».
«Non so se effettivamente egli goda di tale fiducia. In tre
occasioni è stato minacciato di espulsione. La prima volta nel '25,
perché contrario alla riforma agraria. Poi quando si oppose
all'emancipazione delle donne: ha due mogli, una a Taškent e l'altra
a Bukhara. La terza perché aveva avversato la politica dei kolchoz.
Ma è sempre riuscito a trarsi d'impaccio, scrivendo lettere di scuse. I
bolscevichi hanno evidentemente bisogno di lui, in quanto tramite fra
loro e gli indigeni. Oggi è il solo rappresentante dell'ex comitato
rivoluzionario dei Giovani di Bukhara».
Domando ancora se, a suo parere, gli uzbeki siano in grado di
governarsi da soli.
«Un giorno o l'altro sicuramente. Sono così ambiziosi da voler
diventare capi di un ufficio prima ancora di saper scrivere
correttamente e si offendono se si offrono loro posti subalterni.
Quando in Europa è sufficiente una sola persona, qui ne occorrono
almeno quattro, tanto è scarso il rendimento sul lavoro; ma non
dimentichiamo che è già sorprendente che qualcosa si faccia. Gli
uzbeki sono molto orgogliosi dei loro impieghi negli uffici, ma se
devono assumersi qualche responsabilità diventano pavidi e insicuri.
Un giorno mi capitò di leggere in calce a una lettera le seguenti
parole, scritte da un capo: “Sono d'accordo, ma non posso firmare”.
Nel '23 il presidente dell'esecutivo, Akhun Babaev, era ancora
analfabeta. Ancora nel 1933 il segretario Ikramov ha segnalato che,
secondo i dati ufficiali dell'ufficio dell'Asia centrale, il 48 per cento dei
membri del partito non sa scrivere».
«Come giudicano i “nazionali” l'alto costo della vita?».
«Vengono decantati i benefici di cui ora è possibile godere:
elettricità, condotte idriche e scuole. Si assicura loro che il secondo
Piano quinquennale soddisferà le accresciute richieste di beni di
consumo...».
Racconto ad Anna e Nikola che alla posta, dove mi ero recata
per spedire un telegramma in Francia, l'impiegata mi aveva
domandato se ero straniera e poi, sempre con lo stesso tono
monotono che contrastava con le sue parole assai dure, mi aveva
confessato di essere allo stremo, di non avere neppure di che
nutrirsi, dato che i novanta rubli del suo salario le bastavano appena
per mangiare nove giorni.
«Quella conversazione», confido ai miei ospiti, «conferma la mia
opinione su quanto possa essere pericolosa una monocoltura
impiantata troppo frettolosamente. Sul momento, e prima degli
adattamenti necessari, essa può infatti causare gravi inconvenienti,
qui come in altre zone dell'Europa e dell'Asia».
«Il cibo è il costante problema di tutti i giorni!», soggiunge
Nikola, consigliandomi di recarmi al Torgsin per i miei acquisti.
Avendogli detto che vi ero andata una volta per comprare del
sapone, mi domanda se ho incontrato dei negri e, visto il mio
stupore, mi spiega che ne hanno fatti arrivare sei dall'America per
problemi inerenti al cotone e che è assai facile incontrarli al Torgsin,
dove essi si riforniscono abbondantemente di whisky, biscotti e
scatole di conserva.
Le risposte del presidente orientale
Alla «Pravda Vostoka» il direttore ha telefonato sulla sua linea
privata, collegata direttamente a quella di Faisula Khodjajev, per
comunicare al presidente che una straniera desidera incontrarlo per
un'intervista. Egli ha acconsentito e così ho ottenuto un colloquio.
«Prendete un interprete, in modo da non perdere tempo in
spiegazioni superflue dato che vi ha concesso solo una mezz'ora. Al
Glavkhlopkom, il Comitato centrale del cotone, lavora una persona
che conosce assai bene sia il francese sia l'inglese».
In un grande caseggiato grigio dai tendoni arancioni trovo il mio
uomo, sepolto sotto una pila di riviste.
«Mi tengo al corrente su tutto quanto si pubblica nel mondo
riguardo al cotone», mi spiega.
Fissiamo un appuntamento per recarci allo Sovnarkom e,
mentre mi appresto a uscire, entra un negro. Ha un volto che irradia
intelligenza, occhi bellissimi; indossa una camicia di seta e un abito
di taglio perfetto: sembra un dandy uscito da Cambridge. È uno degli
ingegneri specializzati dell'istituto del cotone, provenienti
dall'America del Nord.
Rimango a bocca aperta. Mi rendo conto soltanto ora che
mentre Nikola mi parlava di quei negri che avrei dovuto incontrare al
Torgsin, facevo inconsciamente riferimento a stereotipi formatisi
nell'infanzia - e quindi particolarmente duri a morire - e immaginavo
creature dai capelli crespi, bestie da soma delle piantagioni. Quei
negri, che in Alleluja raccoglievano il cotone o che venivano
rappresentati da Covarubbias cantando esaltati i loro spirituals,
hanno ora una grande rivincita: i loro figli, riattraversano nuovamente
il mare e vengono a insegnare ad altri il proprio sapere.
«Il mio recente soggiorno di parecchi mesi nel Kirghizistan mi ha
permesso di rendermi conto dei molti problemi con cui si deve
confrontare lo stato sovietico in Asia centrale. Credo che voi siate la
persona più qualificata per erudirmi e vi sono riconoscente per
avermi voluto ricevere».
Nella grande sala Faisula siede dinanzi a un immenso tavolo la
cui forma a T mette fra noi una certa distanza. Il presidente, alzatosi
al mio arrivo per venirmi incontro, non è alto, veste di scuro, ha
bellissimi occhi neri, testa e viso ovali, incarnato dai riflessi dorati. Se
lo avessi incontrato in un salotto l'avrei scambiato per uno spagnolo.
Inizio l'intervista domandandogli se i “nazionali” saprebbero
governare senza l'appoggio dei russi.
«È assai difficile rispondere. Tutto dipende dal livello di
preparazione dei nostri quadri. Fino al 26 il russo era la sola lingua
usata dal governo, ma ora i villaggi e le organizzazioni centrali
tengono i loro rapporti in uzbeko. Questo è anche l'idioma che viene
usato nelle scuole. Nel '24 soltanto il 10 per cento poteva vantarsi di
non essere analfabeta; nel '32 siamo saliti al 60 per cento. L'opera
educativa è forse più facile con i tagiki, dato che sono stanziali».
«È forse questo il motivo per cui lo sviluppo del Tagikistan è più
rapido e attivo di quello del Kirghizistan?».
«No, la ragione è piuttosto da ricercarsi nelle influenze straniere,
più forti in Tagikistan che altrove. Al momento attuale abbiamo
diecimila studenti uzbeki che si preparano per entrare nei quadri
delle nostre organizzazioni; e a questi bisogna sommare ventimila
studenti russi».
«Quali sentimenti nutrono gli uzbeki per i russi, loro
colonizzatori?».
«Percepiscono naturalmente il grande divario tra la vita di oggi e
quella passata, consapevoli di quanto è stato fatto per favorire tale
evoluzione. Occorre precisare inoltre che un tempo gli uzbeki non
potevano accedere che alle scuole russo-indigene; solo a Taškent vi
erano istituti laici tollerati dal governo. Le scuole nazionali erano tutte
confessionali, e a Taškent il Turkestanskaja Učitelskaja Seminala,
diretto dal missionario russo Ostrumov, formava i maestri. Gli
insegnanti del Turkestan di fede musulmana professavano il
medesimo credo politico dei funzionari originari della Russia, tanto
l'influenza colonizzatrice era forte.
«I commercianti non avevano il diritto di impiantare stabilimenti
su questa sponda del Volga, potevano soltanto agire come
intermediari tra le banche e i fabbricanti. I contadini russi, incapaci di
coltivare il cotone, erano mandati altrove, mentre gli uzbeki
lavoravano sui loro territori. Non ricevendo alcun aiuto dal governo,
essi vendevano i raccolti alle banche con due o tre anni in anticipo,
sicché queste ultime si impossessavano delle terre non appena una
cattiva stagione impediva agli indigeni di far fronte agli impegni
assunti. Ora la terra appartiene alle popolazioni, esse hanno ormai
nazionalità, lingua, letteratura, arti proprie».
Ascoltando le sue parole penso che certamente egli è anche al
corrente di come i bolscevichi, estranei a ogni religione, hanno
operato tale rivoluzione agraria: essi sono stati costretti a sollecitare
approvazione del clero musulmano affinché convincesse gli indigeni
che la spartizione delle terre non era condannata dalla sharia né dal
Corano.
Gli domando ancora in che modo reagisce un contadino asiatico
al regime sovietico e al comunismo.
«Capisce soprattutto quanto grande sia il lavoro da realizzare in
ogni campo. Vorrei anche aggiungere che non vi è una sostanziale
differenza di mentalità; il popolo uzbeko non è mai stato
individualista».
«Ma per quali vie l'apatico Oriente è arrivato ad ammettere
l'idea comunista?».
«Grazie al lavoro a cottimo, che ha rappresentato un intero
periodo della collettivizzazione: fu un momento di basilare
importanza, una tappa necessaria tra l'individualismo e il
collettivismo».
Alla mia richiesta di conoscere le ragioni che lo hanno condotto
a diventare comunista, così risponde: «Mio padre, un uomo
ricchissimo, e morto quando avevo tredici anni; a quattordici ero già
a capo dei Giovani di Bukhara. Nel '17 il nostro principale obiettivo
era di annientare il mir, la grande proprietà. Un'unione era tuttavia
indispensabile, da soli non eravamo abbastanza forti per agire.
Perciò ci rivolgemmo ai russi. Fui condannato una prima volta
dall'emiro e poi ancora dopo la rivolta del '18; durante la guerra civile
mi trovavo in Russia. Al momento della scissione dei buharioti, nel
'17, l'emiro era appoggiato dagli inglesi...».
«Alcuni dicono che abbiate lavorato per l'Intelligent Service».
«Non io, fu Ubaidulla Khodjajev che nel '18, a Kokand, era
ministro degli Affari esteri del governo nazionale nemico».
«Il movimento nazionalista, così ostile all'ideale comunista,
rappresenta un pericolo?».
«I nazionalisti hanno cercato di mettersi a capo del movimento
dei basmaci, sostenuto all'inizio dai kulaki, i contadini agiati. Enver
Pascià era legato a loro, i quali però perdevano sempre più peso
grazie al nostro costante impegno nel diffondere la comprensione
dei nostri obiettivi».
«Ma la nazionalizzazione della vostra lingua, del vostro teatro,
della vostra letteratura non finirà per separarvi dal sovietismo?».
«Affatto, sono proprio i nostri soviet a dirigere la
nazionalizzazione, sicché essa non può diventare un focolaio di
sviluppo nazionalistico. Le nostre azioni sono tutte mirate al servizio
dei contadini e dei proletari, ed essi ci seguono. Come dice la
formula adottata da Stalin: “Nazionale nella forma, proletario nella
sostanza”; o ancora: “Cultura socialista nel suo contenuto, nazionale
nella forma”».
«Ho osservato che a Taškent, nella città vecchia, quasi tutte le
donne sono velate. Secondo voi, tutte queste grandi riforme a favore
delle donne renderanno le dirette interessate più felici? Sembra che
dopo l'emancipazione sia aumentata la prostituzione».
«L'abbandono del čador non è fondamentale in questa
liberazione, è soltanto un simbolo. Hanno voluto attribuirvi
un'importanza esagerata, creando veri drammi di famiglia. Ciò che
conta è la maturità interiore delle donne, acquisita con l'istruzione, la
propaganda, il lavoro retribuito che le affranca dalla dipendenza
dall'uomo. La libertà non è sempre inebriante per loro, ne convengo.
Occorre educarle. E, quanto alla prostituzione, vi saranno sempre
donne oziose inclini a tale mestiere».
Gli esprimo i miei dubbi sulla possibilità che un kirghizo nomade
si trasformi in proletario.
«Perché no? Anche a lui non sfuggono i molti vantaggi di questa
nuova condizione: ha pane, zucchero, stivali, una paga fissa, una
vita organizzata, qualche divertimento. Sono gli stessi vantaggi che
hanno indotto i nostri contadini a realizzare le condizioni del Piano
per la coltura del cotone. Nel 1916 l'Asia centrale produceva sedici
milioni di libbre di cotone importandone undici milioni. Attualmente
siamo arrivati a una produzione di trenta milioni. Già nel '27 la
superficie delle terre coltivate superava quella dell'anteguerra. E il
sistema funziona a meraviglia da quando riusciamo a importare dal
Turk-Sib i cereali qui ora sostituiti dal cotone. È così finita la nostra
dipendenza dal mercato cotoniero capitalista. Tali risultati sono stati
raggiunti grazie all'emulazione socialista».
Vorrei obiettare che la realtà non corrisponde del tutto a quanto
mi ha appena riferito. E Faisula ne è consapevole quanto me, ne
sono certa. Gli abitanti del Turkestan si lamentano di vivere in questo
periodo di adattamento una vita impossibile; del medesimo parere
sono i russi che ho avuto occasione di incontrare, non importa se
dottori, insegnanti, architetti... Lo stesso malessere è avvertito anche
dagli indigeni che ritornano a essere nomadi, sperando in migliori
condizioni di vita. Essi abbandonano i kolchoz dove non sempre le
promesse sono state mantenute e dove il grano importato è spesso
insufficiente.
Fatto strano, con tutta quest'abbondanza di cotone vi è penuria
di olio. Sul tardi, una sera, avendo perso l'ultimo tram, avevo visto
una dozzina di donne sedute sul marciapiede, davanti all'emporio
chiuso di una cooperativa; la mattina dopo, verso le dieci, le persone
in attesa erano ormai un centinaio e tutte con una bottiglia in mano:
«Za klopkovoe maslo», per l'olio di cotone, mi avevano spiegato.
Ma Faisula guarda l'orologio, è giunto il momento di
accomiatarmi.
«Se non sapete dove mangiare», dice ancora, «passate dal mio
segretario che vi darà una tessera per il ristorante del Sovnarkom».
Lo ringrazio dell'offerta e approfitto per chiedergli se è possibile
ottenere un biglietto per l'aereo diretto a Samarcanda, i cui posti
sono sempre assegnati in anticipo. Anche di questo si occuperà il
segretario.
L'intervista è finita senza che il mio interlocutore abbia mai
abbandonato il tono ufficiale, senza che io sia riuscita a stabilire un
contatto veramente diretto fra noi, benché spesso la conversazione
si sia svolta senza l'aiuto dell'interprete. Nell'anticamera una ventina
di persone, in attesa del proprio turno di udienza, mi guarda con
odio: mi sono trattenuta per un'ora e mezza nella grande sala.
Con l'aiuto dell'interprete tutto si accomoda: compilato un foglio,
un'auto ci conduce all'aerodromo per la considerevole somma di
settanta rubli. Al ritorno la macchina si ferma per un guasto davanti a
una grande chiesa, ora circolo di operai metallurgici; la porta
d'entrata è sormontata da un gigantesco ritratto di Lenin, incorniciato
da lampadine elettriche rosse. L'autista attinge acqua da un aryk per
riempire il radiatore, ma a nulla serve. Contrariamente agli usi
asiatici l'uomo bestemmia a più non posso. Sembra che tanta ira sia
dovuta al fatto che perderà la sua lezione di inglese.
Dall'alto dei cieli
Alle otto precise il piccolo Junker a tre posti si mette in moto,
sobbalza, sbanda, si riassesta: abbiamo decollato. Ma, che sta
succedendo? Un'ala cede! No, sta semplicemente virando, l'altra ala
rasenta il suolo nella manovra: ora abbiamo il sole alle spalle, sulla
sinistra. Coraggio, prendi quota! Non vedi i grandi alberi dinanzi a
noi?
Le torri massicce dei silos di cemento, che si ergevano quali
enormi cilindri grigi disegnati da un architetto futurista, ora non sono
che pile di monete allineate.
La chiesa è un pezzo bianco del gioco degli scacchi, che
avanza su un campo grigio. I canali di irrigazione si ramificano in
mille sinuosità fra il verde polveroso dei giardini. I campi di cotone
sono giallastri, macchiettati di scuro. Ecco la striscia gialla di una
falesia lungo il Čirčik, affluente del Syr Darja.
L'oasi di Taškent si va allontanando.
Toni rossicci e vellutati si rincorrono in mille variazioni sulle
sabbie incolte.
Ecco il Syr Darja e i suoi ampi meandri! Conosco bene questo
fiume, l'ho visto scorrere tra i nevai, lassù dove sorge con il nome di
Naryn. Il suo letto lì ancora stretto, con le sue acque impetuose che
scendevano di roccia in roccia, a quel tempo non serviva a nessuno,
nessuno ne snaturava il libero corso con strozzature o sbarramenti
per irrigare campi e alberi della Sogdiana. D'altronde tanta duttilità
non gli ha evitato una triste fine nelle chiuse acque salmastre del
lago d'Aral, dove è costretto a condividere l'ultima dimora con il
rivale Amu Darja.
In questo momento il suo corso inganna terribilmente la vista:
verso sud scintilla come oro, per farsi blu turchese a nord, ma
proprio sotto di noi si spegne in un grigiore desolato.
Malgrado sia assolutamente proibito fotografare, da dietro il
vetro scatto un'istantanea catturando l'immagine della sua ansa, una
grande esse blu circondata da terre rosse. Addio! O forse lo rivedrò
se prima del Caspio mi stancherò dei noiosi tragitti in treno. Nessuno
ha udito lo scatto, né il mio vicino che legge accigliato né il pilota,
che non ha retrovisore. La rotta punta a sud, verso il Fergana, in
linea dritta tra piste che si susseguono come grani di un rosario.
E ora ecco il “deserto della fame”, la Golodnaja, steppa senza
fine, plaga arida e gialla spruzzata di sale bianco.
E le liriche parole di Flecker mi riaffiorano alla mente:
We are the Pilgrims, Master; tue shall go
Always a little further: it may be
Beyond that last blue mountain barred with snow,
Across that angry or that glimmering sea;
White on a throne or guarded in a cave
There lives a prophet who can understand
Why men were born: but surely tue are brave
Who make the Golden journey to Samarkand.
Siamo i pellegrini, maestro; andremo
Sempre un po' più lontano: sarà forse
Dietro quel monte azzurro striato di neve,
O su quel mare furioso oppure scintillante;
Bianco su un trono o protetto entro una grotta
Laggiù vive un profeta che sa
Perché gli uomini sono nati; siamo certo coraggiosi
Noi che seguiamo la strada d'oro per Samarcanda.
Quei pellegrini volevano conoscere le ragioni del nostro nascere, e
le donne nulla potevano per trattenerli... Le loro carovane avrebbero
impiegato tre settimane per raggiungere la famosa città, ma con il
treno occorrono soltanto dodici ore e appena due con l'aereo!
Contrasti violenti: piane senza vita e fertili oasi; deserti
soffocanti, salati, e alte montagne innevate: tende di feltro, da
sempre rifugio dei nomadi, e casermoni operai di Taškent;
musulmane velate e, quale sconcerto! — le loro sorelle in fabbrica,
operaie. Vestigia di Timur, attorno a cui si va formando il proletariato
per edificare il socialismo.
Immagini che si dipanano ai miei piedi, mentre io, alta nel cielo,
guardo dalla mia mobile base in alluminio ondulato.
E quei negri? Non ho potuto interrogarli. E neppure ho
intervistato la moglie del granduca Nikola Konstantinović, un tempo
bandito dalla corte. Era un furfante; a Orenburg aveva rapito la figlia
di non so quale governatore per sposarla... Un giorno incontrai
quella donna: il capo avvolto da un velo di pizzo, i capelli ricci, il viso
dai tratti cascanti, infarinati di cipria, la bocca amara, lo sguardo
inquisitore, se ne andava curiosando in un mercato. Indossava una
giacca grigia di buon panno, bordata di passamaneria, un vestito
bianco a volant e si serviva dell'ombrellino come di una canna da
passeggio; sotto il braccio stringeva un portafoglio. Rovina del
passato... Non riuscivo a staccare gli occhi da lei, che peraltro non
mi notò tanto era occupata a non comprare nulla, sempre più ostile.
Quando l'uva, il prodotto più abbondante della terra di Taškent,
costava due rubli alla libbra...
No, sono stanca di informarmi senza sosta, di porre domande,
di imprimere risposte nella mente. Quale infinita gioia, il silenzio!
Nella steppa della fame le carovane non possono fermarsi
perché i cammelli verrebbero attaccati dai karakurti, ragni neri
velenosi.
Il cielo riluce di opalescenze incomparabili.
Alle chiazze scure che coprivano il suolo si è ora sostituita una
distesa gialla, costellata di macchie lilla. Ed ecco apparire verdi
quadrati, probabilmente campi di erba medica: stiamo sorvolando
Djizak, costruita non lontano dalla gola di Timur. L'aereo s'innalza
per superare le montagne che si parano innanzi a noi. Come vacilla!
Reggerà? So bene che il pilota conosce il suo mestiere certo meglio
di me, ma è appunto la troppa esperienza che mi induce a temere
gesti meccanici, abitudinari...
I valloni di questa montagna desertica sono divisi in piccoli
riquadri regolari. Perché? Ancora domande, basta! Scivoliamo nella
valle dello Zeravšan, il “donatore d'oro”. Siamo arrivati, ecco l'oasi di
Samarcanda, uno spazio verdeggiante disseminato di costruzioni ad
alveare: sono i cortili delle case. E le rovine? Le abbiamo superate,
ora sotto di noi si stende di nuovo il deserto, sembra venirci incontro,
offrirci la possibilità di atterrare sulla sua piatta superficie.
Scendo con il mio occasionale compagno di viaggio, sempre
scontroso, e finalmente ho il piacere di udire la voce del pilota:
«Sono le nove e quarantotto, abbiamo guadagnato due minuti su
285 chilometri di volo».
Prendo le mie due borse guardando con invidia il S.S.S.R.-L 85
che partirà fra dieci minuti per il Tagikistan. Ma è ancora presto. La
sua ombra lunga si proietta sulla sabbia: in quattro ore coprirà un
tragitto per cui occorrono tre giorni di treno. Solitudine. Laggiù una
nuova montagna. Qui una casa. È tutto.
Il pilota, consumato il pranzo, riparte sul suo aereo rombante.
«Quindici giorni fa», mi dice il giovane e aitante comandante
dell'areoporto, «avreste avuto l'occasione di incontrare un signore
inglese che è ritornato a Londra dopo appena quarantotto ore di
permanenza qui. Un tipo sostenuto, compassato e silenzioso. Sono
tutti così in Inghilterra?».
Forse sì... E il loro modo di comportarsi con gli stranieri.
Saliamo su un camion per percorrere i dodici chilometri che ci
separano da Samarcanda. Attraversata la città russa vengo
depositata all'angolo di un incrocio.
«Non avete che da seguire il corso fino alla piazza Registan,
dove troverete la “base di turismo”».
Samarcanda, l'incomparabile
Sempre, quando mi trovo a passare frettolosamente per
qualche luogo di particolare suggestione, desidero soggiornarvi più a
lungo al fine di assaporare con calma le emozioni che da esso si
sprigionano. Vedere il sole giocare lento con le ombre del chiostro di
Monreale; trascorrere la notte al santuario di Delfi per lasciarmi
avvolgere al mattino da quell'atmosfera vibrante sotto il primo raggio
di sole!
Vivere nel cortile squadrato di una madrasa di Samarcanda, un
sogno che si realizza... Quale migliore ricompensa per il viaggiatore
avventuratosi fin qui? I turisti sono rari: ho una camera tutta per me.
È un'antica cella lastricata, imbiancata a calce, con il soffitto
altissimo e una finestrella sopra la porta; gli unici arredi sono un
pagliericcio, un catino smaltato, un tavolo dove sistemo la mia
cucina. È tutto, ma è un mondo.
Mi occorrono due giorni per perlustrare la madrasa dove mi
trovo, quella di Tin-la-kari, in persiano la “moschea dorata”. In
ognuno dei quattro muri del cortile si aprono dieci grandi nicchie
ogivali; quella centrale, la più ampia, è un'arcata tutta rivestita di
splendidi mosaici variopinti: è l'iwan, la porta tradizionale.
L'iwan a sinistra dell'entrata è sormontato da un'immensa
cupola che protegge il luogo di preghiera, la moschea chiusa.
Dalla mia cella vedo a un tratto due europei — abiti e cappelli
grigi - entrare nel cortile con in mano una guida rossa. Nel momento
esatto in cui, provenienti dall'ufficio dove hanno ricevuto le
informazioni richieste, essi si dirigono nella mia direzione, sto
vuotando con slancio il catino davanti alla mia camera. Cercano
proprio me, vogliono trasmettermi i saluti di un'amica tedesca che
vive a Mosca.
Ho l'orlo del mio unico vestito tutto sbrindellato, mia madre
direbbe che sono impresentabile. Pazienza, la cosa mi è
indifferente... Non poi così tanto, dal momento che ogni mattina
tento invano di raccomodarlo. Magari i due mi inviteranno al loro
albergo, dove serviranno senza dubbio portate di vera carne. Non è
accaduto: hanno ragione, il mio aspetto è pietoso. Se ne vanno.
Cielo, come sembrano infagottati in quei loro bei completi quando
incrociano un flessuoso uzbeko! Il suo čapan a fiori è chiuso dal
fazzoletto triangolare ed egli regge in mano una teiera.
Quattro donne sono accovacciate al centro del cortile, scuri
mucchi sotto i loro parandja. Le raggiungo, ci scambiamo i primi
sorrisi. Non portano il čador e due di esse sono splendide. Ma ecco
che sollevano un lembo del parandja reggendolo con le labbra. Che
cosa è successo? Improvvisamente si nascondono il volto, si alzano
affrettandosi tutte verso il loro padrone e signore che le chiama dalla
porta.
In mezzo a una cantina situata su un angolo della madrasa, un
uzbeko riempie di legna un immenso forno rotondo: è il vasaio
intento a preparare la cottura. Spesso vado a tenergli compagnia. In
questo momento gli orifizi ancora aperti del focolare incandescente,
vere porte infernali, inducono a fantasticare; ma subito l'uomo le
richiude con mattoni e terra fangosa e nel frattempo mi confida che è
andata perduta la formula per la preparazione degli smalti blu dei
mosaici.
Recandomi alle latrine, in un cortile sul retro, ho scoperto una
catasta di mattoni di terra cruda, grazie alla quale posso salire sul
tetto della madrasa, una lunga terrazza dove il vento fa tremare
piante ormai secche. Gli indigeni, prima di chiudersi nella casetta
adibita ai servizi, sbriciolano un mattone prendendone qualche
frammento. Evidentemente non sempre si ha a portata di mano un
giornale: nondimeno un mattone mi sembra un po' ingombrante...
Nei deserti o nei fossati ho visto che chi s'accovaccia compie
sempre lo stesso gesto: raccoglie una manciata di sabbia. Ho
appreso in seguito che tale procedimento sostituisce le abluzioni
ordinate dal Corano.
Rimango ore sulla mia terrazza solitaria lasciando errare lo
sguardo sul mare di tetti piatti che delimitano minuscoli cortili interni.
Alberi dal folto fogliame ombreggiano vasche, riserve d'acqua. Il
tetto sopra la moschea si gonfia a intervalli regolari in perfetti
emisferi che proiettano ombre ovali: morbide rotondità da
accarezzare, mappamondi dimezzati su cui giocano i raggi del sole.
Ancora oltre vi è una stretta galleria, ai piedi del tamburo che
sostiene la cupola.
Da qui vedo bene il lato posteriore di Tin-la-kari, la cui struttura
in mattoni grezzi ricorda le quinte di un teatro; la facciata vera e
propria è invece prospiciente la piazza Registan. Da quassù si
vedono anche le sommità dei giganteschi minareti, torri di fabbrica
mai contaminate dal fumo.
È strano, mi appresto a visitare una città di cui mi è nota solo la
magia del nome. Come per Baghdad, pure così pregna di significato,
nessuna idea o immagine preconcetta è custodita dalla mia
memoria. Sarà dunque impossibile patire delusioni: tutto è ancora da
scoprire.
Registan
All'ombra di un portico, in attesa di clienti, lo scrivano pubblico
dorme con la testa appoggiata sul suo čapan ripiegato. Davanti a lui,
accanto a una cartellina e all'astuccio delle penne, vi è un campione
della sua grafia, tenuto fermo da una teiera.
Di fronte, il fotografo di istantanee ha anch'egli esposto il suo
campionario. Ora entra in azione: la cliente del momento, “il cui
ventre è pieno”, solleva per un istante il suo čador: volto troppo
rotondo, occhi splendidi, sopracciglia unite da un tratto di khohl.
L'amica, i cui abiti moderni — gonna corta, camicetta, berretto
ricamato — producono uno strano contrasto, paga il fotografo.
La piazza Registan è superba: tre dei suoi lati sono costituiti
dalle alte facciate delle madrasa restaurate con grande passione
dall'architetto Vjatkin. I lavori, avviati a inizio secolo, continuano
tuttora. Occorre cementare laddove i muri di mattoni scadenti sono
stati danneggiati da vento, sole, pioggia, gelo, e ripristinare i
rivestimenti di smalto che si sono scollati.
La madrasa di Ulug-Beg è bellissima nella sua semplicità: antro
scuro dell'immenso iwan, arco murato entro l'architettura quadrata
della facciata di mattonelle smaltate a motivi geometrici.
A ogni angolo si innalza un minareto isolato, i cui mattoni
disegnano losanghe di colore blu scuro; le cupole intermedie sono
crollate. Il minareto di destra, pericolosamente pendente, è in
ristrutturazione. Da un anno e mezzo tengono in trazione i cavi con
cui l'hanno cinturato a metà altezza, cercando così di raddrizzarlo
senza farne saltare le mattonelle decorative.
Quando Vjatkin morì, su questa piazza si svolse una solenne
cerimonia.
La madrasa in questione, la più antica e importante dell'Asia
centrale, fu costruita nel 1412 da Ulug-Beg, il sapiente nipote e
successore di Timur. Insigne matematico e astronomo, egli dovette
fronteggiare l'opposizione di chi avversava il suo progetto di
laicizzare le università. Fu ucciso in seguito a un complotto di militari
capeggiati dal figlio. Il suo migliore collaboratore riuscì a salvarne
tutte le importanti scoperte scientifiche e si rifugiò a Costantinopoli
nel 1450.
Di fronte, per esigenze di simmetria o per mancanza di
inventiva, si innalza la madrasa di Shir Dar, copia di quella di UlugBeg, costruita due secoli dopo. L'architetto, Jalank Tush, era un
personaggio importante alla corte dell'emiro. Le cupole, all'ombra
dell'immensa facciata, offrono allo sguardo rotondità scanalate dai
settori in rilievo. Soprattutto nel Turkestan le cupole sono sorrette da
alti basamenti cilindrici; del pari, solo in questa regione gli spigoli dei
muri, così come i minareti, si svasano verso l'alto.
Contrariamente alla tradizione, sui mosaici della facciata è
rappresentato un animale, una sorta di leone. Ovunque i motivi
decorativi riproducono frasi in caratteri arabi: «L'architetto ha
edificato l'arco del portico con tanta sublime perfezione che l'intero
cielo se ne stupisce e crede di vedere una nuova luna», oppure:
«Soltanto l'aquila del pensiero riuscirà a raggiungere la sommità di
questa madrasa». E, ancora, leggo incantata: «Nei secoli, nemmeno
l'artista acrobata del pensiero raggiungerà mai con la corda della
fantasia la cima proibita del minareto»; «Tu sei il grande guerriero,
Jalank Tush Bahadur, se si sommano le cifre corrispondenti alle
lettere del tuo nome si ottiene la data della fondazione (1028
dell'Egira)».
Visitare Shir Dar è impossibile poiché è ora adibita a prigione
dei basmaci, il cui processo è in corso da molti mesi.
Costruita nel 1630, la facciata di Tin-la-kari si differenzia dalle
altre per i due piani di arcate che fiancheggiano l'iwan centrale.
Al centro della piazza una folla compatta si accalca attorno a un
saltimbanco per ammirarne stupita i volteggi.
Dietro Shir Dar si apre una piazza rotonda dove sotto una
cupola vi è un piccolo mercato. Là, tra una folla brulicante, si vende
di tutto: copricapi ricamati, saponi, tabacco, lacci, tessuti, foulard,
calze, nastri, frittelle untuose cotte sul momento, pezzi di pecora
poggiati su un grande vassoio protetto da un coperchio di tela a
forma di cupola, sorbetti che evocano splendenti cristalli di neve.
Alcuni prepotenti si fanno largo fra la folla. Attenzione! Devono
passare personaggi importanti: sono i miei visitatori tedeschi.
Rispondo con il mio sorriso più mondano al loro accenno di togliersi
il cappello...
Vicoli dove si svolgono i vari mestieri. Nella penombra dei tetti
spioventi le minuscole botteghe si fronteggiano; qui gli artigiani che
lavorano accovacciati, là i ciabattini e i falegnami. I fabbri che
battono sull'incudine poggiata al suolo sono in ginocchio per essere
alla sua altezza e sembrano quasi inghiottiti dalla terra. A ogni
movimento del mantice, per ravvivare le braci, si sprigiona un forte
odore di antracite, assai simile a quello che ovunque stagna
nell'umida Inghilterra.
Nella stradina sonora degli stagnini mi appare, incorniciata da
oggetti di rame luccicanti, la testa di un giovane uzbeko che arrota
coltelli nella sua bottega: gli occhi splendenti rimandano riflessi neri
e bianchi sotto l'ombra del grande tocco di soffice pelliccia bruno
dorata.
«È volpe, senza dubbio», gli dico.
«No, gatto...».
Dimenticavo, i gatti di Bukhara...
Bibi-Khanym
Rovine di Bibi-Khanym, grandezza andata in fumo. Due immensi
basamenti all'entrata, ammasso di mattoni ricoperti a tratti da
piastrelle di maiolica; ampio cortile alberato, lungo ottantotto metri,
un tempo lastricato. Al centro, sopraelevato di due gradini, si impone
uno splendido tavolo di pietra scolpita, sostenuto da otto piedi cubici,
sul quale veniva poggiato il Corano di Osman. Il tavolo si trovava
prima nel santuario; una delle sue iscrizioni dice che UlugBeg lo fece
trasportare dalla Mongolia, da Djiti. È il kursen, la pietra ai cui piedi
pregano le donne sterili, la mattina a digiuno.
A sinistra, una piccola moschea dove il muezzin intona il suo
canto dall'alto della torretta.
Di fronte ecco l'enorme arco, alto venticinque metri, il portico
della grandiosa moschea sormontato da un quarto di cupola
cavillata, superficie di un turchese tanto splendente da far impallidire
l'azzurro del cielo. Ho ammirato un colore identico sul lago di
Kaškasu, quel classico blu mongolo la cui vista dà un senso di
benessere. Il portico è fiancheggiato da grandi minareti ottagonali, le
cui mattonelle turchesi e blu marino disegnano sui muri motivi in
rilievo; piastrelle di maiolica ornano le pareti del portico. Per
osservare meglio quanto resta di quella cupola, alta cinquantacinque
metri, scavalco il muro di cinta. Mi accorgo allora di un acrobata che
passeggia lassù. Si procura un po' di legna svellendo travi infisse nei
mattoni della volta: sono dure, lisce, color lampone. L'uomo se ne va
con il suo bottino. Il suolo è disseminato di mattoni smaltati.
L'intensità del blu scuro risalta incredibilmente sulla gaia leggerezza
del turchese.
La moschea-cattedrale fu costruita in un tempo troppo breve, in
pochissimi anni, dal 1398 al 1404. Timur, ormai settantenne e
prossimo alla morte — avvenuta nel 1405 — vi si faceva ancora
portare in barella per sorvegliare gli ultimi lavori. Il tempo, i terremoti,
le cannonate della conquista russa del 1868 l'hanno trasformata in
una rovina impossibile da salvare; la cupola è crollata nel 1882.
Non esistono più le numerose colonne di pietra che
delimitavano il perimetro. Lo scrittore contemporaneo Sherif ed-Din
afferma che ve ne erano 480, alte cinque metri. Per trasportarle
erano stati fatti venire dall'India novantacinque elefanti e alla loro
realizzazione avevano lavorato innumerevoli operai e tecnici, giunti
da tutte le contrade circostanti.
Si racconta che Bibi-Khanym, principessa mongola e moglie
preferita di Timur, avesse ordinato la costruzione di una splendida
sala del trono per il suo sposo. Timur, che guerreggiava in paesi
lontani seminando ovunque distruzione e rovina, le inviava a tal fine i
prigionieri più abili.
La principessa ogni giorno si recava a controllare i lavori, il cui
andamento però era rallentato dall'architetto arabo che, follemente
innamorato di lei, sperava così di starle accanto più a lungo.
Impaziente di veder terminata la sua madrasa, Bibi-Khanym gli
domandò come si potesse accelerarne la costruzione.
«Permettendomi di baciarti la guancia», fu la risposta. Ma ella
rifiutò.
La notizia però che Timur era già giunto a Merv spinse infine la
principessa ad acconsentire, ma un attimo prima che il bacio
sfiorasse la sua guancia ella interpose la mano. A nulla valse: quel
bacio era così ardente da bruciare ugualmente la sua pelle,
imprimendole un segno nero, impossibile da cancellare. BibiKhanym ordinò allora a tutte le donne di velarsi il volto.
«Per tutelare il pudore femminile», spiegò poi allo sposo che al
suo ritorno se ne era meravigliato.
Ma Timur, conosciuta la verità, condannò la moglie a essere
murata viva nel suo mausoleo, innalzato di fronte alla moschea.
L'architetto invece, fuggito in cima a un minareto, potè salvarsi
volando via verso Mashhad grazie alle ali che gli erano
miracolosamente spuntate. Alcune leggende attribuiscono la
macchia nera al tradimento, anche se solo a parole, di Bibi-Khanym;
altre sostengono che la comparsa di quel segno fu il castigo per non
aver mantenuto la parola data all'architetto innamorato.
La macchia presto scomparve, ma ancora oggi perdura l'usanza
di chiamare “viso nero” chi viene meno alle promesse o ai propri
doveri.
Già nel 1369 Timur aveva scelto come sua capitale
Samarcanda, che contava allora 150 000 abitanti, e aveva
restaurato la città devastata nel 1218 dal suo antenato Gengis Khan.
Il mausoleo di Tamerlano
Il Gur-i-Mir, il “mausoleo del principe”, ovvero di Timur, ultimato nel
1404, si trova in un'altra zona della città, all'ombra lieve delle acacie.
Il conquistatore stesso aveva espresso il desiderio di essere
seppellito a Kesh dove era nato; egli aveva ordinato di costruire
sull'area di un antica tomba questo superbo edificio per il nipote, il
cui sepolcro doveva avere accanto quelli di due uomini santi. Ma i
suoi successori decisero altrimenti. All'improvviso, al fondo di una
tortuosa stradina attraversata da silenziose donne velate, appare
l'immagine impressionante del Gur-i-Mir, un'enorme semisféra
sostenuta da un cilindro del medesimo diametro che splende sopra
le basse mura terrose e compatte della città. Avvicinandosi, si
distinguono sul tamburo alto sette metri le iscrizioni splendenti al
sole in grandi caratteri cufici, la prima scrittura araba, artisticamente
formate da bianche maioliche, incorniciate di blu scuro.
Procedendo ancora si scorge il basamento ottagonale che
sostiene l'intero edificio. Nel cortile antistante si innalza tra gli alberi
un portico isolato, ornato di arabeschi e di raffinati motivi geometrici
azzurri e verde scuro. Quando si arriva accanto al mausoleo,
alzando la testa verso la cupola, i costoloni in rilievo sembrano
appartenere a uno strano pallone sferico, prigioniero del verde.
Entro da un passaggio secondario. La sala delle tombe è buia, il
sole filtra attraverso una piccola finestra traforata formando gemme
di luce. Dietro una balaustra di alabastro ecco il sarcofago di Timur:
un semplice blocco rettangolare di nefrite verde scuro, una specie di
giada rara, fatta arrivare dall'india. Accanto si allineano le tombe dei
ministri e di alcuni suoi figli, tra cui quella di Ulug-Beg. A fianco della
pietra sepolcrale dello sceicco Seid Bereke si innalza la grossolana
asta del bunčuk, che indica sempre la tomba di un santo. Sotto il
rivestimento di marmo e di alabastro incastonato di diaspro, i muri
lasciano intravedere tracce di pittura e di dorature.
In una cripta sottostante la sala si trovano le spoglie di Timur,
accanto a quelle del suo maestro.
Timur e-lang, “Timur lo zoppo”, che seminò terrore e distruzione
dall'India all'Egitto, seppe creare a Samarcanda monumenti di
inusitata meraviglia.
All'uscita del mausoleo un sant'uomo aspetta in silenzio il cliente
che vorrà comprare una copia delle iscrizioni incise sul sarcofago di
Timur, che così recitano: «Questa è la tomba del potente sultano, il
misericordioso khan Amir Timur... Gurkhan (genero del khan).
Gengis Khan appartiene alla dinastia degli antenati del degno
sultano qui sepolto, in questa cripta santa e splendida. La madre
dell'emiro Buzandshara era Alankuwa, che si distinse per onestà e
purezza senza macchia. Ella fu fecondata da un raggio di luce
entrato nella sua camera aperta, il quale, assunta sembianza
umana, le comunicò di essere il discendente del credente Alija, figlio
di Talib, e profetizzò che i suoi veri eredi avrebbero per sempre
regnato sulla terra».
La strada dei sepolcri
Fuori città vi è un luogo singolare ed emozionante quant'altri mai: è
la strada dei sepolcri di Shah-i-Zinda, il re vivente. Questa necropoli,
iniziata nel 1326, è il più antico monumento costruito dopo la
conquista mongola; fu eretta in memoria di Kussam, figlio di Abbas,
cugino di Maometto.
Dai viali ombrosi di un parco si scorgono le desolate collinette,
deserte e aride, di Afrasiab, sconfinata superficie morta, disseminata
di tombe. Su pendici solitarie sorgono, quali teste d'obice, le cupole
di una decina di mausolei, i cui muri conservano ancora tracce
splendenti degli antichi smalti. In basso, sul bordo della strada,
alcuni uzbeki barbuti sono seduti davanti alla porta d'ingresso,
rivestita di piastrelle di maiolica.
All'interno una grande scala conduce, a sinistra, al mausoleo a
cupola turchese della nutrice di Timur. Giunta in cima alla scala,
sormontata da un'arcata bianca, sono costretta a fermarmi tanto è lo
stupore: cinque facciate di moschee in miniatura sono disposte ai lati
di una stradina lastricata.
L'apoteosi di colori, di arabeschi, di cesellature, di incrostazioni,
di raffinati mosaici, di contrasti sapienti è indescrivibile. Non posso
non rimanerne impressionata, anche se della tradizionale arte
persiana mi incantano veramente soltanto i tappeti, caldi e vellutati,
dai motivi fantasiosi eppure razionali.
A sinistra quasi si sfiorano i mausolei di Amir Zadi, figlio di
Timur, e della sua prima moglie Turkan... E d'un tratto capisco a
quali immagini si siano ispirati gli artisti persiani per i disegni dei loro
tappeti: la meravigliosa facciata delle moschee, la porta ogivale
inquadrata, l'arco dell'iwan — immutabile come la nostra croce —
che riproduce esattamente il mihrab, nicchia ogivale a nido d'ape,
santuario dinanzi al quale il mullah si inginocchia da sempre, mai
stanco della sua “santa ginnastica”.
L'interno di Turkan Aka, dove si trovano numerose pietre
tombali, è assai bello; il soffitto della cupola è ricoperto da iridescenti
mosaici geometrici. Di fronte, riposano l'emiro Hussein, una sorella e
una figlia di Timur. Quando la stradina svolta a gomito, i muri
perdono ogni traccia di smalto. Davanti a un secondo portico, vicino
a due alberi secolari le cui schegge sembrano essere miracolose per
ogni malattia, si innalzano ancora tre minareti. Giungo così in un
piccolo cortile di incomparabile meraviglia. L'oltremare risponde al
turchese, il blu marino al verde smeraldo, il cobalto alla terra di
Siena, l'azzurro lapislazzulo all'ocra: i colori sembrano rispecchiarsi
l'un l'altro, esaltati dalle tinte calde dei mattoni grezzi, creando un
canto che sale verso l'azzurro del cielo.
Le moschee di Kutluk e di Nuri, moglie e figlia di Timur, sono
una di fronte all'altra. Al fondo vi è il santo Ahmed. Le abbaglianti
colonne di Kutluk, interamente turchesi, sono scolpite in profondità,
caratteristica peculiare del Turkestan. Il mullah, sotto la cupola del
portico, apre le porte di legno incredibilmente lavorate; passando
attraverso camere buie giungo al mausoleo di Shah-i-Zinda, il santo
Kassim, chiamato anche Kussam. Nel VII secolo egli aveva
convertito la Sogdiana all'islamismo, ma fu attaccato da un esercito
di cristiani nestoriani. Sconfitto, fuggì; un angelo gli mostrò una
grotta dove tuttora vive. Si racconta che egli gettò a terra il kamča, il
frustino del suo cavallo morto, e che da esso siano germogliati i due
alberi miracolosi vicino al portico. Secondo un'altra leggenda, il
santo, decapitato dai pagani, si rifugiò in un pozzo tenendo la testa
fra le mani, in attesa del momento propizio per liberare la terra dagli
Infedeli.
Nella stanza antistante la tomba si innalzano alcuni bunčuk,
aste avvolte da lembi di stoffa a cui i fedeli appendono code di
cavallo, pegno, ciascuna, di un sacrificio offerto. La coda è un
simbolo di forza: forse il cavallo era riuscito a scappare ma il suo
padrone, ben saldo, aveva trattenuto la coda con le mani! La tomba
è avvolta dall'oscurità, inaccessibile dietro un'inferriata.
Afrasiab
Ha nome Afrasiab il vasto spazio arido e desolato che si stende
dietro Shah-i-Zinda, formato da colline polverose, talora da tombe
sovrapposte, semplici volte di mattoni, piccoli tunnel in rovina. Così
si chiamava il nono re della dinastia persiana Peshdad. Turco di
nascita, fu il più famoso membro di quella antica dinastia, risalente
all'XI secolo a.C. Il suo nome rappresenta negli annali del paese
tutto quanto è antichissimo.
Quale significato attribuire a questa immensa superficie informe
dove ogni secolo ha deposto il proprio strato di polvere, rigurgitante
di frammenti di terrecotte? Si individuano nettamente quattro cerchie
di colline; nel centro, secondo quanto hanno mostrato gli scavi,
viveva la dinastia regnante, poi vi erano le abitazioni dei mercanti e
dei militari, mentre l'ultima cerchia era occupata dagli orti coltivati.
Ancora oggi gli uzbeki leggono o narrano a viva voce le
straordinarie imprese di Iskandar Sulkarnein - vale a dire di
Alessandro Magno — che avrebbe fondato Marakanda. Il grande
conquistatore, giunto qui nel 334 a. C., uccise l'amico Clito e sposò
Rossana, figlia del capo iraniano della regione; egli volle che anche i
suoi ufficiali prendessero in moglie le donne di quel paese, al fine di
legare l'Europa e l'Asia con vincoli di nozze legittime e con la
comune discendenza.
Alessandro non incontrò turchi nel Turkestan, che allora si
chiamava Sogdiana o Transoxiana, ma si imbatte nei Parti, arcieri a
cavallo, e nei Battriani, delle cui terre è originario il cammello. Là il
mazdeismo, la religione più diffusa, applicava i precetti di
Zarathustra, fondati sulla lotta fra l'ombra e la luce. In tempi
posteriori il mitraismo farà i suoi adepti fin nel mondo romano, e,
inversamente, il cristianesimo nestoriano, sorto nella Siria romana,
avrà seguaci anche in Cina. A nord, oltre il paese degli sconosciuti
Sciti, vivevano, insospettate, le genti innumerevoli degli Unni.
Il grandioso progetto universalistico di Alessandro Magno crollò
con la sua morte, avvenuta a Babilonia, in seguito a febbri provocate
da un banchetto troppo abbondante. Egli aveva trentatré anni. La
crudele Rossana potè finalmente vendicarsi della sua rivale, figlia di
Dario e seconda moglie di Alessandro, e l'assassinò; ma fu a sua
volta uccisa insieme con il figlio. Prese allora il potere il generale
Seleuco che fondò in Persia la dinastia seleucide, destinata a
regnare per tre secoli.
L'Iran sarà poi dominato per quattro secoli dai Sassanidi,
minacciati, anche se non gravemente, dai primi nomadi, gli Unni
bianchi (o Eftaliti), che nel 477 conquistarono il Kandahar, regione
dell'Afghanistan. Nel VII secolo, con l'avvento dell'islam, il regno dei
Sassanidi cadde in mano agli Arabi, mangiatori di lucertole. Nel 643
acquisì grande fama un conquistatore chiamato Samar, colui dal
quale prese forse il nome la città di Samarcanda. Dall'873 al 1004 la
dinastia iranica dei Samanidi si stabilì a Bukhara, difendendo l'Iran
contro le tribù nomadi del Turan e le orde turco-mongole.
Nel 980 nacque a Bukhara Ibn Sina, meglio conosciuto come
Avicenna, il principe dei medici, celebre in tutte le università arabe.
Nell'XI secolo invasero il paese i turchi selgiuchidi, provenienti
dalla steppa kirghiza; essi formarono piccoli stati convertendosi alla
sedentarietà, divennero musulmani sunniti, persino difensori del
califfato abbaside di Baghdad.
Ma si stava avvicinando, terribile, il XIII secolo. Il figlio di
Yesügei Ba'atur, l'imperatore inflessibile, conquistò la Cina con i suoi
quattro eredi - che momenti avranno vissuto insieme quei cinque
guerrieri! — preparandosi a ricreare un impero T'u-Küeh che
ricalcasse quello del VI secolo. Gengis Khan considerava lo scià di
Khiva e di Bukhara, il selgiuchide Mohammed, un semplice capo
turco islamizzato, ma quest'ultimo rifiutò sconsideratamente di
sottomettersi e di proteggere le vie carovaniere, sicché, nel 1220,
Samarcanda e Bukhara furono devastate. S'instaurò quindi il regime
del terrore mongolo, lo jasaq, l'interdizione. I generali del khan,
raggiunto Mohammed in fin di vita sulle rive del Caspio, riuscirono
infine a impadronirsi di tutto il territorio turco fino al Mar Nero. Nel
XIV secolo Timur ricompose l'unità del Turkestan. Alla lingua
persiana sostituì il turco ciagataico, dal nome del secondo figlio di
Gengis Khan. Compì massacri, costruì piramidi con i crani delle sue
vittime, risparmiando soltanto i poeti e i dervisci, che accolse alla sua
corte. Si dice che i suoi capelli fossero bianchi fin dall'infanzia e che
non avesse mai pianto. Zoppicava, eppure era tanto forte da poter
sopraffare l'eroe Rustam. Sopra ogni cosa amava la verità e
uccideva chiunque gli mentisse.
Nel XVI secolo i Timuridi tagiki furono estromessi dagli uzbeki
che, seminando il terrore, governarono il khanato di Khiva. Erano i
discendenti del figlio maggiore di Gengis Khan, Jöci, che aveva
regnato sul Kipčak, e di Uzbek Khan, l'ottavo e famoso khan
dell'Orda d'Oro.
Nel 1717 fu massacrata la spedizione inviata da Pietro il Grande
alla ricerca della via delle Indie. Gli emiri di Bukhara, a partire dal
1784 e fino alla loro scomparsa, appartenevano alla dinastia dei
Manqiti, originari delle montagne del Tagikistan.
I russi, al comando del generale Perovsk, nel 1839
cominciarono a infiltrarsi nel Turkestan. Taškent venne conquistata
nel 1865. Il generale Černjaev, alla testa di soli 3600 uomini,
sconfisse, nel 1866, 40 000 buharioti; Samarcanda fu presa e l'emiro
comperò la pace al prezzo di 1 875 000 franchi.
Nel 1920 si costituì la Repubblica di Faisula Khodjajev che,
diventato bolscevico, fondò con l'aiuto dei rossi la Repubblica
socialista sovietica dell'Uzbekistan. Ancora un'unione tra l'Asia e
l'Occidente: l'Occidente russo, questa volta, e non più macedone.
Quali ne saranno gli sviluppi?
Di casa in casa
Ora ho alcuni amici che ritrovo ogni giorno, dopo il loro lavoro,
alla grande čajkana di fronte al Registan. Là chiacchieriamo
sgranocchiando pistacchi e mandorle tostate di urjuk, piccole
albicocche.
Marussja è senza dubbio bellissima. Voleva diventare attrice del
cinema quando danzava a Leningrado, ma il suo viso delicato dagli
occhi color pervinca scuro era troppo minuto per lo schermo, o
almeno così immagino. Alta, slanciata, ha le larghe spalle un po'
curve, come scoraggiate. Vive solo per il suo camion. Con le mani
sottili e affusolate regge il volante otto, dieci, ore al giorno, senza
problemi, mentre i suoi compagni maschi spesso sono vinti dalla
fatica. Eppure, guidare un camion nel Turkestan non è certo uno
sport per signorine!
Talvolta l'accompagno; consegnamo nei kišlak della zona i
sacchi di grano prelevati dai mulini. Qui le cosiddette “strade” sono
piste con solchi così profondi da costringere Marussja a volteggi di
alta acrobazia sui bordi delle scarpate, ma ciò non turba il suo
sorriso incantato... A ogni istante temo che ci ribalteremo. Gli aryk di
irrigazione si diramano in mille rigagnoli che trasformano il suolo di
löss in uno stagno di melma vischiosa.
Negli stretti vicoli della città vecchia il maggior divertimento
consiste nel prendere le curve in velocità, senza però urtare contro
gli spigoli delle case. Per lasciarci passare i pedoni si infilano nei
vani delle porte. Il gioco può anche essere pericoloso poiché il
parandja attutisce i rumori impedendo talora alle donne di sentire il
nostro arrivo.
In caso di guasto Marussja dovrebbe riparare da sola il motore:
in realtà se ne occupano gli uomini della sua squadra, i quali - mi
pare di capire - sarebbero pronti a buttarsi nel fuoco per lei.
Una donna attraversa la strada e il nostro persiano, calvo sotto il
suo berretto ma con splendidi baffi neri, l'apostrofa urlandole:
«Oca!». Poi rivolto a me: «Ella, ho qualcosa per te», dice
sporgendomi delle noci con un biscotto.
Per i propri compagni Marussja tiene sempre qualche caramella
in tasca. Il suo salario è di centocinquanta rubli e sta preparando un
esame per diventare meccanico, lavoro che le consentirà di
guadagnare di più.
Alla mensa del mulino - zuppa di cavoli, patate alla paprica - la
mia amica mi presenta a un autista iraniano, Ruben. È un giovane di
bassa statura, con splendidi occhi dorati, ombreggiati da ciglia nere
e lunghe che si incurvano fino a sfiorare le sopracciglia. Vuole
assolutamente farci conoscere sua moglie e suo figlio.
Ed eccoci tutti e tre in cammino, a braccetto, sul largo
marciapiede del corso in discesa.
«Vedi», mi confida Marussja, «quando sono con i miei compagni
mi sento allegra, spensierata. È facile capirci, sono persone vive con
cui è bello stare insieme. Se qualcosa va male, evitano parole inutili,
ma si sostengono reciprocamente. Ieri, per esempio, Vanja ha offerto
un cartoccio di patate al persiano dicendogli: “È da tempo che i tuoi
marmocchi non giocano più alle biglie con questo genere di palline!”.
E Jan un momento fa scherzava: “Con la carne a dieci rubli la libbra,
sarà meglio deciderci a trasformare i nostri deretani in bistecche!”.
Sono concreti, franchi, ben diversi dalle donne con le loro continue
lamentele».
Passando davanti a un chiosco che vende birra mi permetto di
esprimere alcune perplessità quando me ne decantano
l'incomparabile qualità.
«Cinque bicchieri!», ordina il persiano.
Il liquido è dissetante, ma acquoso; costa un rublo al boccale,
che è enorme. Ruben si ostina a voler offrire un altro giro: siamo
costretti a sederci sul marciapiede per riprendere le forze.
A casa dell'armeno i miei ospiti, avendo saputo che forse mi
recherò a Merv, scrivono una lettera per il padre e il nonno che
vivono là e presso i quali dovrò assolutamente recarmi per portare
notizie di tutti loro.
La stanza è povera, minuscola, arredata all'europea, con
tendine bianche.
L'ebrea di Khudjum
Ogni giorno Marussja fa consegne alla fabbrica Khudjum; decido
così di accompagnarla per vedere come si produce la seta. Appena
viene aperto il portone, il caldo che si sprigiona da una stufa ci serra
la gola.
Davanti ai loro banchi, donne dalle mani rese molli e bianche
dall'acqua bollente fanno cuocere in un mastello i bozzoli giallastri,
sorta di fave galleggianti, che bisogna prendere dall'estremità giusta
per poterli dipanare. Vengono poi tirati su con una schiumaiola, e
altre operaie ne estraggono a sette per volta i filamenti che
formeranno il filo, da arrotolare in una matassa rigida e brillante.
Alcune donne hanno il capo coperto da un velo trasparente,
altre da un foulard intrecciato a mo' di turbante oppure dal berretto
tradizionale. Piccole trecce nere serpeggiano lungo tutte quelle
schiene, confondendosi con i lacci dei grandi grembiuli.
Le macchine hanno un marchio di origine italiana. La fabbrica,
costruita nel 1927, impiegava a quel tempo centoquarantaquattro
operaie, ora vi lavorano ottocentocinquanta donne emancipate. Al
primo piano sembra di passare in un viale i cui filari sono splendenti
matasse di seta greggia, bianche e giallo oro, che vengono
esaminate meticolosamente. Le operaie sono pagate a cottimo; le
matasse consegnate da ognuna di loro sono sottoposte alle
operazioni di torcitura: si eseguono quattrocento torsioni del filo, che
viene poi campionato. Il risultato è segnato su un registro: 11
significa troppo spesso, da 13 a 15 va bene.
Nella sala di filatura cerchiamo un'operaia che sia giovane e
simpatica e, soprattutto, disposta a invitarci a casa sua,
permettendoci di vedere come vive. Purtroppo sono quasi tutte
vecchie e brutte. Finalmente ne intravedo una giovane e chiedo alla
sorvegliante di condurmi da lei. E alta, indossa una camicetta scura
di velluto, ha un'abbondante capigliatura dall'attaccatura bassa, la
fronte larga, occhi oblunghi sormontati da sopracciglia ancora più
lunghe, il naso diritto. La ragazza mi sorride, destreggiandosi tra fili
invisibili.
«È un'ebrea, un'eccellente lavorante che fa parte di una
squadra straordinaria. Pensate che quest'anno abbiamo adempiuto il
112 per cento del Piano per la nostra fabbrica...».
Osservo che l'ebrea è la sola a trattenere tra le labbra le
estremità dei fili di seta, sicché, avendo le mani libere, lavora più in
fretta.
Aspettiamo la giovane donna all'uscita; mentre camminiamo al
suo fianco ne percepiamo l'inquietudine. Poiché non conosce il
russo ma soltanto il tagiko, cioè il parsik, l'antico persiano, per
discorrere dobbiamo aspettare di essere a casa sua dove una vicina
farà da interprete.
Intorno a un grande cortile rallegrato da qualche macchia di
verde si affacciano delle case nuove, sempre costruite con fango
essicato, a un solo piano, da dove pendono coperte o bucati stesi ad
asciugare.
La ragazza ebrea ha una stanza qui: sopra il pavimento un
kilim; su un semplice cassone le coperte sono nascoste da un
suzaneh, un ampio drappo ricamato a grandi motivi rossi e
tondeggianti. Nel corridoio un fornello, ed è tutto. A disagio, la nostra
ospite continua a non rispondere alle mie domande e infine mi
chiede spaventata: «Ho lavorato male? Devono essere scontenti di
me se hanno mandato qualcuno a investigare a casa mia».
Non riesco a distoglierla da tali cupi pensieri né a cancellare la
ruga che ora le segna la fronte.
L'armena che fuma il čilim
«Che tristezza! Il cielo mi preservi dal dover mai lavorare in una
fabbrica!», esclama Marussja quando usciamo dal maglificio.
La prego tuttavia di accompagnarmi ancora all'artel delle
ricamatrici e di non sorridere quando, per la centesima volta,
domanderò:
«Senza velo, sposata, analfabeta?».
La mia amica è libera dato che il camion è in panne e ora è in
riparazione, come peraltro ho visto, in un'autofficina. Non si tratterà
per caso di un guasto simulato? E Marussja non sarà un'agente
della Ghepeu, incaricata di sorvegliarmi? Non lo so: farò e dirò
comunque ciò che voglio.
La direttrice è energica, magra. Indossa un impermeabile grigio,
stretto in vita da una cintura e una sciarpa di mussola le ripara il
collo: ha mal di gola. Sul capo ha un fazzoletto bianco, annodato
sulla fronte. È una persona precisa, intelligente.
«All'inizio, nel 1929, eravamo in sette. Andavamo di casa in
casa a parlare con le donne, tutte abili ricamatrici. Ora, che abbiamo
sufficiente materia prima, vi sono duecentocinquanta donne che
lavorano in città e centocinquanta nei kišlak. La paga di una brava
operaia è di centoventi rubli, di dodici quella di chi viene soltanto per
avere la tessera del pane. Una camicia si confeziona in quattro
giorni. L'orario giornaliero delle donne che lavorano qui è di sette
ore; per le altre, quelle che ricamano a casa, non è possibile un
controllo».
Le domando se è uzbeca; vengo così a sapere che suo padre
era persiano. Naturalmente mi informo se portava il velo, ma questa
volta Marussja non sorride.
«Sì, fino al '27, contro la volontà di mio marito, che era
insegnante. Quando però ho capito che la mia ostinazione avrebbe
causato una rottura definitiva, ho obbedito».
«Continuano dunque a riproporsi drammi di famiglia per questo
motivo?».
«Certamente, occorre essere prudenti. La liberazione della
donna crea scontento nella coppia. Le donne anziane e che
guadagnano non sono toccate dal problema, ma per le giovani il
discorso è diverso: gli uomini si oppongono a che esse escano
senza velo. Abbiamo istituito un piccolo tribunale per dirimere queste
liti in famiglia. Bisogna far ragionare il marito, convincerlo a non
vedere il male ovunque. Soltanto l'istruzione riuscirà ad aprire gli
occhi agli uomini».
Dopo aver ammirato tovaglie, maglie, camicie, canovacci
ricamati secondo i motivi tradizionali del suzaneh, ci rechiamo a
visitare il negozio delle tjubeteika: sembra quasi di trovarsi da un
venditore di meloni: innumerevoli berretti a calotta, incastrati l'uno
dentro l'altro, sono allineati sugli scaffali. Il broccato, tagliato in
pezze, è ammonticchiato, pronto per essere cucito.
«Ho ordinato da Mosca», ci racconta l'armena, «due vagoni di
casule e di cotte da pope, che dovevo pagare all'arrivo; ma sono
sorte delle difficoltà poiché con il vecchio sistema di consegna al
consorzio, il pagamento avviene a lunghe scadenze. Ora infatti ho
problemi di denaro e molte operaie non ricevono il loro salario ormai
da due mesi, eccetto le russe che, non possedendo né una mucca
né un orto, non possono aspettare».
La direttrice si interrompe per fumare il suo čilim gorgogliante, la
pipa ad acqua con il cannello formato da un semplice tubo di latta
che viene passata di mano in mano.
Ridiamo nel vedere che sul fondo dei berretti appaiono, fissati
da un ricamo, cartoncini dipinti che riproducono testine di biondi
angioletti. La donna ci spiega che un tempo i russi si segnavano
davanti a quelle immagini, ma che ora quel che più conta tra le
montagne del Pamir è il copricapo in sé.
Le ricamatrici chiacchierano mentre lavorano, sembra che si
trovino qui per il loro piacere. Che atmosfera diversa da quella delle
due fabbriche precedenti!
«Le vecchie parlano meno e bevono anche meno tè, ma
ricamano assai meglio», dice sorridendo l'armena prima che ci
congediamo.
Questo non mi basta
Mentre mangiamo il plov nella veranda di una taverna locale, confido
a Marussja di non essere soddisfatta.
«Voglio entrare in contatto più diretto con le indigene, vivano
esse in campagna o in città. Mi piacerebbe trovare un villaggio dove
abitare e lavorare i campi assieme alle donne».
«Sergej ci aiuterà. E un po' noioso, ma pazienza. È un pittore ed
è vissuto per parecchi mesi in campagna; ora si occupa della
riorganizzazione del museo di Ulug-Beg. Nel cortile della madrasa il
famoso artista Benkov lavora a una tela di grande effetto, intitolata
La giornata dell'8 marzo in piazza Registan. A quella data cade la
festa dell'emancipazione femminile e in quell'occasione vengono
bruciati grandi mucchi di čador».
Sergej ci accompagna sulla sommità del minareto da dove si
gode una vista stupenda; Samarcanda, “la più bella città del mondo”,
è ai nostri piedi.
A est si allineano, bianche di neve, le vette delle catene
montuose. Sotto di noi il selciato del Registan è in gran parte divelto
poiché ne stanno abbassando il livello all'altezza originale; la folla
aspetta in coda l'autobus per la città russa e per la stazione; nei
caravanserragli ragliano gli asinelli, le cui sagome sono connaturate
al paesaggio del Turkestan come quella luce cristallina che non ha
eguali in nessun altro luogo della terra.
Laggiù, sulla nuda collina di Afrasiab, dietro la grande moschea
di Khazrat Khajzar dalle belle colonne in legno, ve ne è un'altra, di
dimensioni minori, con un semplice peristilio che mi ricorda il sobrio
tempio della Vittoria aptera sull'Acropoli.
Sergej è tanto turbato dalla presenza di Marussja da balbettare.
Deve essere meraviglioso riuscire a provare una così intensa
emozione! Mi defilo e vado a far visita alla direttrice dell'ufficio
femminile.
«Sì, la legge sovietica vieta di sposarsi prima dei sedici anni,
esige un certificato medico e non ammette che l'uomo contragga un
secondo matrimonio. Occorre tener ben presente che un tempo la
nascita di una bambina era meno apprezzata di quella di un cane,
mentre si faceva gran festa se veniva al mondo un figlio. E soltanto i
maschi erano battezzati.
«In città le ragazze si limitavano a cucire o a guardare la madre
lavorare e dovevano mettere il čador uno o due anni prima del
matrimonio. Non si insegnava loro a scrivere nel timore che
avessero contatti epistolari con uomini. Secondo la sharia, il
commento delle leggi, se una moglie non ubbidisce, il marito ha il
diritto di picchiarla. In campagna esse lavorano i campi senza
coprirsi il volto con il velo, la loro vita è più libera. Il kalim con cui si
comprava una moglie non doveva essere inferiore ai dieci dergamof,
cioè a cinque rubli-oro, che però erano interamente spesi per la festa
di nozze.
«Una vedova poteva risposarsi secondo i propri desideri; invece
presso i kirghizi ella era costretta a prendere come marito il cognato
affinché i suoi beni rimanessero in famiglia.
«Le donne non si recavano alla moschea, ma pregavano sulle
tombe e versavano denaro allo sceicco, il mullah superiore;
ignoravano qualsiasi cura medica e consultavano soltanto la falbin,
la donna sciamano che compiva esorcismi. È perciò facile
immaginare quanto diffuse fossero le malattie veneree: il lavoro da
compiere in ogni campo è dunque enorme. Un tempo all'ospedale di
Samarcanda vi era un'unica ostetrica. Oggi i nostri ospedali contano
diecimila letti, nel 1916 ne avevamo novecento».
La campagna di Samarcanda è un vero labirinto. Sergej ci
conduce di campo in campo, di sentiero in sentiero. Domandiamo a
un passante fin dove arrivano le rovine, a destra della strada. «Fin
dove arriva il grido...», risponde.
Bussiamo alla porta di legno di un čorni rabotnik, un lavorante
giornaliero, e sentiamo voci di donne che domandano chi siamo.
«Sono io, Sergej, l'amico di Mustafà. È in casa?».
Tutto tace.
Stanchi di aspettare decidiamo di andar via, ma in quel
momento la porta si apre su un cortiletto con al fondo una veranda,
divisa in due e riparata da tendoni di cotone. Entriamo nella parte
riservata agli uomini, dove Mustafà è coricato sul letto.
«Ho la febbre da due mesi, ma adesso va meglio. Sergej, solo
ora vieni a trovarmi, malgrado le tue promesse! Le donne non si
fidavano ad aprire non avendo capito chi fossero i visitatori».
«È con me una straniera che desidera rendersi conto di persona
di come vivono le donne e di quel che succede qui».
Una ragazzina porta il tè — due tazze per tutti e quattro — e un
po' di kišmiš, quella squisita uva passa, rosata e senza semi.
Mustafà trema, ma si siede ugualmente per fare gli onori di
casa.
«Capisco, certo; la tua amica non ha che da raggiungere le
donne qui accanto».
Nello spazio vicino alcuni bimbi giocano sulle coperte, una
donna fila in posizione accovacciata, nelle nicchie delle pareti sono
disposte le teiere; e poi, ancora, una culla, un baule. Non vi è
null'altro. Il forno è nel cortile.
Mi informo circa la malattia di Mustafà, rammaricandomi del suo
stato. Per capire dove ha dolore mi tocco la testa, il ventre, la
schiena, domandando se il tabib, il dottore, l'ha visitato.
«Sì, sì».
«E che cosa ha detto?».
«Tif».
È tifo! Bella notizia. E noi che abbiamo bevuto nella stessa
tazza!
Rifiuto gentilmente l'invito di Mustafà a trascorrere la notte nella
sua dimora: ho già visto tutto ciò che mi interessava.
Jan racconta
Marussja è occupata in una discussione sui magneti con Jan,
ispettore di motori d'autobus, che l'aiuta a prepararsi all'esame. Mi
ha confidato che con lui è possibile essere buoni compagni: si è
appena sposato, quindi non vi è pericolo di complicazioni
sentimentali fra loro.
«Jan, dovresti presentare Ella ai tuoi amici uzbeki che forse
potrebbero aiutarla a introdursi là dove vivono le donne. Questa
sera, però, raccontaci una storia di basmaci, che ci faccia
dimenticare la nostra paura del tifo».
Jan era un bambino solitario e ha imparato l'uzbeko prima del
russo. Il suo sguardo che cambia e si fissa nel vuoto lo fa
rassomigliare a uno scandinavo.
«Volete che vi narri di un cavallo?».
Procederà nel suo racconto con frasi brevi, secche, neutre,
inframmezzate di pause, dandomi l'impressione di un topo che
rosicchia a piccoli morsi il suo bottino.
«Allora, siamo in una casa contadina, circondata da una tenuta.
Ci vivono due giovani, un maschio e una femmina, con la madre e il
patrigno. La madre è una donna senza carattere e, contrariamente
all'uso, non può lavorare; ha paura del marito egoista. La ragazza,
Anna Gul, ha mani candide e non ama la fatica. Litiga spesso con il
padre che pretende di sapere tutto; ha occhi grigi, grandi e
pensierosi, e sopracciglia all'insù.
«Nessuno si occupa del figlio, Gul Murad, che è di carattere
schivo; se qualcuno lo bistratta non reagisce, ma non dimentica. A
lui toccano i lavori più duri e deve anche custodire il gregge.
Conosce la montagna, sa individuare le orme ed è abile a catturare
gli uccelli. Cavalca bene e può fare quello che vuole; la madre ama
soltanto la figlia.
«Con il denaro degli uccelli catturati il ragazzo compra un
agnellino e lo ingrassa, tenendolo però nascosto presso un vicino
nel timore che i genitori glielo prendano. Acquista infine un puledro.
Murad è giovane e si appassiona al suo bel cavallo di sangue arabo,
Hindukush. Da principio nessuno nota l'animale, ma appena il
patrigno se ne accorge proibisce al ragazzo di dargli da mangiare
l'orzo. Allora quest'ultimo lo nutre con il proprio pane.
«Nel cortile di fronte alle stanze riservate alle donne sono situati
il granaio di un kulak usuraio e il recinto coperto per proteggere il
bestiame in inverno. Passando dinanzi alla porta d'ingresso è facile
capire che si tratta di una casa abbastanza agiata. Vi è una camera
per gli ospiti con tappeti, suzaneh, cuscini e sanduk, ovvero bauli. Lo
straniero che giunge da lontano può fermarsi con il suo cavallo. Il
figlio si occupa di servire i pasti; i poveri lavoranti non osano
avventurarsi sui tappeti e, seduti vicino alla porta, mangiano i resti.
«Nel cortile delle donne il sole splende sul karagač, l'olmo
dell'Asia, e tutt'intorno alla vasca dell'acqua ci sono fiori, frutti, uve; si
suona, si beve il tè, si sussurrano sciocchezze. Quando arriva il
patrigno cade il silenzio, si possono sentire le mosche volare. Egli
guarda con cattiveria la figlia, che subito si allontana. La moglie gli
leva il khalat, le scarpe, lava le sue mani, gli offre del cibo e poi la
sua pipa ad acqua.
«Di fronte vive quella volpe di usuraio con il figlio Kakim, che è
invidioso di Gul Murad.
«Giunge il giorno del kurban, la festa durante la quale i cavalieri
si disputano un trofeo rappresentato da una capra. I due ragazzi
sono nella mischia, Kakim riesce a impossessarsi della capra ma il
suo cavallo è mingherlino e Gul Murad gli strappa la preda e vince.
L'altro non sa darsi pace e ottiene dal padre la promessa di
comperargli Hindukush.
«Nell'aia Gul Murad si diverte con il suo cavallo che corre libero;
il ragazzo lo chiama: “Hindu, Hindu!”. Ha dimenticato di chiudere il
portone del cortile: il padre arriva in groppa a una giumenta e Hindu
vorrebbe giocare con lei.
«Nel trambusto l'uomo cade, il suo bianco turbante rotola a terra
e si sporca; quando si rialza è sporca anche la manica del suo abito.
Egli prende il frustino e colpisce il giovane. Gul Murad riesce a
riacciuffare il suo cavallo. A quel punto il padre afferra lo scudiscio e
frusta il ragazzo che sta legando Hindu e la cavalla, chiude la porta e
raccoglie il turbante: ormai ha perso la testa e si accanisce contro il
figlio. Le donne gridano, la madre piange.
«Gul Murad stringe i denti per il dolore. Il subdolo usuraio, che
ha visto tutto, va dal padre e gli dice: “Tuo figlio custodisce male il
gregge; dà tutto l'orzo al suo cavallo. Vendimi quella bestia, te la
pagherò bene”.
«Il padre ordina che gli sia portato il cavallo. I lavoranti sono
affezionati a Gul Murad che, scambiato un segno d'intesa con il
palafreniere, agguanta il frustino gridando: “Il cavallo è mio, per
prendermelo dovrete passare sul mio corpo!”. E cogliendo tutti di
sorpresa, salta in sella, frusta sia il padre sia l'usuraio e poi fugge in
montagna.
«Diventato abrek, vagabondo, si unisce a un gruppo di ribelli.
Diventa famoso. Organizza una spedizione contro il proprio villaggio,
tramortisce a forza di botte Kakim dicendogli: “Non avrai neppure gli
zoccoli del cavallo”.
«Talvolta soccorre i poveri. La madre è molto infelice e prega il
marito di far ritornare Gul Murad, ma le sue suppliche sono inutili.
L'uomo organizza sempre cacce al fagiano, a cui partecipa il suo
amico Bala Beg che spera di incontrare la graziosa Anna Gul che
vorrebbe sposare. Ma ella lo detesta e supplica la madre di impedire
quel matrimonio.
«Siamo agli inizi della rivoluzione, durante le guerre civili. Nel
villaggio tutti temono una banda di basmaci vicini, ai quali Gul Murad
e i suoi compagni hanno rubato il bestiame. Per vendicarsi i basmaci
devastano il villaggio e catturano il miglior amico di Gul Murad.
Quest'ultimo riesce a liberarlo, ma riceve da uno sconosciuto una
coltellata alla caviglia. Indebolito per la ferita e reggendosi a fatica
sul cavallo, riesce nondimeno a ricondurre le bestie al villaggio con
grande gioia dei proprietari. La madre scongiura il figlio di rimanere,
ma il giovane acconsente solo quando il padre si scusa,
ammettendo i propri torti.
«Finalmente Gul Murad può riposarsi; i suoi compagni invece
ripartono.
«Kakim, che ha visto tutto, incita i rappresentanti del potere a
perquisire la casa e il giovane è di nuovo costretto a scappare,
senza armi né cavallo. Prostrato dalla fatica, si nasconde in una tana
di sciacallo mentre Kakim si impossessa del cavallo gridando alla
folla: “Ho Hindukush, il mio scopo è raggiunto”. Ma l'animale,
spaventato da un cane, lo disarciona e scappa.
«È notte. Lo sciacallo è inquieto, vuole uscire dalla tana, attratto
dall'odore di sangue fresco. Gul Murad vede i suoi occhi verdi
brillare minacciosi: nonostante la ferita riesce ancora a lottare e
quasi lo uccide con un coltello. Poi, stremato, esce dalla tana con la
bestia e si trascina sulle alture della montagna dove il suo cavallo
sta brucando tranquillo con la sua sella più bella sul dorso. Il giovane
lo chiama e deve farlo inginocchiare per poterlo montare. Ritornando
al villaggio, lungo il cammino passa davanti alla casa di una donna
sciamano che venendogli incontro di corsa spaventa il cavallo. Lo
sciacallo cade lanciando un grido lungo e lamentoso. Gul Murad
cerca di riprenderlo malgrado i consigli della donna che gli dice di
lasciarlo perdere perché è una bestia malvagia. Il giovane non
ascolta i suoi consigli, finisce lo sciacallo e lo squarta. La
mezzanotte è passata, la luna rischiara la neve, uno sciacallo ulula
lontano. Si ode un latrato e una vacca muggire. Gul Murad lega il
suo amato Hindu, lo dissella, lo copre per proteggerlo dal grande
freddo. È a casa sua. I due fratelli dormono al pianterreno, i genitori
al piano superiore. Si sente un tramestio dinanzi al portone. Kakim
conosce la disposizione della casa, scavalca la siepe e fa strada ai
basmaci guidati da Bala Beg. Sparano sulla porta. In un attimo i
servi sono legati. Kakim promette a Bala Beg di consegnargli la
fanciulla, per sé terrà Hindukush. I due giovani si rifugiano nella
camera dei genitori dove vi è un passaggio celato da un baule.
«La madre esorta Anna Gul a buttarsi da quel buco: “Avvenga
quel che deve essere!”, e la fanciulla cade sulla neve in camicia da
notte. Gul Murad spinge la madre a seguire la sorella e la regge per
le mani più a lungo che può. È poi il turno del padre, a cui dice: “Tu
andrai dal mio amico”. Kakim è passato dalla finestra e ha appiccato
il fuoco ai parati per vederci meglio, ma gli altri non osano andare
avanti nel timore che Gul Murad sia armato. Egli si è nascosto
aspettando che tutti siano andati via. Al mattino ritorna: la casa è
devastata, distrutta, il foraggio bruciato, i servi legati mani e piedi.
Ecco però che una alla volta riappaiono le bestie: un bue, un asino,
una mucca e il suo vitellino. Erano troppo ben nutriti per allontanarsi.
Ma Hindu... A terra giace una pastoia, l'hanno fatta saltare. Sui
campi, dove il cavallo ha cercato di liberarsi, spiccano macchie di
sangue. Uno zoccolio: è Hindukush che ritorna, cade e muore!
«Gul Murad piange disperato, non vuole che il suo cavallo sia
squartato, deve essere seppellito. Vende tutto quanto è rimasto e
porta ai suoi i vestiti e i gioielli che è riuscito a salvare. La sorella
ama un giovane e parte con lui. Gul Murad, dopo aver lasciato la
madre in un luogo sicuro, raggiunge il suo gruppo di banditi.
«Il potere è ora in mano ai soviet, i banditi diventano partigiani e
collaborano a liquidare i bianchi. Bala Beg è catturato e consegnato
alle autorità, ma esse non permettono a Gul Murad di tagliargli naso
e orecchie. Bala Beg implora la grazia e, privato dell'oppio,
impazzisce. A seguito di uno scontro ad arma da fuoco viene
catturato anche Kakim, che chiede pietà, ma Gul Murad non lo lascia
scappare e ordina che gli vengano mozzati i piedi. “Ora, monta pure
Hindukush”, lo schernisce. Poco dopo Kakim muore di emorragia. La
storia finisce così».
«Ma noi vogliamo sapere che cosa è capitato in seguito a Gul
Murad».
«Non essendo istruito diventa komsomol, lavora giorno e notte e
può così aiutare gli altri nel loro apprendistato...».
Lungo silenzio.
Jan ritorna alla realtà e guarda Marussja.
«Vi è piaciuta la mia storia?».
«Non male, forse troppo lunga».
Ferito da questa risposta, giura che non ne racconterà più e si
allontana.
«Gli è saltata la mosca al naso, come sono suscettibili gli
uomini!», commenta Marussja.
«Credo che fosse turbato: per vie traverse ci ha narrato la storia
della sua vita».
Ma la mia amica non pensa già più a Jan, tutta presa da una
nuova idea.
«Ho trovato! Riza, il venditore di burro, ci aiuterà; lui conosce
tutta Samarcanda».
Riza
Che personaggio sorprendente! Sa tutto di tutti, riesce ad
abbindolare chiunque, chiacchiera di continuo, e, anche se è ormai
brizzolato, non si lascia estorcere un solo copeco da chicchessia.
Più volte ci ha dato appuntamento per condurci dalle figlie, ma
all'ultimo momento ha sempre trovato una scusa per rimandare.
Andiamo da lui.
«Allora Riza, ci prendi in giro? Abbiamo bevuto quattro intere
teiere aspettandoti».
«Un attimo ancora, il burro è quasi pronto».
Con le maniche rimboccate gira con la mano chiusa a pugno la
spessa panna contenuta in un mastello che scalda di tanto in tanto
sul fornello. Prepara poi un po' di blini, deliziose frittelle a base di
latticello che mangiamo su un angolo del tavolo. Vi è un'unica
stanza, buia ma pulita.
Pretende quattro rubli per ogni libbra di quel burro acquoso.
«Devi essere ben ricco con tutto questo burro. Che te ne fai del
tuo denaro?».
«Se si usa la testa, in poco tempo si può diventare milionari.
Prima della rivoluzione ero uno degli uomini più ricchi della città. Mi
capitava di comprare mille pecore senza avere di che pagarle e di
rivenderle nel medesimo giorno con un buon profitto. Quando
lavoravo alla cooperativa i contadini serbavano per me tutto il kišmiš
perché sapevo parlare con loro, mi fidavo del peso dei loro sacchi.
Quando arrivavano gli altri acquirenti, assai più diffidenti di me, non
trovavano più nulla».
«Riza, si fa sera, è troppo tardi per andare a trovare le tue figlie.
Se non sbaglio, eri intenzionato a condurci in un kišlak».
Mentre parliamo Riza si rasa, distendendo con le dita la pelle
rugosa. Entra una giovane donna, potrebbe essere una russa; si
muove come fosse a casa propria. Quel brigante ha forse ripreso
moglie? Piccola, i capelli raccolti in uno chignon piatto, la nuova
arrivata — che è una georgiana — lavora come apprendista
fotografa. Con voce nasale esclama: «Mi devo sbrigare se voglio
arrivare in tempo per lo spettacolo delle sette. Riza, dammi due rubli,
proiettano un film intitolato Snaiper».
L'ho visto, è una storia di spionaggio ambientata durante la
guerra mondiale.
«Non se ne parla neppure, cara ragazza, oggi come ieri». La
piccola se ne va e noi canzoniamo Riza, felicitandoci con lui della
sua buona sorte.
«Sono loro che mi corrono appresso. Di quella donna, per
esempio, è da due anni che cerco di sbarazzarmi: la mando a quel
paese, non le do un soldo, eppure è sempre qui. Non mi interessa
per nulla. Al contrario voi, Ella, siete proprio la persona che fa per
me. Avete riflettuto sulla mia proposta?».
Scoppiamo a ridere. Già l'altro ieri Riza aveva dichiarato di
volermi sposare, e io ero convinta che scherzasse.
«Ma perché no? Ella, pensateci bene: potrete studiare il paese
a vostro piacimento, non avrete nulla da fare e sarete anche nutrita.
Se desidererete visitare Bukhara, città che conosco assai bene, vi
farò da guida».
Gli prometto che ci rifletterò, fermamente decisa a non
scoraggiarlo prima di aver ottenuto da lui ciò che desidero.
«Riza, devi accompagnarci al caffè armeno, vorrei che Ella
ascoltasse la musica indigena».
A dire il vero, ci siamo già andate da sole, ma siamo
determinate a far sì che Riza metta mano al portafoglio.
«Forse sarai così galante da regalare a Ella questo pezzo di
burro».
«Questo poi no! Mezza libbra vale sette rubli!».
Nella grande taverna gremita di clienti vi saranno al massimo
cinque o sei donne, nessuna uzbeka. Seduti a tavoli coperti da
incerate si beve birra o vodka; davanti alla porta arrostiscono pezzi
di pecora infilzati in spiedini di ferro. Frastuono, fumo; orchestra con
strumenti a corda dai suoni flebili, stridenti, monotoni, le cui continue
variazioni di ritmo sono il solo segno dell'evolversi di un'emozione; al
confronto le nostre ricche frasi melodiche sembrano orgiastiche.
Canti persiani, danze uzbeke.
Quattro avventori hanno una rosa all'altezza della tempia,
infilata tra il berretto e il cranio rasato. Due “compagni camerieri”
trasportano, reggendolo sotto le braccia, un uomo barcollante per
depositarlo sul marciapiede. Un altro ubriaco è scivolato a terra,
imbrattandosi con il proprio vomito.
Ma neppure tali spettacoli riescono a distogliermi dal piacere di
ascoltare il baradan, grande tamburo le cui cupe e ricche sonorità
formano la trama musicale. Il baradan è percosso da un uomo
imponente e barbuto che accompagna i suoi movimenti con una
mimica assai espressiva.
Prima di suonare si rimbocca la manica liberando il polso
nervoso: ha le mani lunghe e scure. Quindi inumidisce il pollice che
appoggerà contro la cassa del tamburo. Ora le dita percuotono
rapide e precise la pelle tesa seguendo una loro cadenza,
demoltiplicata dal braccio e ancor più semplificata dal busto:
movimenti che si articolano in triplice armonia. Al momento di un
crescendo il ginocchio imprime un quarto martellamento; con un
gesto ampio l'uomo fa oscillare lo strumento dagli anelli di ferro,
come per cullarlo appassionatamente. A Mosca avevo assistito a
uno spettacolo dove danzava Tamara Khanum: quando la musica si
alzava a tale sonorità ella si immobilizzava, irrigidendo le spalle, e
con il capo eretto, ornato di mille trecce, segnava il tempo con
movimenti precisi del mento. Riza mi parla di un villaggio in
prossimità di Khiva dove vivono soltanto donne, poiché gli uomini
sono stati tutti giustiziati. Mi ci condurrà, a patto però che
acconsenta alla sua proposta di matrimonio. Per il momento, è molto
irritato perché abbiamo ordinato costosi šašlik accompagnati da
vodka.
Recandoci da Tula, la figlia minore di Riza, incrociamo un
nugolo di uzbeki che fanno a gara per portare a turno sulle spalle
una barella. Il sellaio abbandona il suo lavoro per conquistare anche
lui i suoi dieci metri, e poi ritorna soddisfatto. Sulla barella è steso un
lungo rettangolo di panno blu scuro. È un feretro: compie una buona
azione ogni musulmano che aiuta a trasportare il morto verso la sua
ultima dimora.
Tula non ha l'aria molto amabile: testa grande, ereditata dal
padre, fronte decisa sotto i capelli in disordine trattenuti da una
fascia nera, naso robusto e ben marcato; il cappotto nero, infilato
sopra una camicia bianca, larga e sgualcita, nasconde stivali
consunti.
Nel cortile, sotto una tettoia, il forno ovale di terra fuma
leggermente; nella sua gola annerita stanno dorandosi le lipioška.
Secondo un detto uzbeko «benedetti i visitatori che arrivano al
momento della cottura».
Mentre stende un košmu per noi nel cortile, Tula risponde
appena al padre; poi ci offre delle mele.
No, non ha smesso di portare il čador.
No, non le interessa saper leggere, neppure il cinema la tenta.
Non desidera parlare di suo marito, ignora che cosa egli faccia.
Infine si rasserena guardandomi giocare con il figlio nella stanza
buia dove sono entrata, coperta di tappeti. Il piccolo, tutto fasciato,
sorride nella sua culla di legno scolpito. Sulla grande sbarra che la
sovrasta sono disposte a tendina due pesanti coperte. Il bimbo si
diverte con una collana di palline multicolori sospesa all'altezza del
suo naso.
Tula lo allatta senza alzarlo, accovacciata lì accanto e con il
braccio appoggiato sulla traversa. Poi riassetta la culla: al centro del
materasso e sul fondo di legno è stato praticato un foro sotto il quale
si trova un vaso in terraglia con della cenere. Finalmente capisco
l'utilizzo di quei piccoli oggetti di legno che ho visto fabbricare a
centinaia dai falegnami: sono condotti — a forma di pipa per i
maschi, di calice per le femmine — per dirigere l'urina dove si
conviene.
Mentre ci congediamo una tzigana entra a mendicare: la sua
faccia scontrosa è incorniciata da uno scialle rosso, bordato di
frange. Ne vivono molte nel paese; l'altro giorno, nella città russa,
una di loro, bruna e splendida, leggeva i tarocchi per un rublo a due
piccole russe bionde dall'espressione ansiosa.
Offrendo una lipioška alla mendicante, Tula dice: «Sai, vorrei
anch'io potermi permettere uno scialle bello come il tuo!».
Molti uzbeki sono ancora in campagna, dove si stabiliscono
durante l'estate. Djura, la figlia maggiore di Riza, è nel suo giardino,
seduta alla turca sotto un alto peristilio dalle colonne di legno
scolpito. Nel cortile giocano tre bambini all'ombra di un salice, contro
il cui tronco si sfrega una mucca.
Djura è paffuta, porta un gran numero di braccialetti, pantaloni di
seta, un nastro nero attorno al capo. Ci invita ad accomodarci al
fresco nella stanza superiore, i cui unici ornamenti sono costituiti da
tappeti scuri: è dunque più facile ammirarne pienamente la bellezza.
Nei muri, le consuete nicchie simmetriche contengono teiere,
specchi, canovacci, coperte. Il piccolo tavolo del saundal ricopre la
fossa del pavimento destinata alle braci; in un angolo si cela il buco
quadrato per lo scolo dell'acqua.
Djura ci serve delle focaccine fritte senza però né sedersi né
mangiare in nostra presenza.
Non appena si apre la porta, le vicine accorrono per scrutarci
dall'altro lato del corridoio.
Al pari della sorella, Djura non è coinvolta dal modernismo
incombente, il quale non riesce ad oltrepassare quel passaggio a
gomito attraverso cui si accede a ogni cortile. Si lamenta dell'alto
costo della farina e del kišmiš, vero pane quotidiano degli indigeni.
Forse, quando i suoi figli andranno a scuola, capirà finalmente che, a
sua insaputa, la vita è cambiata.
Andando via, lancio un'occhiata in direzione delle vicine
divertite: in mezzo a loro scorgo una vecchia che fuma il čilim e una
giovane ricamatrice.
Nel kišlak
Incontro il bel Jan dagli occhi azzurri che mi chiede se desidero
ancora andare in un kišlak a vedere lavorare gli uomini e i bachi da
seta, e dove potrò salire su un cammello.
«Appuntamento per questa sera alle sette. Andremo a casa di
un mio amico. Sarà certo meglio che seguire Riza in qualche
villaggio sconosciuto».
Alle nove, quando ormai Marušia e io abbiamo perso ogni
speranza, vediamo arrivare Jan in compagnia di due uzbeki —
riconoscibili dalle loro rassicuranti teste rotonde - vestiti con giacche
di cuoio e entrambi muniti di una di quelle enormi bottiglie di birra da
quattro litri. Preoccupate, aggrottiamo la fronte.
«Che cosa significa, vi preparate a una grande bevuta?».
«Non abbiate timore, Murat e il suo amico sono del tutto
affidabili, potrete dormire sonni tranquilli. Solo un po' di birra, quel
tanto che basta per essere allegri».
Jan ferma due isvoščik che ci conducono per la campagna a
trotto vivace e al suono di grandi schiocchi di frusta.
«Murat, è lontana casa tua?».
«No, apa», risponde, usando l'appellativo di “sorella”,
comunemente dato alle donne. «Giusto il tempo di bere due teiere».
Ignoro dove ci stiamo dirigendo, ma il dado è tratto: nella notte,
per cammini sconosciuti, quando le vetture saranno licenziate, non vi
sarà più ritorno possibile.
Polvere profonda sulla strada, un sentiero nella falesia, e poi
una gradinata di legno, alcuni pioli, una terrazza e infine la porta.
Entriamo in una grande stanza: lampada a petrolio, cuscini, tappeti.
Una ragazza, la sorella di Murat, porta il tè, qualche uovo sodo e un
vassoio di kišmiš. È troppo tardi per visitare il resto della casa.
Jan è taciturno; non ha voglia di raccontarmi come si svolge un
matrimonio uzbeko. Marussja è di cattivo umore e in poche parole mi
confida: «Jan ha rovinato la nostra amicizia confessandomi che da
sei mesi non pensa che a me. Fino a oggi era sempre riuscito a
dissimulare il suo sguardo implorante e io non sospettavo nulla».
Conosco l'atteggiamento della mia amica in questo genere di
situazioni. Pur amando gli uomini e la loro compagnia, quando
diventano supplichevoli Marussja li detesta a tal punto da non
tollerare più il minimo contatto. A questo riguardo era stata molto
chiara con il suo fidanzato, che però aveva voluto sposarla
ugualmente pur di viverle accanto.
«Il tuo affascinante marito manca forse di certe attrattive,
Marussja, ma se neanche Jan, così bello, suscita in te qualche
desiderio, temo che con il tempo il tuo cuore diventerà duro come
una pietra. Senza dubbio hai posto il tuo ideale tanto in alto in modo
da non rischiare che la tua serenità sia scalfita da una qualsiasi
delusione».
Marussja e Jan discutono.
Da parte mia, sento una grande stanchezza dopo questa
giornata così intensa. Appena fuori città, sulla strada per Agalik, ho
visto nel cortile di una fattoria gli indigeni cuocere i bozzoli in grandi
paioli; i bachi morti emanavano un fetore atroce evocandomi ricordi
di greti dove imputridivano al sole banchi di pesci, infestati dalle
mosche.
Mi ero poi recata a visitare, all'estremità di Afrasiab, il mausoleo
di Hodja Danjar, immenso cilindro di pietra dal diametro di cinque o
sei metri, affiancato dal bunčuk, il santo vessillo.
La leggenda narra che il santo gigante continua a crescere nella
sua tomba.
Proseguendo la mia passeggiata, mi ero bagnata nel grande
acquedotto ombreggiato di salici prima di arrivare all'osservatorio di
Ulug-Beg. Questo successore di Timur aveva individuato con
esattezza, nel XV secolo, il meridiano di Samarcanda e stabilito tutti i
calendari del Medioevo: là egli si recava per scrutare il cielo. In una
profonda trincea scavata ad arco una rotaia graduata sosteneva il
sedile mobile, munito di cannocchiale.
I ragazzi dormono, Jan e Marussja continuano a discutere
animatamente.
Triste risveglio. Siamo soli, è tardi, tutti sono usciti. I miei due
amici non si rivolgono più la parola. Decidiamo così di rientrare il più
presto possibile. Dobbiamo lasciare la campagna, i campi, i bachi da
seta, i cammelli, i tanti piccoli animali...
Dalla cima della falesia vediamo la natura intorno divenire
cristallina alla luce incomparabile del mattino del Turkestan. A
migliaia di chilometri dalle perturbazioni oceaniche, l'atmosfera è di
una trasparenza stupefacente. Lascio la stanza che mi ha ospitata e
guardo di sfuggita nel cortile. Una vecchia ha appeso ad asciugare il
materasso e la biancheria della culla: anche da qui se ne
distinguono i fori. Una pecora bela.
«Ella, venite con me a visitare la casa vicina», mi propone Jan,
«è disabitata da due anni, ma potrà interessarvi ugualmente».
Pareti e pavimenti spogli, una finestra ancora intatta; una feritoia
nera, simile ad una buca delle lettere, si apre ai piedi del muro
attirando la mia attenzione.
Jan coglie il mio sguardo: «È proprio lì che bisogna guardare, a
quello strano anfratto è legata una triste storia. In questa casa viveva
una coppia; il marito amava sopra ogni cosa la sua sposa e il suo
cavallo, che era tanto veloce da vincere ogni gara procurando loro
premi e regali. All'inizio non ebbero figli ma poi nacque una bimba.
Al tabib piaceva molto quel cavallo e avrebbe voluto comprarlo. Offrì,
invano, molto denaro. La figlia crebbe felice. Tutto procedeva bene.
«Un brutto giorno, però, appare sul collo della bimba una
macchia bianca. Lebbra? Se così fosse la famiglia dovrebbe
abbandonare il villaggio. Chiamano il barbuto tabib perché guardi la
figlia e dica che malattia ha, ma egli fa il gesto di scappare. Il padre
lo trattiene: “Dimmi che cosa vuoi e te la darò”. “Regalami il tuo
cavallo e non aprirò bocca”, risponde quello.
«I genitori nascosero la bimba di tre anni in quella sorta di
cantina affinché nessuno la vedesse. L'infelice madre nutriva la figlia
di notte, al riparo da sguardi indiscreti. La accarezzava e poi si
strofinava bene il viso sperando di ammalarsi anche lei, ma nulla
accadde. La piccola piangeva, voleva uscire, stare accanto alla
madre: non era possibile, doveva tacere.
«Trascorsero così quindici anni e arrivò la rivoluzione. Il villaggio
venne a conoscenza del fatto, di cui già da tempo si mormorava. I
komsomol, decisi ad appurare la verità, perquisirono la casa. La
povera infelice uscì allora a gattoni: era tutta rugosa, aveva paura di
tutti, come una bestia selvatica. Non sapeva parlare. Il padre fu
costretto a raccontare ogni cosa. Un medico russo venne a visitarla:
non era lebbra, soltanto un foruncolo. Fu chiamato il tabib dalla
grande barba per interrogarlo. Il padre, però, non ebbe bisogno di
spiegazioni; prese il coltello e lo uccise».
Ritorniamo passando tra cespugli luccicanti di rugiada. Ripenso
a quel terribile racconto convincendomi sempre più che in questo
paese si vive ancora in pieno Medioevo: occorre non dimenticarlo
mai. Siamo soltanto nel 1311, con quaranta anni di ritardo sul
calendario arabo dell'egira. A ogni passo il secolo XIV si erge di
fronte al XX; il diritto del più forte prevale tuttora e la nozione di
giustizia deve essere creata dal nulla. A ogni passo la forza
dell'abitudine si oppone alla forza della volontà che i soviet
vorrebbero instaurare.
Il processo ai “basmaci”
Sono svegliata da un insolito rumore: zoccoli di cavallo
risuonano sul lastricato della mia madrasa... Mi precipito a vedere
che cosa succede. Alcuni militari, armati e a cavallo, sorvegliano
l'installazione di numerosi sedili davanti all'iwan di ingresso. È giunto
il giorno tanto atteso della conclusione del processo ai basmaci,
incominciato parecchi mesi fa.
Appollaiata in instabile equilibrio sul davanzale della mia finestra
vorrei fotografare dall'alto il cortile, invaso a poco a poco da una
marea di gente. Mi piacerebbe trovare un'altra inquadratura, ma
temo che mi sequestrino di nuovo l'apparecchio. Eppure so bene
che alla fine non resisterò e salirò sul tetto, come d'altronde sono
solita fare ogni mattina. Ma no... Il corridoio in fondo al cortile è
sbarrato, sorvegliato a vista da un militare. Decido di rischiare e
avanzo fino al podio dove tre giudici chiacchierano in attesa degli
accusati. Mostro loro la macchina fotografica dicendo che ho
l'autorizzazione. Alla mia richiesta di poter rimanere lì accanto,
esitano ma poi acconsentono. Uno di loro, con un impermeabile
grigio, ha un berretto di tela bianca sotto la cui visiera si intravede un
naso aquilino da armeno. Gli altri portano la tjubeteika e il čapan
uzbeko a righe verdi e viola. Dietro di loro, al fondo della nicchia,
sono esposti i ritratti abbinati di Marx e di Lenin. Dalla volta in
mattoni smaltati pende uno stendardo di velluto granata, su cui è
ricamata l'immagine di un uomo che, in piedi davanti a un banco,
manovra la bilancia della giustizia dinanzi a uno spettatore dall'aria
interessata- Sul pavimento, sotto la grande ogiva, fa bella mostra di
sé un'enorme testa di Stalin sullo sfondo di un cielo azzurro, un
fotomontaggio vecchio di cinque anni.
Al centro del podio ricoperto da un grande tappeto è seduto il
procuratore, avvolto nel suo mantello nero; è magro e porta un tocco
di pelliccia anch'esso nero. Su un angolo del tavolo coperto da un
drappo di cotone rosso è appoggiato il busto in bronzo di Lenin, i cui
rilievi risaltano sotto la luce bianca del giorno piovoso. Ha
sopracciglia corrugate e fronte bombata; il procuratore gli assomiglia
stranamente: lo sguardo indagatore, i baffi cascanti, la barbetta rada
sono i medesimi.
Ai piedi del podio numerosi cancellieri sono intenti a scrivere, in
persiano, sui loro tavoli ricoperti di broccato rosa e oro.
Scortati, arrivano gli accusati. Sono una quarantina, tutti
indigeni, ben avvolti nei loro mantelli imbottiti, variopinti e pieni di
toppe. Un uomo a piedi nudi tiene le mani incrociate sul suo čapan
ricamato a grandi rose e posa dinanzi a sé un bollitore.
«Ecco Amrista, il loro capo», mi dice il mio vicino.
Mi faccio indicare chi è.
«Il più basso, quello con il copricapo verde».
Spalle cascanti, testa rotonda e scheletrica, occhi infossati,
bocca sottile, è abbigliato in modo stravagante e scherza con la folla.
«È già stato imprigionato dodici volte», continua il mio vicino che
sfoggia uno splendido, seppur consunto, turbante, «ma è sempre
riuscito a scappare, beffando la polizia. “Uccidetemi pure, la cosa mi
è indifferente. Altri venti prenderanno il mio posto”, è solito dir loro».
Dietro la corda che delimita lo spazio riservato agli accusati è
schierata una fila di donne, infagottate in parandja bianchi, chiusi dal
čador di crine nero. Presenze ansiose e immobili, sono le mogli o le
madri degli accusati. I figli giocano noncuranti a terra. Dietro a quelle
tristi figure si alza un muro di teste maschili, sfaccendati che
osservano la scena, vero campionario di tutte le mescolanze umane
dell'Asia: da chi ha tratti quasi giapponesi al baskiro biondo nelle cui
vene scorre anche sangue slavo.
Due superbi cani poliziotto sono tenuti al guinzaglio da un
militare.
Un giudice legge con voce monotona e quasi incomprensibile
nomi, cognomi e dati personali di ciascuno, prima in uzbeko e poi in
russo.
A sinistra di Amrista, un vecchio minuto con la barba bianca e
corta, il magro collo teso nello sforzo di ascoltare, straluna immensi
occhi azzurri: lo manderanno sul serio al buon Dio senza
confessione?
«Quello grosso, il più vicino a noi, è un sarto; ha già ammazzato
otto persone».
Durante il giorno, ognuno di loro svolgeva il proprio mestiere:
orafo, bracciante, spazzino, caffettiere; ma alla sera si riunivano,
mettevano in discussione le nuove leggi, criticavano il governo,
organizzavano razzie contro le fattorie controllate dai bolscevichi,
preparavano sabotaggi.
Quello che so del loro passato
Con il nome di basmaci— che significa “ladri” o “banditi” — vengono
chiamati tutti i nemici dei soviet, i briganti usciti di prigione all'inizio
della rivoluzione, i controrivoluzionari nazionalisti, sostenitori
dell'emiro spodestato di Bukhara Seid Mir Alim Khan, oppure i russi
bianchi, ex zaristi.
Negli ambienti non sovietici questa parola indica un ribelle
nazionalista. L'accanita resistenza che essi opposero obbligò per
molto tempo le truppe rosse a schierare grandi contingenti nel
Turkestan.
Il movimento basmacestvo si costituì dopo la caduta del
governo provvisorio di Kokand, che aveva cercato di prendere le
redini del Turkestan in seguito alla rivoluzione. Dopo cinquant'anni di
occupazione russa, nel corso dei quali non si era creata nessuna
opposizione interna, questo improvviso spirito di ribellione fu
determinato da molte cause. A partire dalla soppressione dei khanati
si era andata sviluppando una coscienza nazionale; in seguito
l'istinto di difesa spinse all'insurrezione poiché la conquista russa
aveva necessariamente adottato misure assai dure, annullando sul
momento le raccolte di cotone e provocando un'insostenibile miseria
con l'abuso delle requisizioni. Le bande organizzate — inizialmente
un'accozzaglia di criminali — furono chiamate dal governo di Kokand
affinché lo sostenessero, e così i loro membri si trasformarono in
eroi liberatori che agivano in nome della popolazione.
A Taškent i russi bianchi, guidati dal generale Žunkovski,
organizzarono la controrivoluzione con l'aiuto degli inglesi, che
presto però li abbandonarono per proteggere il governo “sovietico” di
Ashkhabad, contrario alla dittatura bolscevica.
In quei primi anni della rivoluzione, secondo l'opinione di Mosca
riferita sulla «Pravda» del 20 giugno 1920, soltanto un russo poteva
diventare dittatore del Turkestan.
Secondo gli avversari del regime, questa chiusura
antinazionale, non legata a questioni di classe, sarebbe stata
all'origine della rivolta generale.
I soviet ritenevano invece che le radici dell'insurrezione fossero
da ricercarsi nello sfruttamento imperialista del vecchio regime. Essi
promisero di riparare alle ingiustizie zariste; pur tuttavia il movimento
dei basmaci crebbe dopo il loro avvento.
Ovviamente si erano verificate sommosse anche prima della
rivoluzione, come quella dei kirghizi nel 1916: in quell'occasione, per
salvare il proprio prestigio, il governo aveva cercato di gettare la
colpa su agenti provocatori turchi. Ma dopo le azioni severe e
inflessibili del generale russo Ivanov-Rinov, quando l'ordine di
mobilitare gli uomini dai diciannove ai quarantatré anni fu commutato
in lavori militari, si era ristabilita una relativa calma.
I russi avevano dovuto altresì sedare ripetuti conflitti tra uzbeki e
turkmeni di Khiva. Nel 1916 Žunaid, alla testa dei suoi guerrieri, si
era impadronito di Khiva tenendo in suo potere il khan della città,
Seid Asfendjar Bahadur. Ma la spedizione punitiva del generale
Galkin aveva costretto Žunaid a evacuare Khiva e da quel momento
i russi, persino i bolscevichi, furono per lui oggetto di odio. Nel 1918
riprese Khiva per due anni, dopo la partenza del colonnello Zaitsev.
Nel 1924, grazie all'appoggio dei commercianti e del clero, egli riuscì
ancora una volta a entrare in quella città ma l'Armata rossa, sconfitti
definitivamente i basmaci del Pamir, lo affrontò costringendolo ad
andarsene.
Si arrivò a un accordo che Žunaid rispettò, finché l'esecuzione
di alcuni suoi sostenitori lo indusse a riprendere le ostilità; per
ricondurlo all'obbedienza fu necessario dichiarare la mobilitazione
generale, decretare che la linea ferroviaria era in pericolo e quindi
convocare il comitato rivoluzionario militare.
Secondo le congetture di qualcuno, la sottomissione del
Turkestan a opera dei rossi sarebbe costata molte più vite umane
della conquista russa di cinquantanni prima.
Nel Fergana non erano mai avvenuti fatti inquietanti prima che
diventasse il centro del movimento basmacestvo, movimento che è
stato giudicato, persino da studiosi sovietici, come una reazione
inevitabile alla politica antimusulmana dei soviet.
Il terzo Congresso dei soviet del Turkestan, svoltosi nel
novembre del '17, rifiutò ai musulmani il diritto di partecipare
all'organizzazione del governo. A tale decisione cercò di porre
rimedio il Congresso nazionale di Kokand che però non aveva né
armi né denaro ma soltanto fede nella rivoluzione comunista, ben più
che in una lotta contro il governo centrale russo. Si rimproverò ai
soviet di non fare nulla per evacuare le truppe rosse che vivevano
nel paese. In un libro pubblicato a Mosca nel 1922, L'esecuzione dei
ventisei commissari di Baku, scritto da Vadim Čajkin, leggiamo la
risposta di Stalin: «Annientate voi stessi la sezione militare russa del
Turkestan, se siete in grado di farlo con il vostro proletariato e la
vostra massa di contadini e se la popolazione la considera estranea
al paese».
Nel '18 Kokand fu bombardata. Quel tentativo di governo
scomparve, ma i numerosi ribelli diffusero l'idea dell'insurrezione. In
quel periodo, sebbene il movimento basmacestvo fosse abbastanza
forte, esso si limitò a formulare soltanto le richieste indispensabili a
rendere più accettabile ai musulmani il programma sovietico. Tra il
'22 e il '23 la riforma agraria fu rinviata, si sospese la
secolarizzazione dei vakuf, i beni delle moschee, si tollerarono le
scuole musulmane. In seguito a tali concessioni quattromila basmaci
passarono ai bolscevichi.
Allora non esisteva un ideale nazionale comune, ma soltanto un
desiderio di autonomia.
Nel Fergana, interrottisi i rapporti con il resto del Turkestan, gli
insorti allo sbaraglio divennero ciechi strumenti nelle mani di
avventurosi kurbaši, o capi guerrieri, quale Madamin Bek, ex forzato,
che si unì ai soviet. Il suo rivale Kurshirmat, a capo di tutte le forze
antisovietiche del Fergana, dopo averlo accusato di tradimento lo
uccise; nel '23 Kurshirmat sarà costretto a ritirarsi in Afghanistan.
I basmaci travisarono lo scopo della loro lotta, divisero invece di
unire; ognuno volle essere il capo di un proprio gruppo senza
riconoscere gli altri.
In tale situazione sarebbe anche stato possibile sgominarli, ma i
saccheggi continui effettuati dai rossi, insofferenti a qualsiasi
disciplina, rinfocolarono le rivolte. L'emiro, fuggito sulle montagne nel
1920, era sostenuto da Ibrahim Bek che, alla testa degli insorti, si
battè per lui.
Subito dopo la sovietizzazione di Bukhara il movimento
basmacestvo risorse, appoggiato ora dagli intellettuali che, temendo
di veder scomparire 1 opposizione, tentarono, organizzando riunioni
segrete, di dargli forma politica. Ma un'autonomia che prevedesse
legàmi con lo stato russo era inammissibile, occorreva ottenere una
vera indipendenza nazionale. E così il Comitato per la liberazione
nazionale dell'Asia centrale, senza denaro e senza armi, decise nel
1921 di ricorrere al console britannico di Kuldja e di proclamare il
Turkestan “repubblica democratica indipendente ”. Ma i membri del
comitato vennero presto arrestati e al processo il procuratore li
condannò basando le sue accuse sulla sharia, erano colpevoli di
aver chiesto l'aiuto di un paese nemico dei musulmani, ovvero di
quegli infedeli britannici che opprimevano i luoghi santi di Medina e
della Mecca.
I rossi, liquidati nel 21 i fronti bianchi, sconfissero i basmaci.
Al primo Congresso dei popoli d'Oriente, svoltosi a Baku dal 1°
all'8 settembre del 1920, Enver Pascià — a cui il compagno Zinoviev
rifiutò la parola -, delegato dei rivoluzionari africani e indù, ebbe
modo di rimpiangere i suoi legami con Mosca quando seppe degli
eccessi delle bande rosse. Sembra che i tesori dell'emiro fossero
stati inviati a Mosca «come dono del popolo riconoscente della
provincia di Bukhara».
Nel novembre del '21 Enver decise di recarsi a Bukhara per
rendersi conto di che cosa succedeva in quella città; dovette
constatare che, dietro il pretesto della liberazione dei popoli, la
politica dei soviet in Turkestan era in realtà la continuazione del
passato regime.
Alcuni rappresentanti dei “giovani di Bukhara”, quali Faisula e
Osman Khodja, gli spiegarono di non aver ottenuto l'indipendenza
promessa ma di essere prigionieri dell'Armata rossa.
Enver, rendendosi conto che sarebbe stato impotente finché
fosse rimasto a Bukhara, con il pretesto di andare a caccia partì per
il Tagikistan, da dove inviò un primo messaggio al governo centrale
invitandolo a ritirare le sue truppe dalla regione e proponendo altresì
di organizzare la repubblica del Turkestan alleata ai soviet, con una
comune politica estera: «In tal caso», egli promise, «sarà possibile
grazie alle forze rivoluzionarie del Turkestan cacciare gli inglesi dalle
Indie».
Enver, genero del califfo di Costantinopoli e amico degli
intellettuali musulmani, era poco conosciuto dagli insoddisfatti con
cui si era associato. Commise un errore, nominandosi gran visir
dell'emiro decaduto Seid Alim, uomo dispotico e detestato,
sostenuto dagli zaristi.
Il Fergana e Samarcanda non riconobbero la sua supremazia.
Lo stesso emiro Seid Alim diffidava di colui che era stato capo dei
Giovani Turchi, sospettandolo di volere realizzare a proprio beneficio
l'unione delle popolazioni turche del Turan.
Il governo di Bukhara decise di inviare presso Enver una
commissione di revisione presieduta da Osman Khodja allo scopo di
reprimere l'insurrezione. In realtà, tale commissione doveva aiutare
Enver nella sua lotta contro Mosca.
Ma Osman fu costretto a fuggire a Istambul. Faisula avrebbe
voluto raggiungerlo otto giorni dopo, ma, sorvegliato a vista, dovette
rinunciare.
Enver tuttavia era sempre forte; in Turkmenia aveva l'appoggio
di Žunaid: ma i basmaci, incapaci di concepire un impero
panislamico, si ostinavano a voler creare uno stato regionale.
Ibrahim Bek, servo dell'emiro, si rifiutò di marciare al fianco di Enver
Pascià che, braccato sulle montagne del Tagikistan, venne ucciso il
4 agosto del 1922.
Nondimeno la ribellione continuò; anche le rivalità tra capi
basmaci non si sopirono. Ogni kurbaši aveva come unico obiettivo di
impadronirsi di una regione per dichiararsene bek e reinstaurarvi
l'antico regime feudale.
La presa di Garm da parte dei rossi, che guadagnavano così
terreno nelle zone di alta montagna, indusse l'emiro a inviare un
lungo appello alla Società delle Nazioni e a tutti coloro che «amano
la pace e rispettano la giustizia».
Nel '24 i soviet accusarono l'Inghilterra di fomentare disordini in
Asia centrale mentre Faisula Khodjajev dichiarò che i basmaci erano
ormai ridotti a bande di ribelli senza alcuna connotazione politica. La
Repubblica autonoma del Tagikistan, formatasi nel 1925, entrò a far
parte nel '29 dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, al
pari dell'Ucraina e dell'Uzbekistan.
Fino al 1931 Ibrahim Bek rimase a capo dei rivoltosi, godendo di
una grande autorità.
Nella regione di Hissar, al centro del Pamir, vivevano le tribù dei
Lokai e dei Magiai, restie a ogni disciplina. Guidate dai loro capi
potentissimi bek dai costumi feudali - esse saccheggiavano il paese.
I contadini talvolta si ribellavano, uccidevano il bek e fuggivano
unendosi ai basmaci.
Anche il contadino, pagato il proprio tributo al bek, riconosceva
a se stesso il diritto di rapinare i vicini. Ibrahim Bek per esempio, pur
figlio di un ricco mugnaio, essendo temuto per la sua maestria nel
tirare, si impadroniva impunemente dei cavalli altrui, secondo un uso
assai frequente nella regione.
I conflitti fra le tribù continuavano incessanti: Ibrahim insorse
contro Enver appoggiando l'emiro, e a nome di quest'ultimo inviò
proclami nel paese. I tagiki avversavano Ibrahim Bek, che era
uzbeko lokai e inoltre favorevole all'emiro di Bukhara, uzbeko
maqita. Questa lotta tra tribù era considerata dai soviet “una lotta di
classe”. Il 26 luglio 1931 Ibrahim fu catturato con il suo secondo e
con un cavaliere. Condotto nella prigione di Taškent, dovrebbe
trovarvisi ancora oggi.
Ma torniamo al processo che è in corso.
Gli accusati si alzano per essere condotti all'interno della
moschea dove vengono perquisiti. La gente spinge per vederli
meglio. I due alberelli piantati in mezzo al cortile si piegano
stranamente, fino a toccare terra, se ne intravede il fogliame
spuntare da sotto le braccia degli spettatori.
Sembrerebbe che la folla voglia lanciarsi a liberare l'uno o l'altro
dei prigionieri. Ma no, si limita a guardarli. Scortati due alla volta,
essi vanno per le loro necessità al fondo del cortile, dall'altro lato del
passaggio a volta...
I basmaci ritornano al loro posto e, rabbrividendo per il freddo,
infilano le mani nelle lunghe maniche del cappotto. Amrista deve
avere la malaria, la sua pelle è verdastra sotto la pioggia
scrosciante. Tremolano le guance grasse e cascanti del sarto
dall'aria ambigua. Ora tutti chinano la testa, spossati, lasciandola
cadere in avanti fino a sfiorare con il mento le clavicole. Quelle
nuche rasate e scoperte, sporgenti dallo scollo del khalat, sembrano
essere in attesa di un colpo d'ascia...
Se l'istante non fosse così grave tutte quelle teste in fila,
esageratamente chine, sarebbero quasi comiche; mi ricordano certi
momenti di preghiera in cui i fedeli esasperano il raccoglimento per
rendere la propria contrizione più edificante.
Sul podio l'uomo continua a leggere, le sillabe si succedono,
sorde, gutturali, con bizzarre elisioni, con brusche accentuazioni a
fine parola.
Un grido, un interminabile lamento... Le donne si precipitano in
avanti passando sotto la corda. Quei nomi scanditi un attimo fa sono
quelli dei diciannove accusati che sono stati condannati a morte!
Strepiti, urla: una scena straziante...
Con la sciabola sguainata i militari a cavallo si aprono un varco
fra i khalat e i turbanti; gli alberelli sembrano falciati da una nuova
tormenta, le donne sono strappate a viva forza dai loro uomini e
trascinate lontano.
Coinvolta nel tafferuglio, mi riesce difficile vedere che cosa
succede e devo riunire tutte le mie forze per difendermi dagli
spintoni. Rinuncio quindi a tornare al mio posto. A poco a poco la
folla si acquieta. Intravedo ancora il basmaci dai piedi nudi che ora
tiene stretto sotto il braccio il bollitore scrostato di smalto blu: fino
all'ultimo minuto di vita la carcassa umana chiede di essere nutrita.
Nel cortile ormai deserto gli alberelli si sono miracolosamente
raddrizzati, le sedie sono rovesciate a terra.
Quando all'indomani mi sveglio, Lenin medita ancora, da solo,
sul tavolo. Le sedie vengono accatastate l'una sull'altra per essere
portate via. Passa un uzbeko che, avvolto da un pesante mantello
nero invernale, tiene in mano una teiera di ceramica bianca; i suoi
stivali risuonano nel cortile di nuovo vuoto e silenzioso.
Sfogliando i giornali non ho trovato una sola riga sul processo ai
basmaci.
Bukhara, città declassata
In treno raggiungo Kagan, la stazione di Bukhara, a circa 250
chilometri da Samarcanda. Un impiegato mi ha messo di forza in
testa alla fila, così ho ottenuto un posto sul treno regolare. Lasciare
Samarcanda mi rattrista; amo la sua vita animata e quella
moltitudine di gente sempre in movimento fra cui mi sento a mio
agio. Mi mancheranno il mercato delle farine, tanto gremito da non
potercisi muovere, il grande bazar coperto ai piedi del mausoleo di
BibiKhanym, le innumerevoli čajkana montate su pedane pittoresche
all'ombra di un bel karragaš...
Marussja non voleva convincersi che sarei davvero partita
mentre la salutavo davanti alle grandi scuole di corso Vseobuč.
Durante il viaggio mi si è seduta accanto un'anziana contadina:
non staccava gli occhi dal pane che stavo mangiando e così l'ho
diviso con lei.
Questa linea transcaspiana da Krasnovodsk a Taškent è stata
costruita nel 1882, senza nessun piano quinquennale, «quasi alla
maniera americana, data la rapidità di realizzazione, a conferma del
fatto che la vita e i metodi russi presentano forti analogie con gli usi
dello “zio Sam”», come osservò Rickmers nel 1913.
Ma Bukhara è lontana, sia dall'America sia dalla Russia. La
prima impressione che ne ricevo è quella di un mondo di rovine e di
tombe. Alle porte della città, circondata da mura lunghe dieci miglia,
si stende il camposanto; anzi s'innalza, dovrei dire, dato che le
piccole gallerie parallele sono sovrapposte le une alle altre.
Che cosa ne è stato della famosa Bukhara, città di cicogne,
centro eccelso della scienza musulmana, forza dell'islam, dove
vivevano centocinquantamila abitanti, di cui ventimila studenti giunti
da ogni luogo per frequentare le sue cinquanta madrase!
In quei tempi occorrevano quindici o vent'anni per essere
designato imam, ovvero capo di moschea. E si insegnavano,
insieme con il Corano, la retorica, l'arte oratoria, la poesia e la
logica. La lezione s'iniziava come d'uso nello Yemen: si alzavano gli
occhi voltando le palme delle mani verso il viso e per ultimo ci si
accarezzava la barba! Nel 1848 vi erano quindici madrase a
Taškent, trenta a Kokand e sei a Samarcanda.
I crudeli emiri di Bukhara prepararono la rovina della città
opprimendo il popolo con imposte esorbitanti, decretando condanne
a morte per proprio diletto. Al museo è ancora possibile vedere gli
strumenti di tortura di cui i carnefici si servivano. Vi era un torrione
infestato da immondi insetti, cimici allevate appositamente per la
tortura dei prigionieri; quando mancavano uomini per nutrirle si dava
loro carne cruda.
Acqua e pane
Ho preso alloggio in una stanza al primo piano della “base di
turismo”, che dà sul cortile di una madrasa, nel centro della città
attraversata da stradine sporche e tortuose.
In un angolo della piazza vi è un erogatore d'acqua dove molti
abitanti vengono a riempire, per qualche copeco, enormi e splendidi
otri, muniti di bretelle.
Bukhara, bagnata dagli ultimi canali di irrigazione provenienti
dallo Zeravšan, aveva l'acqua più cattiva del Turkestan e il 95 per
cento della popolazione soffriva di febbri. Al momento della piena
tutte le vasche della città — gli haus- si riempivano d'acqua e attorno
a questa sorta di serbatoi si svolgeva la vita. La gente veniva ad
attingere acqua, vi faceva le proprie abluzioni, lavava i panni o le
tazze del tè... Una sporcizia incredibile. Ed era proprio attraverso
l'acqua che molti venivano contagiati dall'embrione del verme della
Guinea, il rišta, ovvero il “filo di cotone”, che cresce sotto la pelle
raggiungendo talora la lunghezza di un metro. I barbieri
s'incaricavano
di
liberarne
progressivamente
il
cliente
attorcigliandone ogni giorno qualche centimetro su un fiammifero;
occorreva procedere con grande prudenza per non spezzare
l'animale, nel qual caso si doveva ricominciare tutto da capo.
Ora il Ljabi-haus davanti alla mia madrasa, Dinan Beghi, è a
secco. La polvere è soffocante, invade tutto. Le pittoresche riunioni
sulle scalinate umide sono finite, ma l'acqua è bonificata: il ricta è
morto.
Per contro, approvvigionarsi di cibo è così difficile che la caccia
al pane costituisce l'evento più importante della giornata.
Avrei diritto al ristorante degli “specializzati”, dove si mangia
bene ma si spende troppo per il mio modesto bilancio, dato che ogni
pasto costa dai tre ai quattro rubli. Altrove occorre lottare per
accaparrarsi minuscole porzioni di zuppa o di gulaš, un miserevole
miscuglio di ossa in salsa.
Ho quindi deciso di cucinare da me, approfittando del fatto di
possedere una tessera grazie alla quale dovrei, in teoria, avere
quattrocento grammi di pane al giorno. Mi reco regolarmente alla
cooperativa dove, insieme con una quarantina di persone, aspetto di
veder apparire il prezioso alimento. Occorre essere sul posto se non
si vuole rischiare di perdere il momento propizio o di arrivare quando
hanno già venduto tutto. Quando tocca finalmente a me, litigo
regolarmente con il negoziante che spesso non mi dà nulla.
Nell'attesa la gente chiacchiera, scherza; nessuno recrimina o
protesta, la prendono tutti con filosofia... Da noi, in una situazione
simile, si parlerebbe di catastrofe imminente, si assumerebbe un'aria
tragica, ci si agiterebbe disordinatamente. Qui è impossibile
indovinare dalla sola mimica le parole della gente. Sento dire: «Le
razioni sono ancora diminuite: trecento grammi ai manovali, seicento
agli operai specializzati».
«Assicurano che a partire da febbraio distribuiranno grano
canadese...».
La mia vicina mi chiede di tenerle il posto mentre va a comprare
una cipolla o un cavolo per la zuppa. E io non posso trattenermi dal
dire loro che all'altro capo del mondo il grano viene bruciato nei
vagoni ferroviari o gettato in mare.
Non mi credono: «Ebbene», dice un vecchio tutto sorridente,
«se si permettono simili idiozie vuol dire che laggiù c'è qualcosa di
terribilmente storto!».
Un rumore: arriva all'emporio pane nero e caldo. Un uomo lo
divide in porzioni con un lungo coltello che immerge in una tinozza di
acqua tiepida. A ogni incisione si vedono le fette tagliate fumare
ancora, la mollica umida rimane incollata alla lama formando lunghi
fili luccicanti. Il gusto è dolciastro: credo vi sia una grande quantità di
giugara nella farina.
Andando via ognuno sbocconcella un angolino della sua
porzione.
Le patate costano tre rubli al chilo, ma è difficile trovarle: al
mercato della verdura non ci sono che cipolle e carote. Per un chilo
di riso, principale nutrimento dei locali, bisogna pagare da sei a otto
rubli. Un vecchietto tiene in mano sei uova che è pronto a cedermi
per tre rubli, ma si rifiuta di vendermene soltanto tre.
Qualcuno passa reggendo una lipioška, la gente lo ferma
perché vuole comprarla o domandargli dove l'ha trovata. Tutti si
affrettano a quell'angolo della piazza ma il piccolo venditore non ne
ha più e si allontana tenendo in equilibrio sulla testa la sua grande
cesta piatta. Alcuni mendicanti si aggirano nei paraggi: li vedo
tremare, devono avere le febbri.
Cerco di capire come si organizzano gli altri per nutrirsi.
Ritornando dall'Ark, l'antica cittadella o cremlino, scopro un
ristorante “chiuso”, riservato agli operai dell'industria elettrica. Verso
le cinque e mezza, quando tutti sono stati serviti, se rimane ancora
del cibo in cucina, i cuochi lasciano entrare qualche passante. Per
ottantacinque copechi è possibile avere una buona zuppa
accompagnata da un piatto di riso o di maccheroni.
Gironzolando nei pressi di una casa in costruzione sento
l'imprenditore dire al suo muratore: «Ti pagherò domani, oggi la
banca non aveva più liquidi».
«Potete anche tenerlo, il vostro denaro. Non saprei che
farmene. È di pane che ho bisogno! Pane, ecco cosa chiedono i miei
bambini quando torno a casa».
Un istante di silenzio.
«Trecento grammi al giorno ne ricevo! E la mollica è tanto
bagnata e pesante che la razione si riduce a nulla».
L'imprenditore si allontana per ricomparire con il suo pane, che
offre all'uomo senza proferire parola. Che altro può fare?
Mi reco dal soviet della città; vorrei visitare la comunità ebraica
di Bukhara, rinomata per la purezza della razza e delle tradizioni. Mi
piacerebbe anche vedere un allevamento di pecore karakul, di cui si
esportano le pellicce. Mi dicono di rivolgermi al comitato comunista,
dove però non trovo nessuno: tutti sono al lavoro nei kišlak a
raccogliere cotone a ritmi forzati, poiché ciò che soprattutto conta è
raggiungere le cifre stabilite dal Piano.
Nel formicaio
Non mi stanco mai di osservare la vita intorno a me. Vi sono vie
brulicanti di traffico indigeno. «Posht», “Attenzione!”, urlano gli asinai
e gli arbakeš facendosi strada tra la folla che compra e che vende
quel che può.
Accovacciata contro un muro ascolto il flusso e il riflusso di
questa umanità vagante: sono in un formicaio e capisco finalmente
dove sta andando ogni formica.
Due figli del deserto, riconoscibili dalla pelle abbronzata e dal
passo lento e sicuro, esaminano del kišmiš, ne assaggiano i piccoli
acini, poi chiamano un terzo compagno che porta stivali kazaki dai
tacchi a punta e fiosso alla Luigi XV. Il prezzo richiesto suscita la loro
ilarità e così si allontanano.
Molti hanno grandi turbanti di lana grigia, assai pratici per
portare, protetti tra due torciglioni, vetri di lampade. Sotto la rotonda
coperta della piazza, dove ancor più si accalca la gente, scoppia una
risata generale quando un tiro di buoi si mette a spingere con le
corna i passanti.
Un venditore di mele grida di continuo contro quelli che sostano
troppo a lungo davanti al suo banco.
Due afgani con turbante nero sono tentati da un taglio di
rasatello giallo in possesso di un russo che dice: «Guardate quanti
metri sono, avete solo da contarli, ci sono tutti!».
Un terzo si presta a fare da interprete.
Alcune donne vendono inqualificabili cianfrusaglie. Ma se viene
offerto un tappeto di Bukhara, un tekinski, o una maiolica cinese,
scompaiono nel giro di pochi minuti, acquistati da intenditori che
vedo ogni giorno alla ricerca di un buon affare. Un piccolo pezzo di
tekiner, tappeto di colore scuro lavorato dalla tribù dei Teki, vale
cento rubli ed è soprattutto utilizzato per confezionare i kurdjun, le
bisacce di cui ogni indigeno carica l'asino, il cavallo o il cammello. Mi
dicono che i loro disegni geometrici rappresentano in forme stilizzate
la yurta al centro del grande pascolo, l'aryk che lo solca, i fiori e il
cavallo nel campo.
La mia vicina di camera ha comprato due braccialetti e un
ciondolo d'argento antico lavorato che ha subito indossato, malgrado
le abbiano preconizzato ogni contagio possibile.
In una čajkana alcuni ragazzini accovacciati si scaldano le mani
sulla bocca del forno, mentre le madri, in piedi accanto a loro,
lanciano piccole grida per richiamare l'attenzione sulle camicie in
vendita. Una di loro ha una stella d'oro che brilla alla narice.
Passa un mendicante, prende un po' di brace con la sua
schiumaiola e fa bruciare delle foglie secche di cui offre il profumo.
Nessuno sa che cosa sia la mia Leica, ma appena inizio a
maneggiarla tutti si precipitano per comprarla. In questa metropoli
decaduta l'istinto commerciale è tuttora assai vivace.
Tutti sgranocchiano qualcosa, mandorle, urjuk, oppure uva
comprata sul momento.
Passa un camion lasciando dietro di sé un insolito odore di
benzina: tale è l'abitudine di sentire soltanto olezzi stantii di urina
che se ne rimane sorpresi. Se voglio capire la vita delle formiche che
si agitano intorno a me devo però comportarmi come loro: comprare
e vendere. Passeggio tenendo ben in mostra una macchinetta per
tagliare i capelli, che mi ero procurata tempo prima in previsione di
una lunga traversata in barca a vela. Chiedo venti rubli, disposta a
scendere a dieci; ho anche un coltello e un orologio da due scellini,
acquistato da Woolworth.
Non appena mi incammino per la stradina dove martellano gli
stagnai, i soliti avvoltoi si gettano su di me, decisi a non lasciarsi
sfuggire una simile occasione.
Un uomo dalla barba rossiccia, dagli occhi truccati e con le
unghie laccate di rosso saggia sprezzante la lama... Buon affare:
intasco trentacinque rubli per tutto e ne dilapido subito quattro per
un'anguria.
Non faccio a tempo a palpare un paio di pantaloni di flanella
sventagliati da un imponente russo che quest'ultimo mi apostrofa
duramente, secondo l'abitudine generale: «Prendili, ma che cosa
aspetti?», come se fosse irritato da tanta stupidità: come si può
lasciarsi sfuggire una così bella occasione per soli trenta rubli!
Talvolta mi fermo all'improvviso, tentata di porgere la mano a un
uomo che, malgrado il turbante, mi sembra di conoscere da sempre.
È senza dubbio un tagiko, lo indovino perché siamo del medesimo
sangue.
Una ragazza indigena, truccata e con una bocca volgare dai
denti sporgenti, beve sola in una čajkana. Accovacciate ai suoi piedi
alcune venditrici di berretti vengono quasi soffocate dalla folla che si
scosta per far passare un teleg. Il macellaio sbraita, preso d'assalto
in mezzo ai suoi pezzi scarlatti di cammello.
Sono tanti quelli che potrebbero ripetere assieme al derviscio
che avanza con il suo scodellino di zucca da pellegrino: «La povertà
è la mia gloria». Un venditore di torrone mette infreddolito le mani
sotto le ascelle, il naso gli cola. Una donna cerca di proteggersi
reggendo con le labbra umide i lembi dello scialle verde oliva.
Alcune vecchie tendono una ciotola di legno: hanno palpebre
diafane e croste scure agli angoli della bocca. La pioggia cade,
ravvivando i colori sulle spalle imbottite dei khalat consunti...
Ovunque mi appaiono cadaveri ancora in vita che lottano con
più O meno forza... E forse anch'io lo sono, io che sto immobile a
guardarli. Tutto dipende dal “più” o dal “meno”.
L'odore della morte
La popolazione è scesa a 40 000 abitanti. Per una casa ancora in
piedi ve ne sono tre cadenti, poiché quando muore il capofamiglia la
sua dimora scompare con lui: ciascuno qui si costruisce da sé la
propria abitazione.
Vi sono tombe sui tetti. Henry de Monfreid ha scritto: «Un santo
ha meritato di essere sepolto lassù, di conservare il proprio posto fra
i vivi, di salvarsi dal cimitero della duna, da quella terribile
uguaglianza dove precipita la morte musulmana e ogni morte. Lembi
di tessuto e ciuffi di capelli svolazzano dalla grata della finestra».
Dovunque aleggia un vago odore di muffa, come di sabbia di
palude, e ancor più nei cimiteri sui cui sentieri di löss i passi si
muovono silenziosi. In un mare di gobbe tutte identiche mi
destreggio per raggiungere un boschetto di alberi fiammeggianti dei
colori dell'autunno; il vento ha ammucchiato le foglie morte nel cortile
di una moschea abbandonata, circondata da un peristilio a colonne.
Ritrovo il medesimo odore nella moschea di Char Minar, dove le
celle in rovina sembrano orbite nere e vuote. L'entrata è sovrastata
da un gruppo di quattro minareti incappucciati di turchese, che
ospitano, ognuno sulla propria sommità, un nido di cicogna.
Nella strada un ubriaco cade e a ogni suo tentativo di rialzarsi
alcune donne dagli scialli multicolori ridono con franca allegria.
In un altro cimitero stanno demolendo le tombe per liberare il
terreno intorno al mausoleo di Isma'il il Samanide, che sta
lentamente sprofondando. Dagli alveoli a ripiani si sprigiona un'aria
fredda che sa di terra putrida e di decomposizione: un odore simile a
quello dei bachi morti nei loro bozzoli ammonticchiati. Ossa e
brandelli di tessuto si mescolano alle macerie. Il morto non è
schiacciato dalla terra: si costruisce una volta sopra di lui.
Il mausoleo di Isma'il, il più antico monumento del Turkestan —
risale al X secolo —, è un piccolo emisfero sostenuto da un cubo
rivestito di mattoni incolori, il cui rilievo forma decorazioni
geometriche.
Assai più curiosa è la tomba di Chashma Ajub, la fonte di
Giobbe. È un semplice cono di mattoni sporgenti che si innalza
solitario su anonime tombe. Si narra che Giobbe, giunto in questo
luogo, si chinò per bere e che, mentre si dissetava, sorse un riparo
attorno a lui.
Sì, la morte è ovunque: nelle madrase abbandonate dal suolo
disseminato di mattoni smaltati; sulle gradinate delle grandi vasche
ormai prosciugate, simili a strane arene; nei cortili deserti.
Ma ciò che è sopravvissuto suscita emozioni intense e
ineguagliabili. Come dimenticare la sorprendente freschezza di quel
boschetto sulla facciata di maiolica di Abdul Aziz! Purezza delle
linee, eleganza delle proporzioni, gioia dei colori: quella
raffigurazione compendia in sé tutta la madrasa dal bel nome, il suo
cortile aperto e ridente, le due sale dagli arabeschi in porpora e oro,
sormontate da soffitti a stalattiti.
Di fronte ad Abdul Aziz si innalza la madrasa di Ulug-Beg, assai
più austera. Il suo cortile chiuso fra alti muri induce al silenzio e alla
meditazione mentre — mistero delle proporzioni classiche — dinanzi
all'imponente iwan, incorniciato da una colonna a torciglione, si è
colti da un sentimento di venerazione. Questa madrasa, costruita nel
XV secolo, cioè duecento anni prima della vacillante Abdul Aziz, è
solida e non ha bisogno di alcun puntello.
Ma se di stile grandioso si tratta, nulla è paragonabile alla
moschea Kalian.
Dalla sommità del minareto della Morte, che la affianca, alto
cinquantadue metri, venivano gettati per ordine dell'emiro i
condannati a morte. Da lassù si svela il suo immenso cortile, la
cupola turchese sovrastante il santuario, il frontone centrale dinanzi
al padiglione delle abluzioni.
Come nelle fiabe, nei giorni di festa veniva posto sul lastricato
un enorme tappeto rosso per accogliere tutti i grandi della terra,
vestiti di sete e di broccati.
Coloro che da qui passarono
Poiché il Kalian risale all'XI secolo, le sue mura hanno visto, nel
1220, Gengis Khan salire al potere — egli si era appena impadronito
della città alla testa dei suoi centocinquantamila uomini —,
proclamarsi il flagello di Allah e ordinare ai dottori di dar da mangiare
ai suoi cavalli nelle casse del Corano.
Sotto la penombra della triplice arcata a volta sostenuta da
grandi pilastri cubici, che circonda il cortile, sento incombere la
pesantezza di una cattedrale romana. L'altare, il mihrab, non è nulla
più di un rettangolo di disegni smaltati. La luce qui è così bella che
cerca soltanto linee pure su cui posarsi, non le servono vetrate e
sculture.
Fuori, sulla vasta spianata ai piedi del Mir-Arab, la più grande
scuola musulmana di Bukhara, ferve tra mille grida l'incessante
vendita all'asta. Da ogni lato del portico, due battitori urlano dalla
loro posizione sopraelevata le varie offerte: mantelli, čapan, cuscini,
macchine per cucire, scialli, tagli di seta, coltelli, stivali... La
moltitudine si muove, minuscola, sotto l'immensa facciata interrotta
da due file sovrapposte di nicchie.
Vambery, l'intrepido viaggiatore travestito da pellegrino, giunse a
Bukhara ai tempi in cui l'emiro metteva a morte ogni europeo che si
arrischiasse a entrare nella città.
Il capo avvolto da un turbante, il Corano al collo, egli dovette
passare attraverso una folla simile a questa, che certo lo implorava
di effondere il suo santo spirito, di distribuire la polvere contro le
malattie, raccolta a Medina nella dimora del Profeta.
In netto contrasto, la grande piazza davanti all'Ark è solitaria;
dietro le loro porte monumentali i palazzi dell'emiro ospitano ora
l'istituto pedagogico. In mezzo alla piazza si innalza la torre in ferro
del serbatoio d'acqua. L'haus, ancora pieno d'acqua, è ai piedi della
moschea Bala Khan, ora sede del circolo dei lavoratori. Si tratta di
un'immensa galleria tutta in legno scolpito, dal tetto sostenuto da
una doppia fila di alte colonne sempre di legno che si assottigliano
verso l'alto, quali fusti di palme parallele.
Qui giunse, nel 1843, con la Bibbia in mano, un altro europeo, il
reverendo Joseph Wolff. «Quelle povere anime ottenebrate
toccavano il Libro con devozione», egli riferì in seguito. Il reverendo
veniva a cercare notizie di due suoi compatrioti, Stoddart e Conolly,
che erano stati accreditati dall'emiro come rappresentanti
commerciali. Essi si erano resi colpevoli di alcune mancanze di tatto,
e gli intrighi di corte avevano esacerbato il caso, tanto da renderlo
fatale. La visita di Wolff era dunque assai rischiosa.
«Seduto al balcone del suo palazzo, Sua Maestà, l'emiro Nazir
Ullah Bahadur», egli scrisse, «guardava verso di noi che eravamo
attorniati da migliaia di persone. Tutti gli occhi erano puntati su di
me, per vedere se mi sarei piegato all'etichetta. Quando lo šekaul, il
ministro degli Affari esteri, mi toccò la spalla, non solo mi sottomisi
tre volte, ma mi inchinai ripetutamente esclamando: “Pace sul Re,
Salamat Padishah!”, finché Sua Maestà scoppiò a ridere e tutti gli
altri con lui».
Wolff era vestito di nero e di rosso, dato che in occasione delle
sue visite all'emiro indossava sempre l'abito da pastore
anglosassone. Sua Maestà gli domandò la ragione dei due colori.
«Il nero sta a significare che porto il lutto per i miei cari amici, il
rosso che sono pronto a versare il sangue per la mia fede».
Nazir Ullah era terribile: aveva ucciso cinque fratelli per salire al
trono. Era come una belva assetata di sangue e questo perché
aveva avuto una nutrice kazaka, e i kazaki, accusati di cibarsi di
cadaveri, erano chiamati “mangiatori di uomini”.
L'emiro osservò incuriosito: «Posso uccidere tutti i persiani che
voglio, ma appena tocca a due inglesi ecco che arriva dalla lontana
Londra una missione per informarsi».
In quel tempo la città contava 180 000 abitanti e ogni famiglia
aveva il proprio schiavo persiano.
Quel passato è morto, scomparso del tutto. Oggi solo il cotone è
importante e i mullah ostili alla soppressione del čador vengono
picchiati dalle donne.
Il cotone sarà in grado di resuscitare Bukhara, città declassata?
Verso l'Amu Darja
«Scusatemi, dove trovo l'autobus delle sei e mezza?»,
domando all'impiegato del capolinea.
«Non so, il secondo autista non è ancora arrivato».
«E l'altro?».
«Ah, il primo è già andato via questa notte, senza passeggeri».
Che seccatura! Ancora un ritardo. Quando finalmente ci mettiamo in
moto, malgrado l'acceleratore a tavoletta, non recuperiamo il tempo
perduto e il treno, a Kagan, non aspetterà certo me.
Appena lasciamo le strade lastricate, i camion non sollevano più
polvere ma un vero mare di nebbia, da cui talora emerge una fila di
cammelli spaventati che camminano di sghimbescio, aprendosi
come l'onda dinanzi alla prora. Hanno museruole di grossa tela
grezza attraverso cui brilla il loro fiato condensato in brina; sul naso
si erge un pennacchio di lana: hanno forse bisogno di mirare un
punto per avanzare in linea retta?
I due sacchi del carico, legati insieme in cima alla groppa,
pendono ricolmi, ognuno dal proprio lato, fino a terra, formando
enormi accenti circonflessi grigi che avanzano a intervalli regolari,
tutti con lo stesso ritmo.
Le foglie delle piante di cotone sono avvizzite, scurite dal gelo. Il
paesaggio è tinto di giallo e di azzurro: alberi all'orizzonte sotto il
tenero cielo. Sui bordi della strada cespugli arrotondati di selci sono
incipriati di polvere come le guance di un'attrice che entra in scena.
Il treno diretto è ormai perduto e per il prossimo bisogna
aspettare a lungo.
Dato che la mia meta, Čardžou, sull'Amu Darja, dista non più di
centoventi chilometri, mi accontento di un Maksim in partenza. In
tutti i vagoni merci sono accampate cenciose famiglie di kazaki, che
passano il tempo a spidocchiarsi vicendevolmente.
Un impiegato mi informa che hanno appena attaccato una
carrozza passeggeri dove certamente potrò viaggiare meglio.
Prendo posto di fronte a un uomo brizzolato, silenzioso finché,
attratto dal mio orologio impermeabile, me ne chiede la provenienza.
Inizia così la fitta conversazione tipica di due sconosciuti che si
lasceranno nel giro di poche ore per non rivedersi mai più.
A proposito dei grandi deserti circostanti Khiva ho sentito storie
di briganti. Sembra che essi, in groppa a veloci cavalli non ferrati e
dai larghi zoccoli adatti a galoppare sulla sabbia, sfuggano
regolarmente agli inseguimenti organizzati dai rossi, decimati ormai
da quella vita tanto dura.
E se si trattasse ancora di Žunaid e dei suoi compagni che,
uomini imprendibili tra quei morti spazi, continuano le loro incursioni?
Khiva mi attira: città isolata, difficile da raggiungere, dove meno che
altrove è riuscito a penetrare il sovietismo. Il direttore delle Antichità
di Bukhara, uno studioso che vive in una casa stipata di libri, me ne
ha parlato come di una città strana, un tempo capitale mongola e ora
soffocata dalla sabbia che inesorabilmente l'invade, ma dove
sorgono, specchiandosi sul lago d'Aral, monumenti dell'XI secolo.
Avevo allora cercato di sapere con che mezzi era possibile
raggiungere Khiva, se esisteva un servizio passeggeri lungo il corso
dell'Amu Darja, dato che la linea aerea Čardžou-Khiva era troppo
costosa per me. Il direttore mi aveva sconsigliato di navigare verso
paesi così selvaggi.
In città, all'ufficio della ferrovia, nessuno era in grado di fornirmi
la benché minima informazione. Per ben due ore l'impiegato aveva
ripetutamente provato a telefonare al capostazione e quando
finalmente l'aveva trovato, era risultato che costui non sapeva nulla.
Meraviglia della telefonia: la mano gira la manovella della suoneria,
ventitré volte in un senso e poi bruscamente capovolge il movimento
per compiere altri sette giri dalla parte opposta! Quando l'ufficio non
risponde bisogna ricorrere al trucco di soffiare con energia dentro la
cornetta...
«Sapete come si può arrivare a Khiva?», domando al mio
compagno di viaggio.
«Con l'aereo si impiegano quattro ore e il volo si effettua due
volte alla settimana».
«E altrimenti?».
«Non ho idea».
«Anche nell'oasi di Khiva hanno piantato molto cotone?».
«Nel Khorezm sì, sempre di più».
«Per quali motivi, secondo voi, l'indigeno si è deciso a questo
tipo di coltura?».
«Il contadino è stato convinto con l'offerta di ogni sorta di
vantaggi, ma in realtà egli è obbligato a coltivare cotone; se
rifiutasse, infatti, non potrebbe acquistare nulla alle cooperative, né
grano né manufatti. Inoltre, il più delle volte gli viene persino indicata
una porzione di terra che è libero di coltivare come vuole: a orzo, a
riso, a mais oppure ad alberi da frutta».
Mi piacerebbe sapere se le cooperative sono effettivamente in
grado di soddisfare i bisogni della gente.
«Quelle più lontane dai grandi centri sono di solito le meglio
fornite. È una buona politica. Mia sorella, che si è trasferita a Turtkul,
aveva portato con sé da Mosca alcuni pezzi di sapone, frutto di
lunghe e pazienti ricerche e pagati cinque rubli. Arrivata qui, si è
resa conto che al mercato ne poteva avere quanti ne desiderava, e
per soli due rubli. Quello che manca è il grano, e al bazar ha prezzi
esorbitanti».
Mi informo dove è situata la città che ha appena nominato.
«Turtkul è la capitale dei Karakalpachi, sull'Amu Darja».
Il treno si ferma al centro di una zona arida. Di fianco alle rotaie
vi è una fila di cammelli da cui viene scaricato, e poi pesato, il
cotone; al suolo sono ammucchiati all'aria aperta chicchi di grano.
Dai vagoni dei kazaki proviene un sordo martellio, che si ripete
fino all'estremità del treno. Incuriosita, scopro che le donne pestano
il grano in un mortaio per ricavarne farina.
I bambini chiedono di scendere a terra; sono coperti da pochi e
miserabili stracci e hanno la testa piena di croste. Una donna
risistema il suo scialle — unico capo del suo abbigliamento che non
sia a brandelli — avvolgendolo a mo' di turbante. Ne scorgo i capelli
unti e i lunghi orecchini d'argento. Il piccolo abbarbicato alla sua
gonna ha gambe magre dalle ginocchia sporgenti; l'altro figlio, quello
che tiene sulla schiena, ha la pelle floscia e avvizzita, tanto è
denutrito.
Da dove vengono, dove sono diretti?
Čardžou
Ora non c'è che deserto intorno a me: assorbite dalla sabbia
scompaiono le ultime gocce dello Zeravšan, padre delle oasi di
Samarcanda e di Bukhara, a ventiquattro chilometri dall'Amu Darja,
l'antico, grande Oxus che nasce nel Pamir. Il deserto avanza di circa
un chilometro ogni secolo. La regressione delle acque non è da
imputare soltanto all'incremento degli aryk, ma anche ai venti che da
occidente spingono le grandi dune modellate a mezza luna, i
barkhan.
Nel tentativo di frenare tale avanzata, che è di circa cinquantasessanta metri l'anno, è stato piantato un tipo particolare di arbusto.
L'acqua di irrigazione serve a innaffiare i campi ma anche, e
soprattutto, a lavare la terra in modo da liberarla dei sali che
contiene. Il löss trasportato dal vento li renderà poi fertili.
Continuare il viaggio in treno fino al Caspio e al Mar Nero mi
sembra una sciocchezza. Decido quindi di scendere a Čardžou nella
speranza di poter proseguire navigando sull'Amu Darja. Lascio i
bagagli al deposito e mi informo presso il capostazione che mi
indirizza all'ufficio fluviale. Quando arrivo è già chiuso, benché siano
le quattro. Davanti alla porta due donne sono sedute sui loro fagotti.
Una si lamenta: «Ne ho abbastanza, domani torno a Samara».
«Ma no», dice l'altra, «adesso che siamo qui, il più è fatto. Novo
Urghenč non è lontana».
«Non è lontana? In battello occorrono otto giorni, sul camion,
come sull'idroscivolante, non si trovano posti liberi prima di dieci
giorni, l'aereo ha prezzi inaccessibili».
«Cerco il porto, sapreste indicarmi dov'è?», domando loro.
«A cinque chilometri da qui, laggiù dall'altra parte dell'isola.
Potremmo quasi andarci anche noi...».
Le lascio dietro di me, lente, indecise. Mi sento come un binario
che corre in mezzo a terre desolate. Vedo ancora in lontananza,
sotto di me, i kazaki del treno riuniti in piccoli gruppi, tenebrosi
mucchi di uomini accampati. Che ne sarà di loro? Moriranno di
fame? E allora mi sorge spontaneo domandarmi se i miglioramenti
operati dallo stato non rischino di arrivare troppo tardi per salvare il
paese. Ma so bene che in Asia la vita umana conta assai poco...
Enormi depositi dove finiscono i binari, vicino a un cantiere che
costruisce chiatte metalliche. Una diga interrompe un piccolo canale
e io attraverso l'isola paludosa disseminata di rade canne.
Al porto
L'ufficio portuale è situato su un pontile accostato all'argine. Di
fronte, botti di olio, balle di cotone e tre grandi tende moderne dove
vivono numerosi russi.
Mi informo dal compagno cassiere sull'ora di partenza del
prossimo battello.
«All'alba, ma è completo, sia le cabine sia il ponte». Gli
domando ancora se esiste un servizio sul lago d'Aral.
«Vi sono cargo che vanno da Kantucjak al delta dell'Amu, fino
ad Aralskoie More. Ma dopo Turtkul e Novo Urghenč troverà soltanto
trasporti irregolari e caicchi».
Si susseguono senza sosta viaggiatori che chiedono invano un
posto per il battello di domani.
«Compagno, mia moglie è molto malata, non ha le forze per
sopportare un'attesa troppo lunga».
«Guarda anche tu, compagno, ecco qui il telegramma di mio
padre, moribondo a Turtkul».
«Non posso più accettare nessuno. Il battello imbarcherà già
centocinquanta passeggeri al posto di novanta, più due tonnellate di
merci».
Quando è il mio turno, mostro i documenti: «Compagno, sono
giornalista e vengo da assai lontano per visitare il tuo paese; non ho
tempo da perdere e rinuncio volentieri alla cabina».
«D'accordo, trovati qui alle sei di domani mattina, sono io a
occuparmi dell'imbarco. Trentacinque rubli fino a Novo Urghenč,
posto ponte».
Talvolta essere stranieri è un privilegio...
I miei bagagli sono in stazione e ritorno a prenderli. Il deposito è
chiuso: l'impiegato è andato a mangiare. Dovrò rassegnarmi ad
aspettarlo fino al calar della sera. Adocchio un isvoščik, un vetturino,
e gli domando quanto vuole per condurmi al porto.
«No, signorina, di notte non mi arrischio laggiù. Da quelle parti è
pieno di basmaci e io ci tengo al mio cavallo».
I venditori vicini alla stazione non hanno lipioška : offrono, in
compenso, meloni verdi, a un rublo la fetta; sono di una bontà
indescrivibile, la loro polpa bianca si fonde in bocca, dolce,
zuccherina, dissetante, profumata. Si tratta di una qualità pregiata di
meloni: i califfi di Baghdad, di Memun e di Vatik li facevano arrivare
dalle montagne, ricoperti di neve dentro cassette di stagno
ermeticamente chiuse.
Il peso delle sacche mi rallenta il passo. All'entrata del deposito
un guardiano le tasta per assicurarsi che io non sia un'incendiaria.
Mi fermo in un angolo, investita dal forte odore di catrame. Le
saldatrici elettriche illuminano le chiatte in costruzione di fantastici
sfavillii blu.
Mi allontano nella solitaria oscurità, incespicando talora nello
spesso fondo sabbioso del suolo.
Ho tempo: un'intera notte. Posso concedermi ancora una sosta
per riprendere fiato. Che cosa succede? Uno strano rumore, come di
qualcuno che sputa. Sento una presenza dietro di me, spero di non
essere notata. L'uomo mi vede e arretra di un passo, spaventato.
«Compagna, ti stai riposando?», dice con un tono di voce solo
in parte rassicurato.
«Sì, vado al porto, ma il mio bagaglio è così pesante!».
Ridendo della propria paura, si offre di aiutarmi. Raggiungiamo
insieme la sponda del fiume, le cui grandi acque scorrono verso
settentrione.
Il mio accompagnatore è meccanico su una piccola vedetta
dove vengo invitata per la notte. Stendo sul pavimento il sacco a
pelo e cullata dolcemente ascolto lo sciabordio dell'acqua contro il
fasciame della barca: vorrei mettermi a fare capriole tanta è la gioia
che mi invade. Ho ritrovato la mia amica di sempre, l'acqua viva, con
il suo odore, il suo movimento, le sue improvvise bizzarrie. Nella
minuscola cabina di prua tre uomini bevono il tè.
Probabilmente parlano del passato poiché sento nominare
luoghi come Rostov, il Baltico... In questo medesimo momento,
all'estremità della penisola francese, altri marinai si staranno forse
raccontando le loro campagne di Mauritania o d'Islanda.
Al risveglio vedo muoversi sopra di me una corda. Mi siedo: a
fianco della vedetta scivola un caicco, sulla cui prora sventola una
coda di cavallo. È una grande chiatta vuota che un indigeno
allontana dall'argine aiutandosi con una pertica, mentre a terra gli
uomini dell'equipaggio, tutti con il capo coperto da un enorme
colbacco nero, alano controcorrente l'imbarcazione.
L'acqua è color caffellatte. Il meccanico vi immerge il bollitore
per riempirlo. Sulla sponda c'è gente che si lava le mani e il viso.
La cambusa del “Pellicano”
Il Pellicano , battello a pale che condurrà gli “eletti”, è arrivato.
Appena salpati si passa sotto l'immenso ponte della ferrovia,
costruito trent'anni fa: venticinque archi, ognuno di settanta metri.
La corrente del fiume è rapida - otto chilometri all'ora - e la
navigazione difficile a causa dell'acqua poco profonda e dei banchi
di sabbia in movimento. Vi sono segnali piantati nel canale,
continuamente controllati dal barbuto pilota, un tataro biondo che
non abbandona mai il suo casseretto.
Al momento delle piene, dopo le piogge d'aprile e il disgelo di
giugno, questo grande fiume di 1400 chilometri è color cioccolata e
ha una larghezza di tre chilometri; raggiunge il livello massimo di
profondità, venti metri, in un tratto lungo trecento metri, dove il suo
letto si restringe. Già prima della rivoluzione navigavano sulle sue
acque imbarcazioni simili a quelle del Volga.
Il motore rallenta, lasciano filare l'ancora. Dalla grata della sala
macchine si odono colpi di martello. Finalmente si riparte.
Un ingegnere di nome Lavrov, che viaggia in compagnia di due
studenti con cui ho avuto occasione di scambiare quattro
chiacchiere, mi invita nella sua cabina a dividere con lui una
porzione di pollo. Dirige i lavori di Tiuja Mujun dove è in cantiere la
costruzione di una diga colossale. Il mio coltello a sei lame,
acquistato a Londra, lo riempie d'ammirazione.
All'imbrunire il Pellicano compie un mezzo giro, s'infila nella
corrente e si ferma arenandosi sull'argine friabile. Prima di andare a
coricarsi molti si sgranchiscono le gambe a terra tra le alte canne,
con le quali accenderanno un grande fuoco scoppiettante.
I passeggeri si sono sistemati per dormire sul ponte, sulla lunga
panca che gli corre tutt'intorno, sulla plancia del cassone sopra la
ruota a pale. Riesco tuttavia a scovare un posto ancora libero: il tetto
della cambusa dei viveri, su cui mi sistemo dominando così quegli
infelici ammassati sul ponte.
A terra, la macchia rossa del falò è una ferita sanguinante che
freme e si contorce nel corpo della notte.
Soltanto i fili dell'antenna radio mi separano dalle stelle, fragile
parapetto sul ciglio di un abisso trafitto da mille luccichii.
Il Pellicano è già in moto quando il vento fresco mi risveglia.
Dalla mia posizione sopraelevata vedo i caicchi risalire la corrente
con le loro grandi vele di fortuna quadrate, gonfie di vento; nella
parte superiore, vicino al pennone, le intemperie ne hanno annerito
la tela ed esse mi evocano le vele della Santa Maria così come sono
rappresentate nelle incisioni. Nel momento in cui li incrociamo
scorgo le balle di cotone, le venti teiere dell'equipaggio, allineate
all'interno dei bordi liberi dell'imbarcazione e i colbacchi appesi come
tanti scalpi ai pioli dell'albero. Ritto a prua, il marinaio di vedetta; un
enorme remo funge da timone.
Di norma, tuttavia, i caicchi si tengono discosti dal canale, per
navigare dove la corrente è meno forte.
Dal tetto della mia cambusa, se evito di abbassare lo sguardo
sul ponte, posso fantasticare di essermi concessa il lusso di
noleggiare uno yacht per raggiungere Khiva, il khanato che più a
lungo mantenne la propria indipendenza. Sto navigando su quel
fiume chiamato Oxus dai Greci, l'Oecus, l'Okus-Su, l'Acqua del Toro.
I rumori dell'equipaggio mi arrivano attutiti; lo steward presto mi
chiamerà: «Breakfast is ready, milady». Uno steward parla sempre in
inglese, qualunque sia il menù. Non voglio pensarci: uova al lardo,
pane tostato...
Prendo la decisione di installare il mio fornellino nell'angusta
cabina del meccanico, così potrò far bollire l'acqua del fiume per il
tè. La sua ospitalità mi permette di risparmiare quei due o tre rubli
della zuppa, distribuita ai passeggeri dalla cuoca. Sul ponte è
proibito cucinare.
Vasili Ivanovič è un uomo tranquillo. Ha il volto sempre lucido,
come tutti i meccanici della terra, porta un maglione ampio ed è
molto affezionato al suo bocchino che non abbandona mai. La sua
cabina è pulita.
«Che fatica! Da otto mesi costringono questo povero macinino
ai “lavori forzati”, non so come regga ancora. In compenso, ci siamo
assicurati il premio e abbiamo fatto più viaggi del Komunar. Che folla
c'è a bordo! E pensare che al ritorno non abbiamo mai più di dieci
passeggeri!».
Un rombo: un idroscivolante sfreccia sull'acqua a settantacinque
chilometri all'ora, e in un attimo scompare. Che cosa penseranno
quei cammelli lungo la sponda? In sole sei ore sarà a Turtkul, mentre
noi — se riusciremo a non incagliarci — ci arriveremo fra sei giorni.
Il paesaggio è un insieme di linee: le strisce giallo spento del
suolo e della vegetazione, il nastro azzurro del cielo. I banchi di
sabbia emergono in dolci rotondità.
La sponda occidentale si muta in falesia, lungo la quale si snoda
una processione di bardotti, una dozzina o poco più, a distanza
uguale l'uno dall'altro, che procedono tutti con lo stesso ritmo, un
passo lungo seguito da uno breve. Hanno l'occhio del cavo passato
sulla spalla e si protendono con il corpo tanto in avanti da sfiorare
quasi il terreno con il braccio libero. Rimorchiano un caicco che
naviga lontano dietro di loro, tirandolo per la cima del suo albero.
Sullo sfondo il cielo da blu ocra vira al vermiglio: è il tramonto.
Una scossa brusca, ci fermiamo. Il battello si è incagliato
trasversalmente alla corrente che ride di noi gorgogliando contro lo
scafo e facendoci sbandare.
L'acqua è profonda appena cinquanta centimetri, ma le pertiche
su cui ciascuno fa leva sono manovrate in modo tale da liberarci,
permettendoci di raggiungere la riva. Immagino che soltanto le
acque dello Stige possano essere di un simile, fluido, cupo
spessore.
«Questa notte dobbiamo stare allerta», dice Vasili, «si aggirano
basmaci in questa zona. Hanno già assalito e svaligiato l'autobus di
servizio e rapito quattro donne russe».
Ah, sarei in prima fila se mai mi capitasse l'avventura di
assistere a un attacco!
Ormai l'alba tinge il cielo di grigio e non è successo nulla.
Dinanzi a me vedo soltanto la striscia di terra nera delimitata dai
pallori del cielo e del fiume. Più avanziamo e più il freddo diventa
pungente; devo infilare anche la testa e le mani dentro il sacco a
pelo.
Ora l'orizzonte dispiega a est lunghe striature dei colori
dell'arcobaleno in un continuo gioco di luci, e finalmente la superficie
violetta della terra si circonda d'oro: oro del cielo, oro dell'acqua.
Alcuni cammelli neri passano ai piedi delle nitide dune appena
increspate, zebrature su una pelle di daino. Di fronte, sul suolo piatto
dell'argine, spuntano erbe fitte come peli di un'immensa spazzola
fulva.
Avvistiamo alcune jurte, funghi bruni in mezzo alla boscaglia, e
sbarchiamo nella speranza di rifornirci di cibo. E una corsa
affannosa, ognuno vuole arrivare per primo. Vendono meloni a
quattro o cinque rubli; le donne sono drappeggiate di teli di cotone
rosso che avvolgono le loro alte acconciature a forma di tiara. Un
gigantesco turkmeno, con stivali di feltro e copricapo nero di
montone, squarta una pecora e infilza i pezzi di carne su uno spiedo
conficcato in terra.
Incrociamo un grande rimorchiatore e due chiatte.
Guardo le scie tracciate dalla poppa del battello sulla superficie
dell'acqua che assume i colori di un taffettà cangiante dal beige al
blu, talora gualcito dai gorghi.
Acqua e cielo si confondono dinanzi a noi che navighiamo verso
una meta lontana in fondo all'orizzonte.
Scalo a Dargan-Ata; mi dicono che a quattro chilometri da qui,
in un luogo imprecisato, si trova un borgo abitato dai russi. Lavrov e
io lo raggiungiamo a bordo di un caicco a motore che risale il fiume.
Siamo invitati a mangiare una coppia di fagiani da un idrografo di
ritorno da Tiuja Mujun, il quale ci comunica la cattiva notizia
dell'assassinio di un uomo a opera dei basmaci. È avvenuto un fatto
analogo anche nel sovhoz delle pecore, quell'edificio bianco sull'altra
sponda del fiume.
Durante l'inverno trascorso nella Sirte il nostro ospite ha potuto
constatare che molti kirghizi emigravano verso la Cina.
Sul Pellicano devo privarmi di parte del mio chinino per offrirlo a
uno degli studenti che ne è sprovvisto e ha la febbre. Il pilota, venuto
a saperlo, mi chiede di darne anche a lui in cambio di pane. Accetto
volentieri, dato che non ne assaggio più da quando ho lasciato
Bukhara.
Caicchi
Mi risveglio al grido di: «Un pesce!». Sulla spiaggia hanno alato una
rete dove si dibatte un enorme siluro, un animale verde e bianco
dalla testa arrotondata, chiamato som.
In mezzo al fiume si è incagliato un caicco; gli uomini
dell'equipaggio, scesi in acqua, spingono con la schiena contro il
fianco dell'imbarcazione. Passa un altro caicco i cui marinai remano
in piedi rivolti verso poppa, le pale sono semplici assi inchiodate su
pertiche. Da lontano i loro copricapi, i čugurma, appaiono come nere
punte di spillo.
Ma perlopiù si tratta di imbarcazioni a vela: talora ne scorgo una
ventina che navigano tutte insieme: trapezi di ogni dimensione
disposti in fila sulla liquida strada. Quando i meandri del fiume si
accentuano sembra quasi che, smarriti, essi vaghino sulle terre
basse.
Il caicco si accosta all'argine per issare la vela che viene prima
distesa al suolo. Gli uomini salgono sull'albero e si appendono a
grappolo sotto la drizza; il pennone si alza con il suo ampio telo
spiegato.
Se il vento forte spira costante i caicchi possono risalire la
corrente quasi alla medesima velocità del Pellicano .
Durante gli scali i marinai uzbeki vivono nella loro postazione di
prua, a cielo aperto. La scena, semplice e al contempo grandiosa,
evoca un passato leggendario da Mille e una notte.
A partire dal dritto di prua, la cui cima è ornata, a protezione
dalla malasorte, di una coda di cavallo, la parte prodiera del battello
è costruita su due altezze che scendono a mo' di gradini verso il
grande forno rotondo di terracotta.
Accovacciati a semicerchio sulla plancia, addossati ai fianchi
dell'imbarcazione, alcuni uomini avvolti nei loro mantelli imbottiti, con
il capo coperto dall'enorme čugurma dai lunghi e morbidi riccioli,
stringono tutti in mano una teiera. Il cuoco è indaffarato davanti al
suo forno a forma di arnia: in alto, nell'ampia camera di ghisa,
cuociono le frittelle di lapioška; dall'orifizio in basso spuntano alcuni
rami. L'uomo, armato di pinze enormi, estrae dalle braci un orciolo di
rame e, reggendolo per il collo, lo inclina sulle teiere che gli vengono
porte via via. Immobili e silenziosi, dignitosi come califfi, tutti
aspettano il proprio turno con la tazza in mano, sul cui fondo si
deposita una sabbia scura come cacao in polvere.
Vasili mi cede la metà delle sue copiose razioni di zuppa con
carne, di pasta o di patate. Vorrà forse farsi perdonare di avermi
perduto la pipa, dono di un grande navigatore che ora è all'altro capo
del mondo. Ne sono assai rattristata e gli prometto sei pipe nuove se
ritroverà la mia.
«Prima di andare a Dorgan-Ata me la sono infilata in tasca; ma
doveva esserci un buco, così è scivolata via...».
Gliela prestavo per sdebitarmi in qualche modo della sua
ospitalità.
Ci avviciniamo alla gola di Tiuja Mujun. Lavrov mi ha invitato a
fermarmi là con lui qualche giorno per vedere i lavori che sono in
corso in previsione dell'irrigazione di 30000 ettari di terreno; avrei
inoltre l'opportunità di visitare nei dintorni alcuni accampamenti
turkmeni. Si è anche offerto di procurarmi pane e farina, proposta
che non è da disprezzare.
Così quando Lavrov sbarca mi accingo subito a seguirlo, ma
non appena sono sulla passerella mi sento dire: «No, è meglio che
voi non veniate».
Che tipo stravagante! Avrà forse cambiato idea quando ha
capito che non gli avrei venduto a nessun prezzo il mio coltello?
Partita alla scoperta dell'isola Santa dove abbiamo fatto scalo,
schivati i falò, i canti e le fisarmoniche dei passeggeri, sono giunta a
un čapanno di canne nascosto tra il fogliame. Alla luce di una
lampada a petrolio mi è apparso un gruppo di turkmeni, uomini dallo
sguardo fiero, impressionanti sotto il loro copricapo nero. Al mio
arrivo tacciono. Saranno i quaranta ladroni di Alì Babà o sciamani
che discutono sulle loro magie? Intuisco che questo non è posto per
me, sicché decido di ritornare sul tetto della mia cambusa.
Una donna, proveniente dalle sue vacanze nel Caucaso, e che
gentilmente aveva diviso il suo pane con me, incontrandomi
esclama: «Questa notte mi hanno rubato la mia porzione! Ma se vi
fermate a Turtkul potrete comprarne quanto vorrete: là si trova di
tutto».
Parole sorprendenti, che sento per la prima volta, e che mi
spiegano finalmente il perché della corsa precipitosa dei passeggeri
verso la terra dei Karakalpachi.
Da queste parti si trova un'altura a forma di cono, legata a
Gengis Khan. La leggenda dice che attraversando la regione ognuno
dei suoi uomini doveva versare nel medesimo luogo la terra
contenuta in un cappello, e parimenti al ritorno dalle conquiste: in tal
modo l'“imperatore inflessibile”, confrontando i due cumuli, poteva
valutare quanti guerrieri aveva perduto.
Turtkul
Due tende in un campo di cotone: e il porto. Non è possibile
costruire nulla poiché l'acqua erode la falesia provocando
smottamenti di sabbia, accompagnati da sordi boati.
Un'arba mi lascia a due chilometri di distanza, sulla piazza
principale di Turtkul, dinanzi alla sede del governo. Spero che là
qualcuno mi indichi dove alloggiare.
«Stiamo allestendo una base di turismo, le sovvenzioni sono già
state approvate».
Chiedo all'impiegato informazioni anche circa la possibilità di
unirmi a una carovana diretta ad Astrahan o a Orenburg.
«Ma e pura follia! Da Kungrad o da Tašauz dovete preventivare
dai trenta ai quaranta giorni per raggiungere Orenburg, e per di più
al gelo. Voi non avete idea dei disagi di un viaggio a dorso di
cammello con una temperatura sotto i 30 gradi!».
In un altro ufficio, sempre situato nella medesima grande
piazza, vengo accolta con grande entusiasmo dal presidente della
Società del Turismo proletario, un giovane karakalpaco dai folti baffi:
«Voi siete la nostra prima turista! Una francese! Anzi, una parigina!».
«Che cosa significa “turista”?», gli domanda il segretario.
«Si tratta di... Avete i documenti? Tu, scrivi in quel quaderno:
Ella... No, stai attento, non lì: in quello spazio bisogna segnare le
destinazioni dei turisti».
Il segretario mi accompagna alla “casa del Dekkan”, la locanda
del contadino.
Il padrone è fuori; la giovane figlia mi comunica che non vi è più
un metro quadrato disponibile. In effetti i dormitori sono sovraffollati.
Crisi degli alloggi. Turtkul, un tempo Petro-Aleksandrovsk, conta 20
000 abitanti.
Ritorno infuriata all'ufficio: «Voi vi burlate dei turisti! Non avete
previsto nessuna sistemazione per loro! Perché mi fate perdere
inutilmente tempo prezioso? Firmatemi i buoni per pane, zucchero,
tè, olio, riso, e ripartirò immediatamente».
Un impiegato russo, calmo e determinato, interviene: «Venite
con me, ci sarà pure un posto per voi a casa mia».
Quando arriviamo ci accoglie la moglie, dopo poco rientra la
figlia da scuola; la zuppa è pronta.
Per dieci giorni sarò ospite di questa incantevole famiglia. La
donna tosta ogni giorno fette di pane per poi mandarle in una
cassetta al figlio, studente a Taškent. Ho deciso di fermarmi così a
lungo per avere il tempo di sviluppare le mie delicate pellicole, nel
timore che finiscano per deformarsi in sei mesi di continue variazioni
di temperatura. Ma fortunatamente scopro di essermi sbagliata.
Avendo trovato del rivelatore presso un architetto appassionato
di fotografia, passo le mie notti nella Casa del Popolo, quando la
camera oscura è disponibile.
Manca l'acqua corrente per lavare le pellicole: gli aryk sono a
secco in questa stagione. Devo andare in quei pozzi dove vi è
ancora acqua dell'Amu Darja, eccellente se si lascia depositare il
limo. Quella degli altri pozzi, limpida come il cristallo, è salmastra,
quindi non adatta alle mie necessità.
Per fortuna la luna illumina la cavità dai bordi scivolosi di argilla
bagnata.
Ma subito arriva il freddo, portato dal grande vento del KyzylKum, il deserto delle Sabbie Rosse, che strappa le foglie dagli alberi.
La gente si imbacucca fino alle orecchie. Ogni quarto d'ora provo a
riscaldarmi con energici esercizi di ginnastica. Ed è così che, presa
dal nervosismo per il terrore di sciupare i negativi, danneggio
irrimediabilmente il rollino della mia ascensione sul Sari-Tor,
perdendo quelle istantanee scattate a prezzo di eroici sforzi di
volontà. Raramente la mia dabbenaggine mi è pesata tanto.
Sovietismo
Per i grandi festeggiamenti della rivoluzione e stata innalzata una
pedana sulla piazza; su un arco di trionfo il profilo del dirigente
Vorosilof sovrasta la scritta: «Pronti al lavoro e alla difesa».
Inalberando stendardi e insegne giungono numerose
delegazioni di scuole, di uffici, di kolchoz. Tra la moltitudine dei neri
mantelli invernali risalta un curioso gruppo di donne indigene con il
capo avvolto da veli bianchi.
Il momento culminante della giornata sarà la sfilata di
duecentocinquanta arba e di millecinquecento cammelli carichi del
cotone che verrà scambiato con il grano.
Il presidente della repubblica è un karakalpaco intelligente; il
suo discorso, amplificato dall'altoparlante, è breve, incisivo: «La
socializzazione è appena avviata, ma i risultati sono già notevoli;
occorre perseverare, soltanto così si potrà vincere l'ignoranza
generale».
Si mescolano tra la folla russi e “nazionali”, ed è assai difficile
indovinare quali pensieri si celino dietro le fessure degli occhi di
questi ultimi.
Le bianche barbe fluttuanti degli anziani contrastano con i visi
glabri dei giovani, compunti e puliti. I copricapi meriterebbero un
attenzione particolare, dal topa ben calzato, sorta di zuccotto a
coste, all'enorme čugurma che con i suoi boccoli pendenti ricorda un
salice piangente. Si vedono kabardinka di astrahan grigio su fondo di
velluto e papakha sistemati a mo' di grossi cavoli; e ancora, su certi
visi dalla pelle scura, una sorta di tulipano rovesciato che si apre in
tre petali di folta pelliccia: le due mentoniere rialzate e la visiera
piegata all'indietro.
La distesa di sabbia inizia appena oltre le porte della città, ai
piedi delle mura merlate.
Un cammello sosta immobile presso la jurta dove ho avuto la
fortuna di essere invitata a bere il tè.
Il samovar luccica al sole; la donna porta anelli al pollice e
all'indice, dita con le quali regge la tazza. Il giallo dello scialle che la
avvolge contrasta con gli abiti e l'acconciatura assolutamente
bianchi. Il volto pieno dai lineamenti perfetti ha la levigatezza di una
prugna polposa.
Lo zuccotto del figlio è di broccato dorato ed è ornato di piccoli
sonagli e di un ciuffo di piume. Il bimbo ha paura, riesco a
fotografarlo soltanto quando il padre barbuto lo tiene fermo con la
forza. Al fondo di questa bella jurta, tutta foderata di košmu ricamati,
risplendono tre bauli ricoperti di lamine di ottone.
Sopraggiunge un giovane parente, comunista e studente
all'istituto pedagogico. È molto fiero di constatare, leggendo il
marchio di fabbrica del mio orologio, che entrambi usiamo il
medesimo alfabeto. Dopo aver preso le tessere del pane assegnate
alla famiglia si allontana.
Riunione dei karakalpachi
Interrompo talora lo sviluppo delle fotografie per vedere che cosa
succede nella grande sala vicina. È in corso una riunione dei
sindacati, a cui partecipano i giovani “nazionali” della città.
Durante i vari interventi gli astanti discutono fra loro ad alta
voce, e altrettanto rumoroso è il continuo andirivieni della gente che
arriva o che se ne va. Alla fine di ogni intervento - che è sempre
tradotto — o quando viene pronunciato il nome di Stalin, tutti
cantano qualche strofa dell'Internazionale.
Il mio vicino impedisce a un karakalpaco di fumare, ma davanti
a noi un russo accende impunemente una sigaretta arrotolata in
carta di giornale.
Chi ha concluso il proprio exploit oratorio torna a sedersi,
celando a malapena la propria soddisfazione.
Il fazzoletto rosso dei comunisti dona moltissimo ai piccoli
karakalpachi dai tratti giapponesi.
Quelli che vengono dal deserto
Al mercato è appesa ai ganci dei macellai una grande quantità di
carne che costa cinque rubli al chilo; con otto rubli è possibile
acquistare una libbra di burro, con uno tre lipioška e con trenta
copechi le patate. Ecco mucchi di grosse cipolle bianche, di meloni,
di pomodori, di spezie: Turtkul è veramente il paese della cuccagna.
Le fritture di pesce mandano odori appetitosi e invitanti; il
rosticciere di šašlik, protetto da un ampio grembiule con le maniche,
è circondato da clienti; l'aria è irritante e quasi manca il fiato per la
polvere di tabacco verde che si setaccia ovunque. Tutti lavorano
seduti sui talloni.
Alcuni uomini, ben allineati in fila, aspettano davanti all'emporio
della cooperativa per comprare calosce e fiammiferi. La teoria nera
dei loro berretti è interrotta dal feltro a punta bianco di un kirghizo
dagli occhi triangolari.
Le donne indigene inalberano turbanti altissimi; talora hanno la
narice trafitta da una piccola margherita d'argento. Si salutano
ponendosi prima la mano davanti alla bocca e poi vicendevolmente
sulla schiena l'una dell'altra.
I vecchi camminano tenendosi per mano.
Nella sua bottega il venditore di lipioška ha focacce esposte a
centinaia, ammonticchiate accanto a sé. Il forno, dalla bocca ad
altezza d'uomo, occupa un terzo della stanza buia. Un giovane
persiano dagli occhi neri vi infila con gesto rapido il braccio fino alla
spalla per sistemare la focaccia contro la parete; porta una tiara in
stoffa e si protegge il viso dal calore del fuoco con un fazzoletto
passato sotto il mento e legato sulla testa.
Il padrone dagli occhi gialli è un tagiko, mentre gli altri lavoranti
sono uzbeki. Nel retrobottega, su un treppiede poggiato a terra,
cuociono a fuoco lento alcune cipolle, coperte da un bel piatto di
ceramica verde pavone.
Dall'altra parte del mercato della legna — ove sostano i
cammelli dalle gambe a X carichi di contorte radici di saxaul - lo
spettacolo più sorprendente: innumerevoli arba con le loro ruote
gigantesche dai raggi piatti, e poi asini, cavalli, cammelli, tutti
posteggiati in quell'immenso garage asiatico.
Potente e rauco lamento dei cammelli, cui seviziano le narici
tirando la corda appesa al naso per costringerli ad accovacciarsi! I
piccoli, dal tenero manto vellutato, con le gobbe appena segnate da
due ciuffi di pelo scuro, poppano tranquilli; cammellieri e vetturini,
seduti sui talloni, conversano o mercanteggiano vicino ai loro sacchi
di semi; le grandi ruote delle arba si rispecchiano nitide nell'acqua
immobile di un lago di liquami; padri di famiglia passano reggendo
un bimbo sulle mani incrociate dietro alla schiena...
Ed ecco, splendidi e isolati, due re del deserto che si mostrano
a una corte di ammiratori, pestando il suolo con le zampe incatenate:
da entrambi i musi trabocca una schiuma compatta, come una sorta
di panna montata. La testa slanciata del dromedario è ornata da due
fieri pennacchi di lana, uno ben eretto sul naso non forato, l'altro
sulla fronte; dal caschetto si dipartono quattro file di pompon
digradanti che pendono lungo il collo. Sopra alle ginocchia ha delle
sonagliere e al collo, a mo' di ciondolo, una campanella. L'altra
bestia è un cammello enorme, massiccio, dal collo possente che
rovescia all'indietro alla maniera dei cigni; gorgoglia rumorosamente
lanciando al cielo getti di schiuma che gli ricadono sul gozzo, fiocchi
bianchi di bava spumeggiante. Ambedue hanno un alto pennacchio
issato al fondo della sella ricoperta da un bel tappeto. Dalle cinghie
che avvolgono il ventre pendono altri pompon.
Lontano, sui freddi corsi deserti soffia il vento: lugubre e
desolata periferia, defraudata anche di quella vita che anima le
vecchie stradine, altrettanto sporche ma calde di umanità...
Arrestata
Ho telefonato due volte al porto dove è previsto l'arrivo del Komunar
diretto a Kopalik, il porto di Novo-Urghenč, tappa obbligata per
raggiungere Khiva. Sono ansiosa di partire al più presto: se la
temperatura continua a scendere il lago d'Aral non tarderà a gelare e
di conseguenza sarà giocoforza interromperne la navigazione.
Mi reco al garage statale provvista di un foglio che mi dà diritto a
essere condotta al porto. L'autista non sente ragioni, manca una
firma. Sono furibonda, il tempo stringe!
Ritorno al Sovnarkom per risolvere la questione con il
segretario. L'uomo, di norma inappuntabile come un inglese, è
stremato e ha la barba lunga di tre giorni; che cosa mai gli avranno
fatto fare? Quando finalmente, chiarito l'equivoco, raggiungo la
sponda del fiume, è ormai troppo tardi.
«Non vi preoccupate», mi dice il cassiere, «è possibile che da
un momento all'altro parta una vedetta».
Decido quindi di fermarmi sul porto in modo da esserne subito
avvertita.
Alcune famiglie sono accampate sotto la tenda dei passeggeri. Il
freddo costringe tutti a raggomitolarsi sotto le coperte. Nel campo
strappo steli di sorgo per isolarmi da terra.
Mi preparo il tè; quando mi accingo a imburrare una fetta di
pane, la mia vicina tende la mano per chiedermi un pezzetto di burro
che scioglie nel palmo e poi spalma sui capelli, brillantina primitiva
che, a quanto sembra, è utile contro i pidocchi. Il suo piccolo piange.
Incessanti grida infantili, sempre identiche, come se ogni volta fosse
sempre lo stesso bambino a lamentarsi! Per indurlo a tacere, la
madre gli dà qualche scappellotto, facendo ancora più chiasso di lui.
A tutti gocciola il naso.
Vicino ai grandi caicchi ormeggiati i marinai hanno formato con
la vela una tenda conica sostenuta dai remi; mi offrono del tè e
posso finalmente riscaldarmi al calore del loro fuoco.
Un'anziana donna dal turbante avvolto in modo elaborato siede
accanto a me: un vapore denso, simile a una piccola nuvola, si
solleva dalla sua tazza. Gli uomini hanno l'aria di briganti bambini.
La notte è glaciale. Il vento scuote con colpi secchi la tela della
grande tenda.
Intorpidita dal freddo mi alzo tardi. Vedendomi entrare in ufficio,
l'impiegato esclama: «Mi sono dimenticato di voi: una piccola
imbarcazione a motore è appena partita. Ma c'è qui Danieletz, il
capitano del porto di Kopalik, che salperà a momenti».
Nel frattempo un'auto si è fermata. Ne scende un uomo che
dice: «Siete voi la straniera francese? Dovete seguirmi
immediatamente».
Non ho neanche il tempo di protestare che siamo già in moto.
«Ho le mie cose sparse ovunque... Gli utensili da cucina... e
soprattutto la macchina fotografica...».
«Telefonerò al porto perché radunino tutto».
Di che cosa sono colpevole? Se quell'uomo si preoccupa dei
miei bagagli significa che intendono trattenermi a lungo. Paura...
Se hanno deciso di dare prova di zelo, non sarà loro difficile
trovare un pretesto per accusarmi: le foto che non avrei dovuto
scattare, quelle dei basmaci o delle vedute aeree. E tutte le mie
carte rimaste laggiù! Avrò almeno distrutto gli appunti sui miei
incontri con i confinati?
Sono ancora troppo giovane, ho sbagliato per inesperienza.
Finalmente qualcuno mi spiega: «Perché non vi siete presentata
all'ufficio competente?».
«Ma io dipendo dalla S. T. P., dove sono stata registrata. Inoltre
ho frequentato questo edificio praticamente tutti i giorni e non
capisco per quale motivo non mi sia stato mai chiesto nulla!».
«Pensavamo che avreste trascorso qui l'inverno. Il vostro
passaporto è in regola, vi ricondurremo al porto».
Khiva
Una barca a motore scende infine il fiume e, prima di imboccare
un canale laterale, deposita Danieletz e me sull'argine, circa trenta
chilometri a valle. Aspettiamo. Passa un minuscolo caicco, stipato di
gente e mercanzie. Danieletz, il tipo di marinaio ben piantato, lo
chiama imperiosamente. Vi saliamo e filiamo a tutta velocità
trasportati dalla corrente.
«Con un po' di fortuna, se il freddo s'attenua, potrete arrivare a
Kantucjak per tempo. Dal 22 o 24 novembre sul lago d'Aral la
navigazione viene sempre interrotta. Tra cinque giorni il Lastočka
dovrebbe scendere l'Amu: questa è la vostra sola possibilità».
A Kopalik, immenso deposito a cielo aperto di sacchi e di fagotti,
affitto un'arba che mi porta per dieci rubli a Novo-Urghenč. Le piste
solcano un deserto sempre uguale e occorrono quasi tre ore per
coprire una distanza di dodici chilometri.
Mi faccio condurre presso il ricevitore postale, un uzbeko
incontrato sul Pellicano che si era offerto di ospitarmi. Sono contenta
di poter evitare, grazie a lui, il caravanserraglio dove bisogna tenere i
propri beni sotto stretta sorveglianza.
A casa sua si vive secondo gli usi uzbeki, cioè mangiando e
dormendo per terra. La giovane moglie ha morbide trecce, pantaloni
lunghi infilati in stivaletti; è timida, non conosce il russo e i suoi bimbi
non si staccano mai da lei. Mangia dopo il marito e versa sul
pavimento il tè rimasto al fondo delle pjala. La grossa stufa
scoppietta bruciando il panello dei semi di cotone, compresso in
sottili tavolette che si rompono come mattoni. L'uomo, padrone e
signore, dorme sul letto.
L'indomani l'arba della posta parte per Khiva e io mi isso sui
grandi sacchi di cuoio pieni di corrispondenza, pronta a percorrere
trentacinque chilometri in quella strana posizione. Appena fuori
dall'importante centro di Novo-Urghenč si distende una campagna
grigia e monotona, ingiallita dal löss.
Le fattorie hanno muri simili a quelli che si vedono in Africa, con
grandi motivi geometrici incisi nel pisé (Impasto di sassi, paglia e
fango), che imitano, a intervalli regolari, larghi pilastri rotondi.
Gli aryk sono a secco. Molte squadre sono al lavoro per ripulirne
il letto. Lì accanto giacciono smontati i čighir, macchine simili alle
norie per sollevare l'acqua mediante una ruota munita di una serie di
tazze. Quando sono in funzione, l'asino gira intorno alla piattaforma
rotonda spingendo il braccio che fa salire quattrocento litri d'acqua al
minuto. La grande ruota e i suoi orci rotti ora sono sparsi per terra.
Quando due arba si incontrano sulla strada dai solchi profondi è
impossibile indovinare quale delle due cederà il passo. Talora esse
si bloccano all'ultimo istante, una di fronte all'altra, e il tiro che ha più
fretta devia verso la scarpata. Ci fermiamo per permettere al cavallo
di bere; la terra intorno all'imboccatura del pozzo è coperta da una
dura crosta di ghiaccio. Un karragaš secolare protegge un mazar, il
luogo di sepoltura; tre piccoli mausoléi si innalzano sulle tombe
comuni, le loro cupole sono sormontate da una lucente palla verde,
simile al pomo dell'albero maestro.
A metà giornata facciamo una sosta sul ciglio della strada per
prendere il tè. I carrettieri si accovacciano silenziosi intorno al
focolare della čajkana.
Melanconia di un arido autunno sotto un sole bianco. Nei campi
stanno raccogliendo il cotone, gli steli delle piante sono secchi e
senza foglie. Un grande forno di mattoni che fuma, i piloni del T.S.F.,
delle mura: ecco Khiva. Nel cortile dell'ufficio postale mi rivolgo al
giovane capo, un russo, per domandargli dove abita il conservatore
del museo, che spero acconsenta a ospitarmi per due giorni.
«La sua casa è piuttosto lontana. Inoltre è un uzbeko e non
parla il russo. Forse vi converrebbe fermarvi da me...».
Accetto volentieri la sua proposta. Conoscerò più tardi sua
moglie, una donna dal carattere allegro e scherzoso, che si occupa
del loro bambino e serve con grazia il tè.
Entra un impiegato delle poste, un tedesco con la barba a punta
e gli occhi azzurri. Accorgendosi del mio stupore, mi spiega: «Siamo
una colonia tedesca insediata ad Ak-Mecet da cinquant'anni e
originaria della Repubblica del Volga. Ho un fratello ricoverato
all'ospedale, quel grande edificio di fronte, per un'itterizia; anche sua
figlia è malata, ha la polmonite. Se voleste fotografarla potremmo
avere un ricordo di lei nel caso non guarisse. Mio fratello, che è
contabile, ha seguito studi di teologia e talvolta presiede alle nostre
riunioni di preghiera: siamo mennoniti».
Attraversiamo la strada. Nel cortile dell'ospedale la cooperativa
ha aperto un chiosco per il personale. Dopo due controlli assai
severi accediamo a un'anticamera dove posiamo i cappotti per
indossare un camice bianco.
Il signor Quiring è a letto, ha i baffi e un volto affilato; la fronte
alta ed emaciata mi ricorda quella di Romain Rolland. La bimba, dal
piccolo ovale incorniciato di soffici capelli biondi, è sofferente,
risponde a fatica. La madre, una donna vivace, cura i due malati; I
suoi denti risplendono candidi e gli occhi sono grigi e gravi, la fronte
ampia è ornata da un diadema di spesse trecce bionde.
«Noi tedeschi non possiamo certo lamentarci, abbiamo buoni
impieghi e guadagnamo bene. Dovreste visitare la nostra colonia a
quattordici chilometri da qui».
«Mami, quando vedremo le foto?».
«Bisogna aspettare che la signorina abbia concluso il suo
viaggio, deve andare lontano, ancora più lontano di Berlino».
La donna veste la figlia, le annoda i capelli con una garza a
guisa di nastro. Mi preparo a scattare e finalmente la piccola sorride
al mio invito di mostrarmi quanto bene vuole alla sua mamma; le
passa le braccia attorno al collo stringendola forte.
Alla scoperta
Per evitare una recidiva di arresto mi annuncio alla Ghepeu prima di
avventurarmi alla scoperta di Khiva, la città degli usignoli.
Nella cinta di Nurulla-Bai, riservata ai personaggi importanti, si
innalza tra imponenti filari di neri karragaš la dimora relativamente
moderna dell'ultimo khan, le cui buie sale coperte di legno dipinto
sono ora adibite a biblioteca pubblica, su un piedistallo, splende il
marmo candido di un busto di Lenin, di fronte troneggia un
altoparlante fissato a una colonna.
L'harem, fortezza merlata, è circondato da mura con torrioni. Un
tempo, nei suoi innumerevoli cortili, dove eleganti pilastri sostengono
alti balconi e logge, si annoiavano nell'attesa le ottanta mogli del
khan. L'edificio è attualmente la sede dell'istituto pedagogico.
Mi domando quale casa abbia ospitato il capitano Burnaby, che
era oggetto di grande curiosità da parte di tutta la popolazione,
stupita della sua stravagante abitudine di mangiare con forchetta e
coltello. Questo succedeva a metà del secolo scorso. Sembra che
un abitante di Khiva, tentando di imitarlo, si fosse trafitto la guancia
con la forchetta non sapendo come maneggiarla! Del resto, perché
meravigliarsi quando persino noi conosciamo l'uso delle posate
soltanto dal tempo di Luigi XIV?
Mi aggiro senza meta per le stradine tortuose e segrete. Come
a Bukhara, anche qui prevale l'impressione di abbandono, ma con
qualcosa di più selvaggio, di più chiuso.
Si para dinanzi a me l'enorme minareto incompiuto di Madamin
Khan, cono mozzato dove brillano piastrelle di maiolica disposte a
strisce incrociate e sovrapposte. L'edificio a fianco è una famosa
madrasa, la cui visita, mi dicono, potrebbe interessarmi moltissimo.
Ma sopra la porta, ben sorvegliata, leggo “Domzak”: è la prigione.
Parlamento invano.
Madamin Khan, nemico dello zar, fu tradito da un turcomanno e
morì pugnalato nel 1855. Portarono la sua testa allo scià con tutti gli
onori riservati agli Achemenidi, i primi Samanidi.
La schiavitù fu abolita nel 1873. Si calcola che in quegli anni vi
erano in tutto il territorio del Khorezm — o più esattamente Khorzem,
da khor, “spregevole”, e da zem, “tribù” — circa 50 000 schiavi di
guerra su una popolazione di 5 - 600 000 abitanti. Al mercato uno
schiavo russo, di buona costituzione, valeva ottanta tilla, circa sedici
franchi di allora, di schiavi russi ve ne erano 5000. Le donne
persiane erano preferite a quelle russe.
Nel cortile severo di una madrasa lavorano i tintori: le loro
tinozze squadrate sono ricavate da un grande pezzo di cuoio.
Mi fermo incuriosita nel sentire un sordo ronzio; attraverso la
feritoia di una casa scorgo un asinello dalla groppa appuntita che,
con gli occhi bendati, gira in una stanza trascinando la macina per la
farina.
Salgo in compagnia di tre studenti sulla sommità di un minareto
dalla forma di un immenso camino, dove mi appare a ovest, oltre
l'oasi, il deserto di Kara-Kum, le Sabbie Nere. Vista da questo lato, la
città ha l'aspetto di una scacchiera: i bianchi riquadri dei tetti sono
intervallati da quelli scuri dei cortiletti. A nord invece si innalzano
moschee e madrase.
Ai miei piedi brillano i mattoni d'oro del mausoleo di Paluan Ata,
“il Potente”, che fu un campione di lotta ma anche un erudito, grazie
ai lunghi anni di studio passati in India. Davanti all'iwan d'ingresso si
apre un cortile di forma regolare, contornato da celle; al suo interno
vi è un pozzo, un albero e un grosso gatto. Sui tetti circostanti, dove
cresce persino un albero coperto di stracci votivi, sono ammassate
alla rinfusa, tra le aste chiamate bunčuk, tante tombe, simili a ceppi
imbiancati dalla polvere.
Ancora una madrasa, questa volta occupata da un artel di
tessitrici armene, riconoscibili dallo scialle posato sul copricapo
piatto. Che pena! Con le dita rigide e violacee per il freddo intenso
devono stare sedute tutto il giorno davanti al loro telaio, fissato sopra
di una cavità scavata nel suolo di ogni cella. Le pareti rimandano gli
echi dei colpi di battente; una donna sospira e poi riprende il suo
canto. Mi allontano.
La costruzione più sorprendente è senza dubbio il Dash Hauli,
la “casa di pietra” un tempo harem del khan. In due delle sue sale è
stato allestito un museo dove sono stipati oggetti di ogni sorta
lasciati dai principi. Anche se qui non si trova la grande rana di
ceramica ornata di un cappello a cilindro, come a Shir Budum, il
palazzo d'estate dell'emiro di Bukhara (il donatore doveva certo
essere un gran burlone!), vi è in compenso un vasto campionario di
armi, abiti, ritratti, strumenti di tortura.
Le pareti del cortile principale, con il pozzo al centro, sono
coperte da pannelli smaltati; al primo piano, otto verande di legno
scolpito. Attraverso un corridoio a volta, dove si avverte l'odore della
legna che un boscaiolo sta tagliando in una delle stanze, si giunge al
primo cortile che presenta sulle tre facciate una serie di ampie logge
sopraelevate, anch'esse di legno scolpito e dipinto. La quarta parete
è un immenso peristilio alto due piani, dal tetto a cassettoni
affrescati, sostenuto da sottili colonne di legno, gonfie alla base.
Tutte le pareti sono ricoperte di motivi smaltati. L'insieme è di
un'opulenza e di una ricercatezza tali da rendere questo luogo
indimenticabile.
Ho di nuovo l'illusione di essere capitata in un palazzo delle
Mille e una notte, tale è il tripudio di decorazioni che si offre al mio
sguardo.
Al centro di questo cortile di quindici metri di lato si innalza una
pedana circolare a cui si accede tramite quattro gradini: qui viene
allestita la jurta riservata agli ospiti di riguardo. Anche nel Medioevo
gli uzbeki mantenevano l'uso della jurta nelle città che costruivano.
Segue un secondo cortile, altrettanto straordinario. Mi fermo,
immobile e commossa dinanzi a quell'assoluto splendore.
Immaginate di tappezzare un palazzo di classici broccati stile
Impero, completate l'opera con ornamenti assortiti e avrete solo una
pallida idea dell'incanto emanato dai muri di questi cortili deserti,
dove il silenzio è interrotto soltanto dal tubare di una colomba. Mi
ritornano alla mente le parole di René Grousset: «... per il mongolo
nomade il lusso consisteva nell'applicare parati e tessuti ricamati alle
pareti della sua tenda. Quando fissò la sua dimora volle che i suoi
palazzi e le sue moschee gli restituissero con le loro decorazioni di
ceramica la stessa sensazione».
I tedeschi di Ak-Mecet
In sella a una bicicletta provo l'ebbrezza della velocità
pedalando nelle vie di Khiva, sfioro i rumorosi calderai, metto in fuga
i bambini, mi allontano dal suk coperto scampanellando, faccio alte
acrobazie per evitare i solchi profondi della carreggiata. La gente mi
guarda ammirata e sono fiera di me come se fossi io il geniale
inventore di questo mezzo di locomozione.
Esistono tre sole biciclette a Khiva e, fortuna insperata, alla
posta un russo ha accondisceso a prestarmi tale preziosa rarità. Tutti
gli impiegati, schierati sotto le teste di Lenin e di Stalin, hanno
assistito alla mia partenza, curiosi di vedere se la straniera era
veramente in grado di servirsene.
Supero una fila di scolari guidati da due indigene, attraverso una
porta delle mura per dirigermi a sud, verso Ak-Mecet, la seconda
oasi, dove vive la colonia tedesca.
Mi raccontano alla posta: «Forse voi non lo sapete, ma essi
hanno le loro feste, e in quelle occasioni inaspettatamente li vediamo
comparire vestiti con i loro abiti più belli. Ogni tre giorni vengono al
mercato a vendere il burro e la frutta che essi stessi producono.
Quando si sono insediati nel paese hanno però dovuto promettere al
khan di non allevare maiali per cinquantanni!».
«Sono fortunati: ricevono pacchi di riso e di medicinali dalla
Germania».
Campi inariditi, fattorie come fortini, piste ingombre di detriti di
aryk. Pedalo da un bel po': per due volte mi sono illusa di essere già
arrivata, ma soltanto ora intravedo in lontananza, dall'altro lato del
deserto, un verdeggiare di alberi.
Le ruote affondano nello spesso strato di sabbia, slitto e mi
affanno inutilmente. Il metodo migliore è quello di mantenere la
massima velocità fino al momento dell'inevitabile caduta. Intorno a
me scorgo grandi distese coperte di sale, candido come neve fresca.
Arrivo in un bagno di sudore, ma mi rallegra l'idea di poter parlare fra
breve con degli europei. Mi dirigo verso una fattoria, una bella
costruzione circondata da pioppi ormai ingialliti, ingentilita da
bianche tendine alle finestre. Sento qualcuno dire: «Maria, wer
kommt dort?». («Maria, chi c'è?».)
Domando in tedesco a un giovane dove abita Otto Theuss,
aspettandomi un moto di stupore dal mio interlocutore. Invece nulla;
discreto, grave, biondo sotto il berretto di pelliccia, mi indica un
gruppo di abitazioni di cui scorgo soltanto le aie. Alcune mucche si
dissetano a una fontana al coperto, custodite da un uzbeko. Due
ragazze si occupano di me, trattandomi con timidezza. Nitore
ovunque: il secchio colmo d'acqua, il catino bianco con accanto
sapone e asciugamano, il tavolo da cucina, il forno di mattoni, tutto è
pulito, anche ogni più remoto angolo della casa.
«Eh sì», mi dicono, «qui occorrono lavori continui! Il pisé è da
riparare ogni anno: si spacca, si sbriciola e lascia passare l'acqua».
Entro nella stanza in compagnia delle ragazze che hanno lasciato i
loro zoccoli sulla soglia. Un grande tavolo, delle panche, una
credenza di campagna, due zie con gli occhiali sul naso che
lavorano a maglia sedute su rigide poltrone. Su un tavolinetto è
posata la «Vossische Zeitung», che impiega diciotto giorni per
arrivare fin qui. Le anziane signore non nascondono la loro sorpresa:
«Siete venuta in bicicletta? Da sola? Ma non avete paura?»
«Ah, prima eravate nel Kirghizistan! Anche noi proveniamo da
quel paese. Abbiamo lasciato Aulje-Ata dove per noi la vita stava
diventando troppo difficile. Dal Volga spesso ci raggiungono alcuni
parenti, attualmente la nostra colonia si compone di ben
trecentoquaranta persone. Dobbiamo stringerci per far loro posto».
«Leggevo in effetti in un libro di Ali Suavi che in virtù del suo
isolamento Khiva è sempre stata una terra di rifugio. La vostra
colonia, così ben organizzata, sarà probabilmente di esempio ai
vostri vicini uzbeki».
«Nient'affatto, il nostro modo di vivere li lascia indifferenti. Essi
non hanno bisogno di tutti quegli oggetti per noi indispensabili. Per
esempio, con la nostra famiglia è vissuto due anni un turkmeno, un
ragazzo intelligente che alla fine parlava il dialetto platt-deutsch
proprio come uno di noi. Ebbene, prima di andarsene confessò di
ritenerci persone assai buffe e di non capire per quale ragione
sprecassimo tempo e fatica per lavare tre volte al giorno stoviglie,
coltelli e forchette quando un unico piatto era più che sufficiente!».
La cena è pronta, ci sediamo. Otto Theuss recita ad alta voce
una breve preghiera durante la quale ha la delicatezza di ricordare
anche la straniera di passaggio.
Tra loro conta soltanto l'età. Persino i figli sposati parlano con
toni sommessi, sbirciando il padre. Ritorno all'infanzia e conto fino a
sette prima di porre domande, masticando lentamente per non finire
prima degli altri. Mangiamo uova alla coque, fette imburrate di pane
nero, accompagnate da un caffellatte. Il miele è riservato ai più
anziani. Tutti hanno visi onesti, puliti, cosparsi di efelidi; le fronti
ampie e squadrate mostrano quell'ostinazione che ha salvato il loro
gruppo cinquant'anni fa.
Le donne portano i capelli acconciati in due trecce raccolte in
chignon, con la riga in mezzo.
«Sì, sono soddisfatta del mio viaggio. A Karakul e a Turtkul, le
città più lontane dalla ferrovia fra quelle che ho visitato, ho
riscontrato le migliori condizioni di vita».
Il mio ospite si confessa preoccupato per il destino dell'Europa,
di cui legge notizie poco rassicuranti sul suo giornale tedesco e non
posso che essere d'accordo con lui.
«Sembra che gli uomini si incitino vicendevolmente a
commettere errori...».
«Ogni giorno ringraziamo Dio di non aver permesso che
dimenticassimo i nostri principi...».
Otto Theuss è minuto, ha occhi azzurri e baffi rossicci, un cranio
ossuto e calvo. Sembra una persona decisa, pratica. Mi decido infine
a confessargli la mia ignoranza circa la loro dottrina.
«I mennoniti sono membri di una setta anabattista fondata dal
riformatore olandese Menno Simonsz all'inizio del XVI secolo. Essa
si oppone alla violenza, alla guerra e alle autorità civili. A Zurigo e a
Basilea raccolse subito molti adepti. Nel mondo ora siamo circa
mezzo milione. Abbiamo tre principi basilari: non toccare nessun tipo
di arma; non giurare mai perché il nostro sì è sì; ricevere il battesimo
solo dopo esser stati istruiti e aver creduto.
«In tempi passati il re di Polonia ci fece venire dalla Frisia per
bonificare le paludi di Danzica; in seguito, dopo la rivoluzione del
1848, poiché il servizio militare era diventato obbligatorio per gli
abitanti della Prussia, un centinaio delle nostre famiglie chiese asilo
allo zar. I nuovi arrivati poterono appoggiarsi alle colonie prussiane
già insediate in Russia e inoltre, grazie all'esistenza della ferrovia,
portare con sé i propri attrezzi e le proprie masserizie.
«Ma la nostra migrazione verso est non era ancora conclusa.
Venimmo infatti informati che nel 1881 anche la Russia avrebbe
imposto il servizio militare. Incoraggiati dal generale Kaufmann,
governatore del Turkestan, che ci prometteva terre garantendoci al
contempo la libertà, lasciammo la Repubblica del Volga il 3 luglio
1880, diretti a Taškent. Altri diecimila mennoniti partirono per
l'America.
«In quel periodo a Uralsk si poteva comprare una pecora per un
rublo e mezzo. Durante il viaggio patimmo disagi e fatiche
innumerevoli. Coprivamo soltanto quattro verste all'ora... E ad
Aktjubinsk finì l'avena per i nostri cavalli. Per attraversare il deserto
fummo costretti a smontare i carri e a caricarli su quattrocento
cammelli. Guardate i montanti di quella porta, in realtà sono delle
stanghe.
«Trascorremmo l'inverno nei pressi di Taškent e alcuni di noi si
stabilirono a Aulje-Ata. Nel 1881 Alessandro II venne assassinato e
Kaufmann fu colpito da un infarto senza che nulla a nostro riguardo
fosse stato fissato per scritto.
«Decisi a chiedere asilo all'emiro di Bukhara, ripartimmo
passando per Samarcanda. Durante il percorso abbiamo avuto
modo di conoscere gli strani usi di coloro che vivono nelle jurte,
meravigliati nel vederli nutrirsi di carne di cammello o servirsi tutti di
un'unica scodella. Abbiamo visto scuoiare le pecore soffiando sotto
la pelle di una zampa, metodo che certo favorisce la diffusione dei
microbi.
«I bek locali non erano d'accordo con l'emiro, e alla fine fu
Asfendjar, khan di Khiva, a concederci le terre.
«Il khan aveva bisogno dei nostri carpentieri, abili nel levigare
legni e palchetti. Informato da questi ultimi che i turkmeni ci avevano
rubato cavalli e mucche, egli inviò un gruppo di gighit perché ci
proteggessero. Fu proprio in quel periodo che ci venne assegnata
Ak-Mecet, una zona ricca di albicocchi: ve ne erano ben
centotrentanove.
«Il khan e i dignitari erano uzbeki; abusando del proprio potere
essi tagliavano talora, a monte dell'Amu Darja, l'acqua di irrigazione
destinata ai turkmeni che rispondevano a quel sopruso con razzie è
incursioni».
Incontro con il maestro
Quando mi alzo non vedo più nessuno: sono tutti al lavoro. Dopo
avermi offerto la colazione, che consumo da sola, una ragazza mi
accompagna dal vecchio Riesen.
Case basse si affacciano sui quattro lati della piazza che me ne
ricorda altre, viste in Prussia. I piccoli giardini, cinti da muri, hanno
ognuno due pioppi a guardia della porta d'ingresso; i montanti
bianchi delle finestre danno una nota di gaiezza.
«Che nomi sono di moda adesso in Germania? Sapeste come
tutte noi vorremmo avere nomi diversi dai soliti Gretchen, Luisa, Eva
Rosa, Dorotea...».
Le suggerisco Brigitte o Marlene.
Emil Riesen, l'anziano maestro di scuola, ha occhi azzurri assai
belli, una lunga barba, ma neanche più un dente. È il depositario di
un intero mondo di ricordi: tutti gli avvenimenti di un periodo molto
particolare della loro storia.
«Gli inizi sono stati difficili, siamo arrivati qui senza un soldo. Al
mercato vendevamo per ottanta copechi piccole lanterne fatte da noi
e poi calze, maglioni... Uno dei nostri riparò il fonografo del khan, il
quale ci commissionò anche quei mobili decorati con piccole
immagini che tanto gli piacevano. Conoscendo l'uzbeko toccava
sempre a me occuparmi delle questioni ufficiali. Per l'incoronazione
di Nicola II, il khan Seid Muhamed Rahim mi volle con lui come
interprete a Mosca, dove affittò un palazzo da trecento rubli al mese.
Ricordo che quando la zarina gli domandò che cosa pensasse di
Mosca, egli rispose di sentirsi più a proprio agio in quel “buco” di
Khiva. Era, a dire il vero, poco più di un contadino intelligente,
contrariamente a Ispendal, che aveva costumi simili ai nostri e
poteva stare alla pari con gli zar».
Riesen mi mostra una serie di fotografie dei dignitari di corte,
splendidi nei loro khalat di broccato.
«Il khan preferiva noi ai suoi sudditi e quando dovevamo
comparire a corte ci offriva abiti adatti. Era pronto a pagarmi assai
bene se avessi acconsentito a diventare musulmano».
In una delle foto appare una fattoria americana: incuriosita,
chiedo spiegazioni.
«È la casa di mia sorella nel Kansas; anch'io ho abitato là per
sei mesi dopo esser stato deportato ad Angora: mi avevano
accusato di spionaggio per conto della Germania e fui liberato alla
caduta di Kerenskij».
Mentre chiacchieriamo la moglie, una dolce vecchietta, riempie
il mio tasčapane di biscotti all'anice, invitandomi a servirmi senza
complimenti anche di quelli nel vassoio posato sul tavolo.
Nella casa vicina le donne filano con un grande arcolaio.
Il centro della piazza è occupato da due semplici edifici
squadrati in pisé, con le finestre bianche: sono la scuola e la casa di
preghiera. La chiesa, come sperduta in questa repubblica sovietica,
è commovente nella sua luminosa solitudine. File di sedie, separate
da un corridoio che porta a tre gradini: là, sullo sfondo del muro
imbiancato a calce, si innalza un pulpito nero. Sul leggio intravedo
una scritta: «Herr! Hilf mir!». («Signore! Aiutami!».)
Un armonium, un bel candelabro, null'altro.
«Non abbiamo un pastore, sicché a turno uno dei nostri fratelli
legge e commenta la Bibbia».
Nella scuola mi accoglie un piacevole calore. Le ragazze
occupano una metà della classe, i maschi l'altra. Alle pareti sono
appese carte geografiche e la stampa di un piroscafo della Hamburg
Amerika Linie. Scorgo anche un mappamondo e una lavagna tra le
due finestre.
Gli allievi si alzano quando entriamo e intonano un cantico per
poi riprendere la lettura di un racconto biblico. I libri sono sempre gli
stessi da vent'anni; le piccole dita scorrono sul testo seguendo riga
per riga, ma Elisa è colta in flagrante delitto di disattenzione.
Al pari di tutti i mennoniti di Ak-Mecet, la fisionomia del maestro
è un misto di gravità e di onestà. Quale sarà il futuro di questa
comunità, in cui ognuno è di aiuto all'altro?
Ho dovuto arrivare fin nel cuore del Turkestan per capire la forza
della probità e la disciplina di una fede...
Corsa contro il gelo
Da Khiva telefono a Kopalik dove si trova Danieletz: il Lastočka
non è ancora arrivato. Malgrado inciti senza sosta l'arbakeš alla
guida della mia carretta, raggiungo Novo-Urghenč soltanto a notte
inoltrata e devo così dormire a casa dell'impiegato postale.
All'indomani mattina, quando sto per partire, mi accorgo che il
mio ospite è scomparso e con lui il mio coltello! Avevo rifiutato di
venderglielo spiegandogli che ne avevo bisogno; temevo inoltre che,
se glielo avessi ceduto, l'avrebbe mostrato vantandosi di averlo
ottenuto in ricordo dei favori della straniera: era furioso e non mi
rivolgeva più la parola dopo che, essendo io più forte di lui, ero
riuscita a sfuggirgli.
Malgrado abbia una gran premura di andarmene per non
perdere il battello, mi affanno invano a cercarlo in tutte le čajkana
della città. Come ultima risorsa vado alla polizia a dichiarare il furto
lasciando il mio recapito di Mosca.
Proprio nel momento in cui mi accingo ad arrampicarmi sulle
ruote dell'arba, l'uomo compare all'improvviso. Lo investo con mille
rimproveri.
«Ma credevo che me lo aveste regalato! Eccolo qui, il vostro
coltello, non era il caso di fare tanto chiasso!».
L'arbakeš procede a piedi davanti al cavallo tendendogli piccoli
ciuffi di erba medica. Quando sono finiti la commedia continua, ma
questa volta con steli secchi di sorgo. L'uomo mi domanda se ho
ancora del pane nella sacca e mangia con lentezza il pezzo che gli
offro.
Al porto, mi preparo all'attesa. Mi sistemo in prima fila contro un
argano, sulla gabarra degli uffici. In una baracca vicina è posato su
un banco un enorme piatto di pirožki. Un ragazzo entra, si serve e se
ne va, e così un uomo e poi due ragazzine bionde... Non resisto alla
tentazione e faccio come loro.
Una donna dagli occhi azzurri e con uno scialle nero in testa
ritorna camminando lentamente: è a lei che ho rubato quelle squisite
frittelle di patate.
Chiacchieriamo mentre faccio il bucato.
«Mio marito è medico a Kopalik; io ho la malaria, sono sempre
stanca».
Porgendomi il vassoio mi invita a servirmi se ho fame, e io non
oso confessarle il mio furtarello di poco prima.
«Questa notte potete dormire da noi, sulla panca; fuori è troppo
freddo. Mio figlio si sistemerà sul tavolo dell'ufficio».
Tutti mi sconsigliano di scendere il fiume verso settentrione, il
gelo è prossimo. Non ho che quattro o cinque giorni per raggiungere
Kantucjak, devo perciò rinunciare al mio progetto di visitare Kunja
Urghenč, l'insabbiata. Mi imbarcherò dunque al più presto per la
traversata del lago d'Aral. Se decidessi altrimenti dovrei invertire il
mio cammino e non so risolvermi a ritornare sui miei passi. A ovest
la strada per Astrahan attraverso il deserto in questo momento non è
sicura, hanno appena assalito e disperso una carovana di
cinquecento cammelli che trasportava zolfo.
Occupiamo questa minuscola baracca in cinque, senza contare
due cagnetti e un gatto. Le due panche, una di fronte all'altra,
servono da giaciglio ai genitori e ai due figli. È indiscutibile, soltanto i
poveri sanno essere tanto generosi con gli estranei.
Finalmente appare il Lastočka, con tre giorni di ritardo; quattro
dei suoi passeggéri vogliono, come me, andare ad Aralskoie More.
Il dado è tratto. Mi imbarco. Il ritorno sarà impossibile: presto il
gelo impedirà alle imbarcazioni di risalire il fiume.
Prendo posto sulla plancia di prua di un battello in avaria,
rimorchiato dal Lastočka che è al completo. Siamo in una decina,
tutti coricati sui due piani delle panche. Intorno a noi è buio, i
finestrini sono chiusi da assi, una tavola di compensato ci separa
dalla sala macchine fuori uso. Regna il silenzio in questa sorta di
zattera della rassegnazione. E presto capirò il perché.
Gravato di tale peso morto, il Lastočka perde velocità e governa
male; attraversando le rapide in prossimità del promontorio procede
di traverso, finché con un brusco urto ci incagliamo; l'ormeggio
posteriore salta e il nostro rimorchiatore non ha la potenza
sufficiente a tirarci fuori di là. Nella notte glaciale ognuno sparisce
sotto le proprie coperte.
Al mattino, grazie ai movimenti dell'acqua che ha liberato lo
scafo dalla sabbia, riusciamo a salpare. Che sollievo vedere
scomparire i pali di segnalazione dietro di noi! Ma la tregua è di
breve durata. La nostra “zattera” è a rimorchio con la barra attaccata
ma la corrente ci fa sbandare e “tocchiamo” violentemente per due
volte; il cavo salta e siamo di nuovo fermi. Il Lastočka inverte la rotta
per venire a prenderci ma a sua volta si blocca. Nervosismo a bordo;
i marinai si inarcano sulle pertiche, sembra che finalmente il battello
si muova e invece gira solo su se stesso. Scoraggiamento generale.
Il freddo della notte è terribile. Per fortuna siamo riusciti ad
aprire il serbatoio del motore per prelevare del petrolio con cui
alimentiamo due grandi fornelli che ci permettono di scaldarci un po'
e di preparare il tè. Ci assopiamo, ma presto il gelo intorpidisce
naso, mani e piedi che dobbiamo frizionare vigorosamente.
Due uomini sollevano alcune assi dal pavimento, posano una
lastra di ferro sul fondo umido e scivoloso della stiva, divelgono i
mancorrenti del ponte e accendono un fuoco che ci rianima. Gli
sciacalli ululano fra i canneti lungo l'argine, popolato forse anche da
tigri.
Uniche attività possibili: sputare e arrotolare sigarette con un
pezzo di giornale. Iniziamo a mercanteggiare pagnotte di pane. Offro
a un'anziana coppia che non ha nulla da inzuppare nel tè qualche
galletta di Turtkul.
Si affiancano tre pescatori su una bejdarka, un canotto piatto, e
ci portano in salvo. Ripartiamo pieni di speranza. Coprendomi con
tutto quanto possiedo mi metto alla barra — un pezzo di ferro
spezzato — decisa a evitare con ogni mezzo una seconda e fatale
guizzata. Poco dopo Tagi Murad, un marinaio del Lastočka, viene a
darmi il cambio.
Durante il viaggio vendo un chilo di riso a due giovani dall'aria
sveglia incaricati di fare il censimento della popolazione di Čimbaj.
Non sarà facile il loro lavoro con gli indigeni, che, per il timore di
dover pagare più tasse, omettono spesso di denunciare tutti i
membri della famiglia; o al contrario dichiarano anche quelli già morti
quando ritengono che si voglia conoscere il loro numero per le
assegnazioni della cooperativa.
Un vecchio soldato, un veterano dai grandi baffi, che aveva
comandato uno squadrone contro i basmaci di Kunja Urghenč,
racconta come i suoi uomini siano morti nel deserto per mancanza
d'acqua nel vano tentativo d'inseguire i ribelli. I basmaci sono
imprendibili grazie ai loro cavalli, i cui zoccoli larghi, mai ferrati, non
sprofondano nella sabbia.
Egli mi spiega che “kirghizo” in lingua tagika significa “nomade
delle steppe”, escludendo l'etimologia fantastica che fa risalire il
nome a kirk, quaranta, e kiz, vergini. La leggenda narra, infatti, che
un ricco signore aveva quaranta figlie, ma, dato che il kalim per
comprarle doveva essere proporzionale alla sua ricchezza, nessuno
si presentava per sposarle. L'uomo allora le abbandonò in un bosco
dove incontrarono una banda di briganti che domandarono loro chi
fossero. «Le quaranta vergini», esse risposero.
Alla mattina, mentre ancora mi impigrisco dentro il sacco a pelo,
Tagi ci manda a sbattere in piena velocità contro la sponda. Lo
schianto dello scafo è tanto forte da dare l'impressione che ci stiamo
aprendo come una noce. Vinta dalla corrente violenta, la barra non
ha più tenuto la rotta.
Sfido il freddo e battendo i denti rimango accanto a lui,
determinata a non fare la fine del topo, intrappolata nei miei pesanti
vestiti, in questo fiume ghiacciato.
Siamo in prossimità di un monte, il Sultan-Baua, meta famosa di
pellegrinaggi.
Kipšak, a lungo sospirata, si annuncia con l'apparire di un
vulcano merlato, immenso kurgan.
Breve scalo, giusto il tempo di correre alla stazione radio al
fondo di un polveroso cimitero e di sapere che Kantucjak non ha
ancora dato notizia della chiusura della navigazione.
Lungo le rive del fiume si distende un melanconico paesaggio di
case abbandonate prossime a crollare insieme con le loro falesie
erose dall'acqua. Sul greto, cammelli e barili d'olio. In mezzo alle
catapecchie d'argilla e paglia risalta la prigione imbiancata a calce.
Scivoliamo davanti a lagune già coperte di un sottile strato di
ghiaccio.
I due scafi si incagliano simultaneamente. È una fatalità.
Nessuno reagisce. Con i pantaloni rimboccati che scoprono magre
ginocchia dell'indefinibile colore del fiume, il komandir ci raggiunge a
piedi portando un cavo irrigidito dal ghiaccio.
Il capitano è del paese e sa come tenere a bada l'acqua
capricciosa, sempre sfuggente, sempre presente. Ordina una
rotazione, la corrente colpisce la prua; sul ponte noi corriamo da un
lato all'altro perché il fondo si distacchi dal letto; nell'acqua, il
komandir fa leva per correggere lo sbandamento... Ci disincagliamo
di botto e la scossa impressa dal nostro movimento libera il
Lastočka.
Per via di terra
Nel grande porto di Kodjeili, distante duecento chilometri da
Kantucjak, iniziano le ramificazioni del delta. Siamo accolti dal
giovane komsomol kazako che, non per sua volontà, era rimasto a
terra a Kipšak. Per raggiungerci ha dovuto comprare un cavallo che
ancora trema, madido di sudore. Quando era ancora con noi molti si
divertivano a sue spese ponendogli domande trabocchetto sul
comunismo, a cui egli non poteva rispondere conoscendo male il
russo. I passeggeri vanno al mercato della città, a quattro chilometri
dal porto. Io mi dirigo verso il gabbiotto della radio, sotto i grandi
piloni. «Kantucjak è chiusa. Il Komunar, ultima possibilità rimasta, è
partito ieri». Già sognavo le comodità che mi avrebbe offerto quel
cargo misto: un buon sonno al caldo di una cuccetta, un bagno
ristoratore! Che fare?
Scettici, i miei compagni di viaggio decidono di continuare la
discesa del fiume. Se la notizia corrisponde a verità sverneranno
laggiù aspettando il disgelo.
Ripeto loro gli argomenti del telegrafista che mi hanno convinto:
«Dovete tener conto che Aralskoie-More è seicento chilometri più a
nord e che nevica già!».
Nella cabina riscaldata dell'equipaggio del Lastočka pago il
tratto da Kopalik, ventun rubli per centoquarantacinque chilometri a
bordo di quella cella frigorifera.
Il secondo tiene i conti aggiornati su un quadernetto di scuola e
li fa firmare all'impassibile komandir. Vedendo che il padrone di un
grosso cargo lì accanto offre una carpa al veterano, chiedo di
poterne acquistare una anch'io.
L'uomo mi invita a seguirlo. È simpatico, così minuto nei suoi alti
stivali, con quegli occhi scintillanti di vivido blu.
Sulla riva è accatastata una montagna di balle di cotone.
Indicandomele, egli mi dice: «Che peccato, ai primi giorni di nebbia
si ammuffirà tutto e andrà perduto!».
Il casseretto del cargo è nascosto da filze di pesci salati, messi
a seccare. Nell'Amu vive un pesce straordinario, lo skaferingus , che
ha un suo uguale soltanto nel Mississippi.
Mi informo su quale direzione devo prendere per raggiungere
una linea ferroviaria.
«Ma perché non andate a Čimbaj, sul grande canale, dove
troverete delle carovane per Kazalinsk? Passando per il deserto
occorrono circa quindici giorni».
«Sarebbe l'ideale per me. E molto caro?».
«In estate costa di norma ottanta rubli, ma in questa stagione
occorre procurarsi una šuba e un paio di valenki, perché senza
pelliccia e stivali di feltro potreste anche morire di freddo se il buran
si mette a soffiare. Inoltre dovete comprare almeno cinque chili di
pane nello spaccio qui vicino. Ecco il padrone che ne esce proprio
ora».
Nukus
Čimbaj è sull'altra sponda del fiume. Mi dicono che all'estremità del
porto potrò trovare un traghettatore. Cammino lungo piramidi di
sacchi di grano; sull'argine sono incagliate alcune imbarcazioni, delle
bejdarka.
Domando ai marinai lì accampati se vanno a Čimbaj, ma mi
rispondono di essere diretti dalla parte opposta, verso Tasau.
Sulla sporgenza di una spiaggia alcune carriole staccate dal tiro
sono in attesa di non so che; le bejdarka approdano qui dopo la loro
traversata, il cui percorso disegna un accento circonflesso. Esse
navigano aiutandosi con una vela a punta, inserita su una sottile
antenna. Quando si sale a bordo bisogna rompere il ghiaccio del
pavimento.
Sull'altra sponda, il nulla... Ah, sì, un uomo imbacuccato in una
pelle di montone che prega piegando la testa fino a sfiorare la
sabbia. Lo supero senza che si accorga di me; ora la sua sagoma si
delinea sullo sfondo incandescente del tramonto.
A ogni passo affondo nel terreno molle, così, quando dietro una
duna mi appare un'arba, non me la lascio sfuggire. Dopo tre
chilometri siamo al villaggio di Nukus.
Chiedo all'arbakeš di lasciarmi alla čajkana e di venirmi a
riprendere all'indomani mattina per condurmi a Čimbaj. Nella stanza
scura e fredda tre o quattro persone sono sedute in silenzio.
Mi reco dall'impiegata della posta, nella speranza di poter
finalmente passare a casa sua una notte confortevole.
«Non posso ospitarvi», mi dice, «dormiamo già in quattro in una
camera minuscola. A Nukus non ci sono più alloggi per la grande
affluenza di operai che arrivano da ogni parte: sembra che qui sia in
progetto la costruzione di una città».
Aggirandomi nella čajkana vedo una porta, la apro e un'ondata
di calore mi investe. All'interno della stanza: una lampada a petrolio,
un tavolo, libri, giornali, e un profumo di carne che cuoce a fuoco
lento su una stufa. Chiedo ai due giovani che si trovano là se posso
riscaldarmi un momento.
Mi invitano gentilmente ad accomodarmi ponendomi mille
domande: da dove vengo, dove sono diretta, come mi procuro il
cibo...
Sono due geometri incaricati di fare il catasto della regione dei
Karakalpachi.
«Forse già sapete che Turtkul è destinata a scomparire nel giro
di due o tre anni, per via dell'erosione del fiume».
«Ma perché l'acqua scava soprattutto a est?».
«Le ragioni non sono chiare. Saranno i venti dominanti o la
rotazione della terra. Si è reso comunque necessario correre ai
ripari: con un concorso, è stato scelto un progetto per una città di
200 000 abitanti che verrà costruita in questa zona, a duecento
chilometri a nord di Turtkul. Il costo previsto è tra gli 80 e i 180
milioni. Sarà un'opera grandiosa. Per il momento è in cantiere
soltanto l'ospedale».
«Da dove prenderete il materiale necessario?».
«Il legname per le impalcature proviene tutto dall'Ural; occorre
dunque trasportarlo per via d'acqua, attraverso il lago d'Aral».
Invitata a cenare con loro, mangio senza ritegno avvalendomi
del pretesto che presto dovrò affrontare il Kyzyl-Kum; la vodka
svolge poi il suo effetto salutare.
Si accorgono che non possiedo un cappotto.
«In effetti, durante i miei spostamenti finora mi sono protetta
infilandomi dentro il sacco a pelo e spero di trovare una šuba al
bazar di Čimbaj».
Uno dei due, un giovane barbuto e con occhi innocenti, mi offre
la sua: «È troppo lunga e pesante, non la metto mai; ne ho un altra
più piccola che preferisco. Il freddo qui non è così pungente come
nei luoghi che avete intenzione di visitare».
«Ma non potrò pagarvela; non so ancora quanto mi costerà il
viaggio in carovana».
«Non importa, mi invierete il denaro quando l'avrete rivenduta,
non vale più di una sessantina di rubli».
Verso il nord sconosciuto
Salgo sull'arba arrampicandomi con qualche difficoltà sulla
ruota, intralciata dal mio nuovo cappotto di pelle di montone, ma poi,
avvolta dal suo calore, ripenso con gratitudine alla bontà di quel
giovane.
Mai mattino della mia vita mi è apparso più bello. Vorrei
inventare un grido che sappia esprimere un sentimento tanto
intenso.
Partire è per me come rivivere. Tutto ricomincia, vado incontro
al nuovo, all'ignoto. Il sole si alza ed è la medesima sfera rossa che
ieri tramontava. L'aria scintilla di mille goccioline di brina sospese e
io procedo attraverso una realtà più bella di qualsiasi straordinaria
magia.
E tuttavia, quanto mi è costato oltrepassare la porta del
Lastočka e girare la schiena a quella calda cabina!
Il mio arbakeš è simpatico e non risparmia l'animale. Dietro ai
mobili riccetti neri del suo čugurma ne intravedo lo sguardo franco,
rassicurante.
Un tratto di deserto lungo quarantacinque chilometri ci separa
da Čimbaj. La grande ruota di destra lascia cadere su di me la
sabbia sollevata nella corsa. Quando il terreno della pista diventa
troppo molle, il vetturino, un karakalpaco, mi fa segno di scendere e
di proseguire a piedi.
A mezzogiorno, giunti nei pressi di un gruppo di casolari dove
non riesco a vedere campi coltivati, mangiamo dei šašlik. Il
rosticciere prende una lipioška con la quale agguanta quegli spiedini
fumanti, e tirando libera le punte di ferro lucide di grasso.
Riprendiamo il nostro monotono cammino. Per permettere di
bere al suo cavallo bianco, l'uomo lo stacca quando siamo vicini a
un canale: a colpi di tacco apre un buco nel ghiaccio che imprigiona
l'acqua. Pare che gli indigeni si opponessero alla costruzione di
questo canale rettilineo, convinti che l'acqua, per scorrere bene,
dovesse essere nascosta.
Non vi è più una čajkana aperta. Al Sojustrans si rifiutano di
darmi alloggio dato che l'ufficio è chiuso. Vedo di fronte il
Sojusarbakeš, che comprende un cortile dove trovano riparo i tiri e
una stanza adibita di giorno a ufficio e di notte a rifugio per gli
indigeni. Dormono sulle panche mentre un fornello scalda
brontolando l'acqua in una brocca di rame.
Siamo accolti con assai scarso entusiasmo: il mio gentile
carrettiere non è iscritto al sindacato, e il prezzo di trentacinque rubli
che mi ha richiesto è inferiore alla tariffa corrente. Mi sistemo anch'io
sul bancone aspettando il mattino. L'indomani mi reco al
Raispolkom, dove un indigeno mi informa con grande cortesia che i
cammelli partono da Tahtakupyr, quaranta chilometri più a est.
Non ho dunque un minuto da perdere se voglio arrivare in
giornata. Il cavallo di cui ho bisogno tarda ad arrivare; inoltre non si
trova il cassiere che deve firmare la ricevuta dell'avvenuto
pagamento da parte mia dei quarantacinque rubli pattuiti per il
tragitto.
Di pessimo umore per tutti questi contrattempi, rifiuto di pagare
in anticipo: non voglio ritrovarmi alla mercé di questi maledetti
arbakeš, per conoscere i quali sono pagata.
Non sentono ragioni e sono costretta a cedere. Protesto per il
cavallo che mi sembra già sfiancato e ribadisco la mia assoluta
necessità di raggiungere Tahtakupyr prima di sera, dato che
altrimenti perderò la carovana in partenza domani.
Il cassiere mi assicura che arriverò in tempo.
La strada è buona, non si sprofonda e procediamo al trotto, ma
ecco che, appena fuori città, il cavallo rallenta l'andatura. L'elegante
arbakeš che mi è stato assegnato porta un incredibile berretto di
pelliccia e velluto rosa. La sua insolente indolenza mi irrita oltre ogni
dire, lo bersaglio continuamente di critiche sprezzanti. Se pensa che
per mettere il suo ronzino al galoppo gli debba una ricompensa, fa
male i suoi conti.
Intorno a noi si distendono melanconici campi di cotone, dove la
raccolta è quasi terminata.
A metà pomeriggio, passando in prossimità di un borgo, il mio
vetturino accenna all'eventualità di prendere un tè. «D'accordo, ma
in fretta. Tahtakupyr è ancora lontana».
In un cortile, dove vi sono due jurte da cui esce del fumo, mi
indirizzano verso una grande stanza di almeno otto metri per quattro.
Alcune stuoie per terra, un piccolo forno di latta, ed è tutto.
Nella lunga attesa del té vedo entrare l'arbakeš carico di tutti i
miei bagagli! Protesto vivacemente ripetendogli più volte che non ho
nessuna intenzione di fermarmi in quella sorta di dormitorio: «Voglio
essere portata in serata a destinazione, ti ho già pagato per questo.
Se sarà necessario affitterò un cavallo».
Alla fine devo rassegnarmi: inutile perdere la propria dignità
quando le possibilità di ottenere un qualsiasi risultato sono nulle.
Un filetto di carpa frigge nella mia padella; bastano pochi legni
secchi per far crepitare il piccolo forno che diventa subito
incandescente.
Giungono a cavallo due eleganti coppie di karakalpachi e
sostano un momento per bere una tazza di tè; hanno ancora infilato
al polso il loro kamča, il frustino dal manico cesellato. Calzati di
stivali di feltro, gli uomini indossano un čapan di lana di cammello e i
loro copricapi rassomigliano a fiori pelosi dagli enormi petali; le
giovani mogli hanno mantelli di pelliccia e scialli di seta.
Emigranti
Al calar della sera arrivano piccoli gruppi di persone che percorrono
a piedi la strada diretta a sud. Si siedono per terra, slegano le fasce
che, sapientemente intrecciate, servono loro da calzature e si
frizionano i piedi stanchi. Dalle bisacce estraggono ciotole di legno,
subito riempite di piccoli, rotondi semi dorati.
Me ne offrono da assaggiare: è miglio tostato che si mangia
bagnato nel tè. Il mio vicino, che è un russo, mi dice di provenire da
Kazalinsk.
«Allora siete passato per il deserto!».
«Sì, sedici giorni di traversata con un asino, che ho pagato
laggiù centoventi rubli e che ora non ne vale più di sessanta».
Gli domando se la sua bestia non affondava nella sabbia.
«La neve, ormai prossima anche qui, aveva indurito la pista».
«In questa stagione perlomeno è» risolto il problema dell'acqua:
non occorre più cercare i kuduk, i pozzi di acqua salmastra. E ora,
dove siete diretto?».
«Approfitto delle vacanze per comprare del grano che poi
rivenderò nel nord a un prezzo due volte maggiore».
Un'unica lampada fumosa rischiara a malapena la stanza che si
sta riempiendo via via. I nuovi arrivati non sanno dove sistemarsi; tre
bambini, in piedi, si nascondono tra le pieghe della gonna materna.
Poi li conducono altrove.
Stanca di ascoltare parole per me incomprensibili trovo un
angolino e mi addormento. Mi risveglio un istante, il tempo di vedere
la serva che distribuisce scodelle colme di plov fumante, di cui
ciascuno si ciba immergendovi le dita.
Sempre nel cuore della notte, mi sembra di udire un sordo
tramestio: qualcuno si sta infilando di nuovo quella sorta di stivali e si
prepara a riprendere il suo vagabondaggio.
Quando mi alzo sono circa le otto ed è ancora buio; sono sola e
l'arbakeš sta attaccando il cavallo. Come al solito sollevo il cuscino
per prendere gli scarponi da montagna che utilizzo come capezzale.
Sono spariti! Disperata, frugo inutilmente tra tutte le mie cose.
Ispeziono poi la stanza, operazione assai facile dato che è vuota.
Nella camera vicina alcuni gruppi di persone dormono ancora.
Interrogo irritata la locandiera che diffonde la notizia: la scomparsa di
un paio di stivali è un fatto notevole in un paese dove le vere
calzature rappresentano un bene raro.
Sarà stato il carrettiere? No, la sua sorpresa non è una
commedia; nondimeno è su di lui che si abbatte il mio furore: «E
tutta colpa tua! Avevi soltanto da far trottare il tuo cavallo! Io non
volevo dormire qui».
Più che l'irreparabile perdita, mi esaspera il dovermi piegare alla
volontà di questo imbecille.
In sé la situazione è piuttosto comica: in pieno inverno sono
costretta a camminare nel Kyzyl-Kum in calzette!
No, questo non è ancora pieno inverno, lo sarà quando avrò
raggiunto Kazalinsk, prima della fine di dicembre: allora la
temperatura scenderà a 35 gradi sotto zero. Andiamo, bisogna
partire e andare più svelti, molto più svelti. Mio caro arbakeš, non
credere che abbia pagato il tuo plov di ieri alla mardjia della čajkana.
Sabbia, cespugli, aryk a secco, cammelli carichi di rovi e di
legna secca, un lungo cammino disseminato di basse catapecchie. E
finalmente arriviamo.
Tahtakupyr
Al comitato esecutivo del settore, al Raispolkom, il segretario Bai
Muhamedov mi ascolta con interesse. Un berretto rosso incornicia il
suo bel volto da mongolo: «Fra tre giorni ci sarà il mercato e forse
avrete qualche possibilità di trovare una carovana diretta verso nord,
anche se in inverno le probabilità sono poche. Proprio questa
mattina è partita una famiglia per raggiungere Kazalinsk, dove
abita».
Ah! Lo sentivo che dovevo arrivare ieri.
Il segretario telefona alla cooperativa per informarsi se hanno
valenki da vendermi, ma purtroppo non ce n'è più un paio.
«Nuovi costano sessanta rubli, ma talvolta al mercato se ne
trovano d'occasione».
Entrano ed escono di continuo persone avvolte in pellicce
altrettanto monumentali della mia, di pelle conciata color sabbia e
con un triangolo di stoffa cucito all'altezza della nuca: è un amuleto.
Un russo mi osserva, stretto in quell'immenso mantello di lana
color kaki usato dai veri bolscevichi.
«Se non sapete dove alloggiare», mi dice, «potete venire da
me. Ho una piccola stanza che divido con il mio gighit, dove però ho
appena fatto installare una piacevole stufetta di mattoni».
Salvo che nella via principale, le case sorgono a caso, lontane
le une dalle altre, sullo sfondo di un orizzonte sempre piatto e
desolato. Ho l'impressione di trovarmi al centro di una terra alla fine
del mondo e ne sono turbata.
Il russo che mi ospiterà ha occhi gialli, scintillanti, e un viso
butterato dal vaiolo. È il responsabile dei trasporti, si trova qui da sei
mesi con il compito di accelerare lo smaltimento del cotone secondo
tempi e prezzi stabiliti al momento della produzione. Nel cortile della
sua casa alleva due tacchini e li ingrassa per il 1° gennaio. Allora la
vendita del cotone sarà terminata ed egli potrà tornare a Turtkul,
dove vivono i figli e la moglie che, a suo dire, è bellissima e ha
conseguito diplomi di ogni tipo.
L'una di fronte all'altra vi sono due stanze: a sinistra vive la
famiglia di Mustafà, giovane komsomol, a destra il russo. Muri
spessi, una piccola finestra, un tavolo, due pagliericci poggiati su
cavalletti e un buon fuoco che scoppietta. Il gight, l'interprete di
Kiseljov, è un caucasico che conosce bene il paese. I muri di terra
sono coperti di manifesti dai colori crudi: giallo, rosso, azzurro; uno
raffigura un'indigena del Turkestan in una filanda; in un altro, alla
guida di un trattore, una donna contribuisce alla realizzazione del
“Piano quinquennale in quattro anni”.
Fuori, accanto al riparo costruito per la mucca, vi è una sorta di
bugigattolo dove vivono due donne; una ha la testa avvolta da un
turbante e lunghi orecchini, la seconda è a letto malata: non la vedo,
ma la sento tossire di continuo dietro il sacco vecchio che pende a
guisa di porta. Pare che i kazaki siano soliti lavare con l'acqua gelata
i neonati nei primi quaranta giorni di vita. Che questa usanza duri o
meno tutta la vita, è chiaro che quella povera inferma non si è
ancora abituata al freddo.
La madre di Mustafà ha l'aria da gran signora con il suo
turbante ornato di una gala che le inquadra il mento. E debole
perché digiuna ormai da giorni: in questo mese cade il Ramadan.
Nella casa vivono anche il fratello maggiore Safa, dai baffi
spioventi, la moglie e, nella classica culla, un bimbo, coccolato da
tutti. Per l'intera giornata girano a mano una piccola macina che
frantuma i semi di giugara per ricavarne farina.
Ho chiesto loro di cuocermi un po' di patate e la vecchia mi ha
domandato che cosa fossero: non ne conosceva l'esistenza.
Trascorro sei giorni a Tahtakupyr in preda a un'ansia terribile. I
cammelli sono scomparsi dal villaggio. Ve ne sono cinquecento
sparsi nella regione, tutti mobilitati per caricare cotone o legna di
saxaul. Da Kyzyl-Orda, la vecchia capitale del Kazakistan, sulla linea
ferroviaria di Taškent, hanno mandato quaranta cammelli
richiedendo del pane, ma il soviet di Tahtakupyr ha rifiutato di
fornirlo.
Finalmente ne vedo tre nel villaggio e mi precipito ad avvisare
l'ufficio del Sojustrans che ha promesso di interessarsi al mio caso
non appena ci fosse stata una partenza per il nord. Anche Mustafà
s'informa da tutti. Prendo contatti con un intermediario che dice di
sapere dove si potrebbero trovare due animali. Arriva l'uomo che
dovrebbe procurarmeli, vuole venti rubli di caparra... Fissiamo un
appuntamento a cui non verrà. Kiseljov costringe il mediatore a
rimborsarmi.
Alla sera vado spesso a trovare la dottoressa. «Sono arrivata
nel 1929 con mio figlio», mi racconta, «ero allora la prima donna
europea mai vista qui. In media visito una sessantina di persone al
giorno. È facile curare i kazaki, anche se per l'80 o 90 per cento
sono malati di sifilide. La vita sotto la jurta comporta purtroppo la
diffusione di questa infezione».
Le dico di avere una siringa Record e alcune fiale di
Neosalvarsan che vorrei vendere, dato che temo di non avere
sufficiente denaro per acquistare il mio biglietto quando sarò a
Kazalinsk.
«Se sono in buono stato ve le comprerò, benché, in realtà, ne
sia già provvista».
«Ricordo che due anni fa vi era un'assoluta mancanza di tali
medicinali. Questi sono intatti, li ho portati con me in previsione del
duro viaggio attraverso la Mongolia».
Mustafà ha trovato per quaranta rubli un paio di stivali
scompagnati. Ora nulla più mi differenzia da un vero kazako: come
loro sono più larga che lunga e quando mi aggiro fra la folla
polverosa dell'assordante bazar mi sembra di essere anch'io uno di
quegli strani materassi che si spingono l'un l'altro.
Dal macellaio, ben ritto dinanzi alle sue grandi carcasse
impalate, compro per quattro rubli un chilo di carne di cammello, che
taglio a pezzi e cuocio prima che geli e diventi duro come la pietra.
Con sette rubli mi procuro un chilo di grasso di montone, in
sostituzione del lardo che da queste parti non esiste. E poi pane,
biscotti, tè, urjuk secchi. Finalmente ho tutto quanto mi serve. Là, in
un chiosco della cooperativa, ho visto venti casse tutte identiche che
contenevano un articolo introvabile a Mosca: calze di seta! Quale
strana politica avrà fatto arrivare qui quelle casse, relitti arenati in
una sorta di landa africana misteriosamente glaciale?
Mi domando se di notte nel deserto, per sentire meno il freddo,
gli uomini si corichino accanto ai cammelli, malgrado i parassiti che li
invadono. Già mi immagino sballottata durante il viaggio in uno di
quegli enormi nidi di feltro fissati al dorso dei cammelli, la cui insolita
sagoma mi aveva colpito vedendo una carovana nei pressi di
Turtkul...Ma devo stare soprattutto attenta a non lasciar trasparire la
mia scarsa dimestichezza con le traversate invernali nel deserto,
altrimenti rischierei di vedermi rifiutare il passaggio.
Finalmente un kazako mi annuncia che suo fratello partirà alla
fine del giorno di mercato, mi conviene dunque tenermi pronta.
Questa volta Mustafà vuole che l'uomo gli lasci in pegno il proprio
cappotto, ma il kazako si rifiuta assicurandoci di essere una persona
onesta.
Per un ultimo addio al brulicante mondo asiatico, che ora lascio
definitivamente, ritorno nella confusione del bazar. Ogni personaggio
che incrocio potrebbe essere Inkižinof, l'eroe mongolo di Tempeste
sull'Asia; chi di loro porta nascosta nell'amuleto la prova della sua
discendenza da Gengis Khan?
Nella stradina che conduce al terreno incolto dove c'è il bazar
donne accovacciate vendono yogurt, frittelle, peperoni; una di
queste, con il suo mucchio di riso in mostra sul fazzoletto, porta
l'anello d'argento di tutte le indigene. Glielo compro per quattro rubli,
cioè a un prezzo pari alla spesa giornaliera per le lipioška. Per
pagare apro la pesante pelliccia, sollevo giacca e maglione di lana e
infine raggiungo la tasca. Rientrata a casa, distante appena cento
metri, scopro di non aver più il portafoglio: l'avrò certo fatto cadere
nella polvere credendo di rimetterlo al suo posto; non è possibile che
qualcuno sia riuscito a rubarmelo sotto tanti indumenti!
Per fortuna vi erano soltanto quindici rubli dato che avevo
suddiviso il mio capitale riponendolo in più posti. Ma con orrore mi
ricordo che l'ultimo scomparto conteneva trentacinque dollari, la mia
riserva per Mosca e Berlino.
La donna che mi ha ceduto l'anello è sparita; del portafoglio
nessuna traccia. Chi mai capirà che quei pezzi di carta verde sono
soldi? Finiranno nel fuoco poiché in ogni caso nessuno qui potrebbe
cambiarli. Avevo anche la serie completa dei francobolli per posta
aerea, acquistati per mio fratello, e tre negativi dell'enorme pesce
issato sul greto dell'Amu.
Vado alla polizia e pago un banditore affinché annunci a colpi di
tamburo che una ricompensa di quaranta rubli verrà data a chi
riporterà la bustina di cuoio contenente carte straniere. Ma la sorte
mi è avversa: un enorme cammello è già nel nostro cortile ad
aspettarmi. Ho preteso con così tanta insistenza una partenza
immediata e marce notturne, che ora non posso più tirarmi indietro.
Il basto del cammello è una sorta di spessa trapunta ovale,
fissata a due grossi bastoni posti lungo i due lati delle gobbe.
Bisogna sedersi sui sacchi con i piedi sui due bastoni orientati in
direzione del collo e tenersi ben saldi quando il grande animale si
alza con un brusco movimento.
È tempo di lasciare Tahtakupyr, le dico addio issata su quel
cammello condotto da un kazako.
Ogni nuova partenza è un bagno di gioia.
Ma subito dopo quel piacere intenso si stempera in un senso di
ansietà per le difficoltà che forse mi riserverà il futuro.
Cinquecento chilometri nelle Sabbie Rosse
Puntiamo verso nord, presto raggiungeremo il resto della
carovana. Piste ben battute solcano un paesaggio coperto di rovi.
Alcune donne scendono lungo la diga del grande aryk gelato,
reggendo sulle spalle la traversa di legno alle cui estremità
dondolano due secchi. Le chiazze rotonde indicano i posti dove il
ghiaccio è stato rotto.
Tre jurte nere sono piantate in modo da formare un triangolo nel
cui centro il mio grande cammello si accovaccia per essere liberato
dal suo carico e io smonto. Ormai è notte. Asmetali mi ospiterà.
La figlia Anna lavora una pasta spessa di farina di giugara
sbriciolandola poi nell'acqua bollente di un paiolo; la sorellina
Tojbacar è assai giovane ed elegante con la sua graziosa collana di
dodici monetine e i suoi orecchini. Asmetali è un vecchio rinsecchito
e rugoso come un saxaul, ha uno sguardo inquieto e tre fili di barba
sul mento. Il figlio è silenzioso. Nurman, il genero, anch'egli minuto,
ha un viso rotondo e gentile.
Il vecchio e io abbiamo il privilegio di servirci da una ciotola in
cui sono mescolate carne e pasta. A guisa di dessert mi offrono una
porzione di un miscuglio di prossa, la farina di miglio, e farina di gida,
una piccola bacca dalla buccia liscia bruno-dorata, dalla polpa
bianca, dolciastra e inconsistente come quella dei funghi.
Levatisi la šuba, gli uomini la distendono vicino al fuoco per
inginocchiarsi e pregare. Infine ci corichiamo e dormiamo tre ore.
Verso mezzanotte iniziamo i preparativi per il viaggio.
Le tre bestie, montagne accovacciate tra le jurte, vengono
caricate di sacchi in lana di cammello colmi di semi.
I lunghi rami secchi posti sopra le jurte per proteggerle dalle
raffiche di sabbia e dalla neve imminente le fanno apparire nella
notte come giganteschi ricci.
Appendono un secchio, alcune pale; non occorre sprecare
parole: sono sempre i medesimi gesti che si ripetono prima di ogni
partenza. Qui, come sul mare, si consuma l'ultimo pasto, si dorme
per l'ultima volta a casa propria prima di affrontare la traversata:
chissà quali imprevisti ha in serbo per noi?
Ci avviamo in silenzio nella brezza pungente: sopra di noi un
cielo di stelle cadenti.
I cammelli procedono lenti. A ogni loro passo il mio busto oscilla
avanti e indietro: per frenare questo movimento incurvo la schiena
cercando di rimanere più ferma possibile in modo da non disperdere
quel bel tepore che ancora mi accompagna.
Di tanto in tanto è necessario scendere per riscaldarsi
camminando, duecento metri sono sufficienti. Essendomi fermata un
momento dietro un cespuglio, affretto il passo per raggiungere i miei
compagni: l'oscurità della notte ha però inghiottito non soltanto le
loro sagome ma anche il suono della campana.
Chiamo... Tutto tace. È come se la mia voce venisse subito
inghiottita da quell'immensità. Secondo le stelle la direzione che
prendo è giusta. Taglio le piste, dato che non ne seguivamo
nessuna. Mi invade un brivido di terrore.
Chiamo ancora. Mi pare di udire una flebile risposta di cui mi è
impossibile individuare la provenienza. Accidenti! Prometto che mai
più perderò di vista i cammelli! Eccoli, immobili, appena un po' più
neri della notte.
Asmetali dice che verrà a piantare la sua tenda qui, dove vi è
abbondante sterpaglia per il fuoco. Il giorno si alza grigio per poi farsi
rosso, oro e, infine, bianco. Latrati, fuochi di jurte lontane; sul terreno
ancora qualche traccia di aryk.
Lasciamo la boscaglia per raggiungere sulla sinistra una lunga
collina di sabbia ai cui piedi vediamo alcune tombe sante. Un
cavaliere ci supera, sta ispezionando le sue trappole per le lepri.
Procediamo ora tra dune ondulate o marezzate come pelli di
daino, finché ci fermiamo al riparo di un anfratto per consumare il
nostro pasto. Il vecchio si siede liberandosi degli stivali; Abuish, il
figlio minore, raccoglie fasci di sterpaglie, tanto secche da spezzarsi
come vetro; sono intrise di sale e bruciando emanano un odore acre,
amaro, come di farmacia. Con una mano Nurman munge la
cammella reggendo con l'altra un recipiente di legno.
Riprendiamo il cammino attraverso laghi prosciugati, dalla
superficie screpolata, screziata di verde. Uno stormo di cigni si alza
in un immenso battito d'ali. Corazze di testuggini e miriadi di
conchiglie rosa coprono il fondo chiazzato di rosso di uno di quei
laghi.
Sarà per questo che il Kyzyl-Kum è chiamato il deserto delle
Sabbie Rosse?
Ci teniamo lontani dalle grandi piste, quelle che si dice siano
battute dai basmaci. La strada sarà più lunga ma in compenso
troveremo legna per il fuoco.
E così andiamo, giorno dopo giorno, incrociando talora orme di
cammelli, losanghe gemelle. A notte fonda sostiamo. Abuish
scompare per ritornare dopo un bel po' con la lunga corda e il suo
secchio pieno di acqua salmastra, magnesiaca. Come è riuscito ad
orizzontarsi e a trovare il kuduk, il buco d'acqua? Il tè che
prepariamo risulta vomitevole. Una mattina, dopo estenuanti ricerche
nella cavità di una duna, scopriamo finalmente un kuduk sui cui bordi
ghiacciati convergono numerose tracce di kazaki, i quali
pazientemente immergono in quelle fosse un secchio dopo l'altro,
subito svuotati, o meglio aspirati, dai cammelli. Anche noi facciamo
bere le bestie; ciascuna consuma un centinaio di litri d'acqua,
l'equivalente di circa venti secchi. Riempiamo in seguito molte
enormi borracce poiché domani potremo contare soltanto sulla neve.
I tre cammelli
In testa marcia il cammello più grande, barbuto, grave, crespo come
un negro, le lunghe ciglia costellate di lacrime di ghiaccio. Sui due
grandi sacchi di cui è carico stanno appollaiati il vecchio e Nurman; il
passo della bestia è regolare, non è quasi mai necessario stimolarla
con colpi di kamča. Questa mattina Nurman si è addormentato sul
suo trespolo ed è rotolato a terra rimanendo stordito per qualche
secondo.
Via via che procediamo i peli del Grande crescono arricciandosi
sulle cosce lunghe e legnose. Ogni giorno le tre linee orizzontali che
ne striano i garretti sono più segnate, ogni giorno vedo la sua ombra
ondeggiante che si sposta da sinistra a destra passandogli sotto il
naso. Una corda di crine fa due mezzi nodi a metà della coda
triangolare e raggiunge poi il bastone affusolato che è infilato nel
naso del mio cammello, il Bastardo. La gobba di quest'ultimo non è
troppo sporgente, dato che è un incrocio tra un cammello e un
dromedario, un ibrido fecondo, assai apprezzato dai kazaki.
Segue la giovane cammella, aggraziata, elegante, sottile; ha un
muso fiero, peli biondi, occhi neri segnati da ciglia orizzontali. Geme
e digrigna i denti lanciando rauchi richiami al suo piccolo. A ogni
passo sembra che lo invochi, che protesti per l'andatura troppo
sostenuta, che si domandi se mai lo rivedrà.
Vedo il sole passare sotto l'arco fine del suo naso, attraverso le
narici tagliate a mandorla. Nel punto villoso dove queste quasi si
congiungono si rizzano tre peli brinati, come frementi fili di lucido
argento o zampilli d'acqua stilizzati.
I giorni si succedono sonnolenti al movimento cadenzato e
monotono dei cammelli che inebetiscono la mia mente svuotandola
di ogni pensiero. Non faccio che mangiare, dormire e viaggiare con
lo sguardo fisso sulle zampe del Grande, soffici sfere che a ogni
passo si parano dinanzi a me.
Imparo a salire sul mio Bastardo alla maniera dei kazaki, senza
far accovacciare l'animale. Tirando sulla corda nasale lo si costringe
ad abbassare il collo così da posare il piede sulla nuca tutta spelata
per i continui sfregamenti e, aggrappandosi al basto, ci si issa
mentre l'animale raddrizza testa e collo. Un ultimo movimento serve
a recuperare l'equilibrio e a sistemarsi bene sul basto. Il mio primo
tentativo è stato, a dire il vero, poco felice: le ginocchia mi si sono
impigliate nella pelliccia e sono precipitata a capofitto battendo la
testa. Per il futuro, se mi sfuggirà qualche sciocchezza, avrò una
scusa più che plausibile.
Questa sera il paesaggio lungo le rive del lago d'Aral è
grandioso nella sua desolazione: cielo e ghiaccio si confondono in
un'unica, grigia distesa. Mentre sgelo la carne nella mia padella,
Nurman stacca un pezzo di ghiaccio per preparare un'immonda
bevanda salata che dovrebbe essere il nostro tè.
A nord il cielo si tinge di lilla, e quel colore dolce e raro mi
intenerisce fino allo scoramento, mi inebria di poesia: «Esistono
ancora in qualche luogo della terra quelle piccole stelle, dolci come il
miele, che hanno nome “lillà”? Avrò ancora la gioia di rivederle in
fiore, ronzanti di avide api?».
Durante la mattinata incontriamo un bambino in lacrime in
groppa a un cammello, un asino che porta una donna tutta
avviluppata in una coperta a quadri, con i piedi avvolti da stracci, e
un uomo che chiude il piccolo corteo. Egli ci segue a lungo
supplicando il vecchio di vendergli un po' di grano.
Il nostro carico viene notato anche da altri tre uomini che si
appendono al naso del Grande, determinati a farsi consegnare due
sacchi di semi che in effetti ottengono, nonostante le vivaci
rimostranze di Asmetali, al prezzo di ventidue rubli. Pare che sulla
grande pista vi sia una continua processione di gente che viene a
piedi dal nord.
Attraversiamo un ramo di lago ghiacciato, sulla cui superficie i
cammelli si muovono a disagio, scivolando spesso.
Sul versante settentrionale, già disseminato di chiazze di neve,
sporgono zolle di terra. La brina inanella di bianco gli orifizi delle
tane dei conigli. Questa sera dovremo spalare il terreno per poterci
accampare e far riposare i cammelli, che altrimenti vagherebbero
fino all'alba, essendo restii a coricarsi sulla neve.
Queste notti, che tanto mi preoccupavano, sono incantevoli. Ci
corichiamo in tondo attorno al grande fuoco; il vecchio occupa
sempre il posto migliore, quello al riparo dal fumo, e non si
sognerebbe mai di cedermelo: per lui sono soltanto una donna,
entità trascurabile.
Il legno duro del saxaul brucia sprigionando enormi fiamme
chiare e le sue braci durano a lungo. È una pianta del deserto, le cui
radici affondano nel terreno a un metro e mezzo di profondità e il cui
corto tronco raggiunge in cento anni la circonferenza della gamba di
un uomo.
Ci sediamo scalzi davanti al fuoco per scaldarci i piedi; gli
uomini si sono tolti gli stivali e le strisce di stoffa che avvolgono le
loro gambe sono tutte fumanti. Il vecchio ha calzature logore e dure
come cartone, ma è abilissimo a staccare e a sostituire ogni volta
suole e contrafforti. Nondimeno, se si alzerà il buran i piedi gli
geleranno di certo.
Prima di mangiare, i miei compagni di viaggio si levano le
pellicce e sfilano dai pantaloni arricciati le loro camicie per
esaminarne con cura il rovescio: danno la caccia a pallide bestiole
striscianti, destinate a fare una brutta fine.
Al risveglio scrolliamo la neve fresca che si è depositata su di
noi; dobbiamo aspettare l'alba per ripartire perché è scomparso un
cammello, irrintracciabile al buio. Su una duna scorgo alcune fascine
accatastate a forma di cubo: è una tomba sovrastata dal bunčuk.
Nurman si inginocchia e prega in disparte.
Abbiamo percorso soltanto metà del cammino, non riusciamo a
fare più di cinquanta chilometri al giorno. Il freddo aumenta, la brina
sui cespugli non si scioglie più e li fa apparire come enormi ciuffi di
piume di struzzo, bianchi e grigi. È impossibile difendersi dal
nevischio che trafigge il viso stringendolo in una morsa gelata e
lacerandone la pelle. Uso la mia ampia cintura di flanella a mo' di
turbante facendola salire fin sopra il naso, ma la striscia intorno al
mento si ricopre di uno strato di ghiaccio. Capisco finalmente l'utilità
dei t'mak, quei berretti con una balza di pelliccia che scende fino a
metà schiena.
Nella notte mi sembra di vedere ovunque luci di fari.
Quando il luogo scelto per fermarci è sommerso di neve, vi
scaviamo un buco e preleviamo della sabbia con cui ricoprire la
superficie del nostro accampamento. Tagliamo poi alcuni ramoscelli
che disponiamo sul terreno per farne una specie di pavimento.
Abuish pianta i treppiedi di legno sopra il fuoco e vi appende un
secchio pieno di neve. Sulle braci che mi arroventano il viso tosto
meravigliose fette di pane spalmate di grasso di pecora.
I grandi animali si inginocchiano vicino al fuoco e ci osservano
ruminando. Nell'oscurità il loro collo da uccello predatore mi evoca la
prua dei drakkar. Mi dicono che il Grande sputa e morde al tempo
degli amori.
Rinuncio a capire quale logica seguano le nostre soste.
Dormiamo di giorno e marciamo quando cala l'oscurità per evitare
eventuali aggressioni, per approfittare dell'ultima legna reperibile
lungo la via oppure perché la luce impedisce a chi percorre la
grande pista di vedere il nostro fuoco?
Ogni sera il mio cammello decide di scioperare e si ferma
bruscamente, ma il Grande continua imperterrito strappandogli il
chiodo di legno infilato nel naso. Quando glielo rimettono, il Bastardo
si lamenta piano, mentre gocce di sangue arrossano la neve.
La graziosa cammella per fortuna non ha le narici forate, porta
una sorta di museruola. Le sottili gambe a X e l'andatura
ancheggiante la fanno spesso scivolare sul fondo ghiacciato della
pista. Cade sulle ginocchia per rialzarsi subito e guardandoci con la
coda dell'occhio sembra dire preoccupata: «Vi sbagliate, non è
successo nulla di grave». Solo lei sa procedere con passo regolare,
raccogliendo al contempo la neve con il labbro inferiore.
I fuggiaschi
La pista si dipana infinita. Macchie scure in movimento ci vengono
incontro. Sono famiglie intere: neonati che piangono nelle loro culle
fissate alla groppa di un asino; allegri ragazzi carichi sino
all'inverosimile; madri curve sotto il peso di innumerevoli coperte;
bambini che strascicano a terra cappotti troppo grandi per loro;
vecchie costrette a sedersi ogni tanto per riprendere fiato.
Tutti avanzano, sorretti dalla speranza di raggiungere il sud,
dove il pane è meno caro e il clima più clemente, dove costruiscono
una città; sono indigeni sprovveduti, ignari di quanto sia ancora
lunga la strada da percorrere, che già ora non hanno più grano. Una
donna porta un pesante samovar, un'altra la corona di una jurta, una
madre ride reggendo il suo piccolo sulla schiena. Procedono a brevi
tappe; di notte si coricano sui bordi della strada raccogliendo i pochi
legni rimasti per riscaldarsi e lasciano mucchietti di cenere
semisommersi dalla neve, segni rivelatori del loro passaggio.
Gli asini morti riversi sui campi lungo la pista mostrano le loro
costole parallele e il mio Bastardo ha un sussulto di spavento a ogni
carcassa che incontriamo. Ecco tre uomini intenti a squartare un
cammello, ucciso perché s'è spezzato una zampa. I coltelli hanno
messo a nudo la spina dorsale e la radice delle due gobbe; al suolo
giace floscia l'enorme tasca del peritoneo.
Abbiamo portato con noi legna di saxaul, indispensabile ora che
ci troviamo nella steppa dove ogni traccia di vegetazione è
scomparsa.
Al tempo in cui suo padre possedeva ottocento pecore, Nurman
viveva qui. In inverno si accampava nel Kyzyl-Kum più a est dove
abbonda il saxaul quando sopraggiungeva l'estate si spostava a
occidente del lago d'Aral, nel Kara-Kum, terra di pascoli estivi in cui
l'acqua è più vicina alla superficie.
La luna scompare all'improvviso, sfera arancione inghiottita
dalla terra.
Attratto dal nostro fuoco un uomo si avvicina in compagnia del
figlio: la sporcizia ha annerito la loro pelle. Il padre racconta la sua
storia: «Ho lasciato il kolchoz 6 ad Aktjubinsk perché ho intenzione
di andare a Čimbaj. Benché abbia cinque figli da nutrire, non mi
sono stati pagati i settanta rubli del mio salario mensile. Mi è stato
detto che mancavano soldi e viveri e che dunque potevo andare a
cercare lavoro altrove».
«In tal caso devi avere con te una carta che attesti la tua libertà
di andartene».
Sebbene affermi di possederla, non ha evidentemente nulla da
mostrare. Al pari di tanti altri egli deve partire, è nomade nell'animo.
Come Nurman, che ha rinunciato alla propria ricchezza, il nostro
ospite occasionale preferisce nutrirsi di sorgo tutta la vita, non
vedere più né zucchero né carne pur di non avere un padrone.
Prima dell'alba terra e cielo sono di un identico, livido nero. Poi,
scure tonalità vellutate ricoprono il suolo mentre l'aria sembra
inchiostro diluito. All'orizzonte il grigio vira al mogano intenso per
mutarsi ancora nel colore di una caramella di lampone. Infine tutto si
accende di arancione: è giorno.
Mi distendo sui sacchi del carico per riposare la schiena e
proprio sopra di me una nuvola ripete quella medesima successione
di tinte.
Il freddo non è mai stato così impietoso, gli occhi mi lacrimano,
le gocce al naso si gelano togliendomi il respiro. Siamo
probabilmente a 25 gradi sotto zero.
La criniera del Bastardo è bianca come i filamenti dei vecchi
abeti: le ciglia e i peli della fronte e del naso formano mazzetti di fiori
di brina. Lo sterno sostiene il suo cuore di ghiaccio; il cammello
inginocchiato riposa sulla sua cassa toracica che poggia su un
enorme callo ovale.
Nurman canticchia di continuo per non addormentarsi. Questa
mattina, vedendomi mangiare del pane, mi ha domandato come si
fa.
Il corteo degli emigranti è ininterrotto.
Non lontano da Kazalinsk raggiungiamo una fila di cammelli
quasi sommersi dal loro carico di canne.
Appare una casa isolata. Nurman lascia la grande strada per
dirigere la nostra piccola carovana verso quella fattoria dove abita
suo cugino con molta altra gente.
I miei compagni kazaki vorrebbero fermarsi qui. Chiacchierano
tutti insieme, instancabili, come se volessero rifarsi degli interminabili
giorni di silenzio. Il paesaggio è splendido, ma ormai la mia ansia di
bellezza è appagata: ora desidero buoni pasti consumati al caldo,
lontano da qui. Vorrei tuttavia che mi fosse concesso di saltare a piè
pari i giorni amari che hanno nome “ritorno”.
Oggi uno dei nostri cammelli si è rotto una zampa attraversando
il Syr Darja che ci separa da Kazalinsk. Pretendo di essere
comunque condotta in città e, dato che il cugino di Nurman si rifiuta
di prestarmi il suo asino, mi isso di nuovo sulla cammella.
Invero, capisco bene il comportamento dei miei kazaki: essi
preferiscono non farsi notare troppo in città, dove venderanno a
sessanta rubli la libbra il grano acquistato a venti a Tahtakupyr. Non
sono certa che essi abbiano regolare licenza per praticare questo
commercio privato.
Finalmente si parano dinanzi a me gli alti pioppi di Kazalinsk:
ora non ci saranno più imprevisti, il vero viaggio si conclude qui.
Salève, novembre 1933